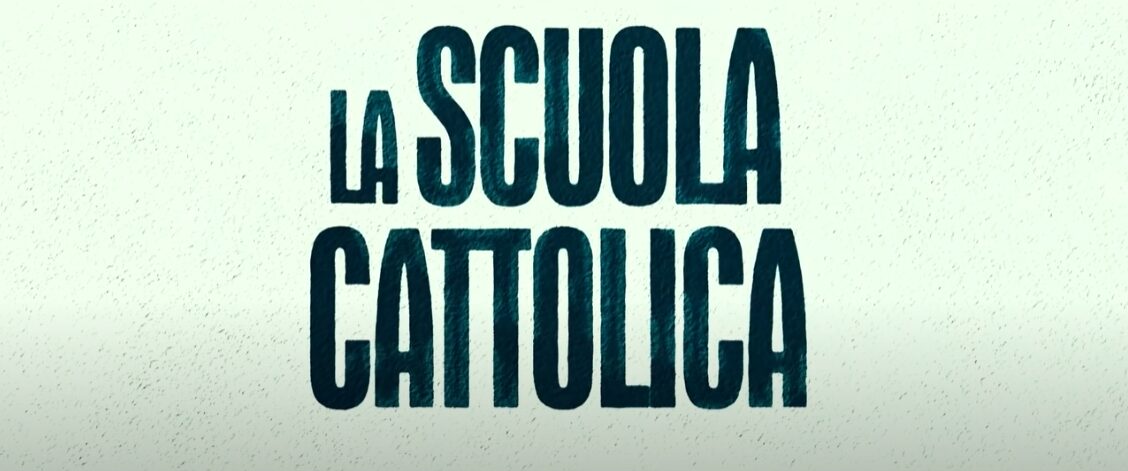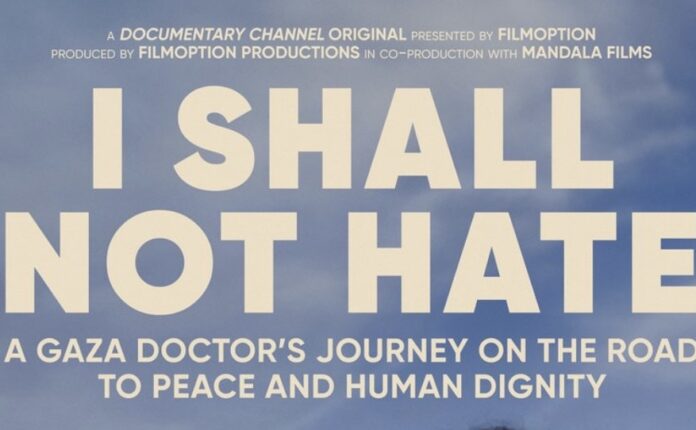La scuola cattolica e il massacro del Circeo, analisi
Il 29 settembre 1975 ha segnato una data indelebile nella cronaca italiana: Rosaria Lopez, 19 anni, e Donatella Colasanti, 17 anni, entrambe provenienti dal quartiere popolare della Montagnola a Roma, accettarono l’invito di Angelo Izzo e Gianni Guido, giovani della “Roma bene” residenti ai Parioli, per una festa che non avrebbe mai avuto luogo. Portate in una villa a San Felice Circeo, di proprietà di Andrea Ghira che si unì al gruppo, le due ragazze subirono minacce, botte e stupri protrattisi fino alla sera del giorno successivo, culminando nell’uccisione di Rosaria Lopez e nel disperato tentativo di salvezza di Donatella Colasanti, che si finse morta. Donatella, che per tutta la vita avrebbe lottato per verità e giustizia, denunciò come quei ragazzi benestanti e di buona famiglia, arroganti e beffardi, fossero aderenti a gruppi neofascisti e avessero pianificato un vero e proprio massacro. Questo evento agì come un vero e proprio detonatore nell’Italia degli anni Settanta, già attraversata dalla seconda ondata del femminismo, portando la violenza sessuale a irrompere nello spazio pubblico con una forza inedita, grazie alla mobilitazione di migliaia di donne.
La sceneggiatura di La scuola cattolica, firmata da Massimo Gaudioso, Luca Infascelli e lo stesso Stefano Mordini, cerca di esplorare l’ambiente delle scuole cattoliche private per soli maschi nella Roma bene, luoghi intesi come privilegiati incubatori della classe dirigente, ma che nei fatti si rivelano “serre per il seme della violenza” e di una “mala educación” arci-italiana. Mordini pone sul banco degli imputati tanto i padri biologici, ritratti come grandi assenti, quanto i padri-educatori, i docenti religiosi, evidenziando una mancanza di educazione sentimentale che riduceva le ragazze a carne. Nonostante una messa in scena accurata e un ottimo cast di giovani attori, inclusi Benedetta Porcaroli nel ruolo di Donatella Colasanti e Luca Vergoni come un somigliantissimo Angelo Izzo, oltre a volti noti come Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Valeria Golino e Fabrizio Gifuni, il film ha ricevuto significative critiche. Tra le principali debolezze riscontrate vi sono una discontinuità tra una lunga anticamera della tragedia e il frettoloso passaggio chiave finale, un eccessivo numero di personaggi che impedisce una caratterizzazione profonda e riduce l’empatia dello spettatore, e un finale che risulta affrettato, ingiustificato, immotivato. Si lamenta inoltre la mancanza di una chiara cornice politica e sociale degli anni Settanta, con l’accusa che il movente fascista sia reso “labilissimo se non eluso”, il ruolo delle droghe “sparite” e la Chiesa affrontata in modo superficiale. La scuola cattolica è stata definita “modesta nelle ambizioni, timida nell’ideologia”, a cui manca lo sguardo e la trasfigurazione artistica. In tutto questo, la Commissione Nazionale Valutazione Film ha comunque riconosciuto l’opera come complessa, problematica e adatta per dibattiti sebbene il film sia uscito con il divieto ai minori di 18 anni, una decisione che, ironicamente, è stata vista come una conferma del “pericolo della censura” e della rimozione degli istinti che il film stesso intendeva esplorare. L’eco del massacro del Circeo non si spense con le aule dei tribunali; al contrario, generò una profonda e duratura reazione sociale. Nel 1978 la raccolta di saggi Lessico politico delle donne, curata dalla psicanalista Manuela Fraire, si propone come un manuale di diritto accessibile e applicabile a situazioni pratiche, nata dall’idea del 1974 come reazione critica a un sistema giuridico che promuove il mantenimento dell’ordine patriarcale. Tra i contributi, l’avvocata Remiddi analizza la violenza sessuale, spiegandone la definizione giuridica e illustrando come una donna potrebbe comportarsi in caso di violenza, mostrando un’influenza esplicita delle teorie femministe statunitensi. Diventano emblematici e spartiacque gli eventi del caso Circeo, la cui ricezione e dibattito sono dominati da una chiave di lettura politica: l’estrazione sociale dei ragazzi e il loro orientamento neofascista.
La critica femminista dopo il Massacro
La critica femminista sottolinea però come queste interpretazioni siano parziali e pericolose, perché rafforzano l’idea che la violenza maschile sulle donne sia un fenomeno eccezionale ed episodico, sia essa legata a contesti di marginalità e povertà sia a una borghesia violenta e neofascista. Nel 1976, a Roma, in piazza Navona, un sit-in femminista definisce la violenza contro le donne un crimine politico, sottolineando come ogni violenza maschile su donna sia radicata in una cultura e una politica che la giustificano e la consentono. Le polemiche si estendono anche al tema della pornografia e della censura, con una volontà di reazione alla violenza e di sperimentazione di nuove forme di espressione. Sempre a Roma nel 1976 vengono aperti i primi centri antiviolenza, mentre l’organizzazione di un corteo fino al tribunale durante il processo per gli omicidi del Circeo scandisce slogan forti come “Per Rosaria non basta il lutto”. “Pagherete caro, pagherete tutto” e “Guido, Ghira, Izzo non sono pazzi, sono strumenti patriarcali”. L’ingresso in aula di Angelo Izzo, uno dei tre imputati fascisti, provoca un silenzio di gelo e pertanto la presenza femminile e femminista nello spazio giuridico è fortemente osteggiata, con avvocati di destra in difesa e di sinistra in accusa, contribuendo a politicizzare il processo. La sentenza, con due ergastoli e un trentennio di carcere, condanna i colpevoli definiti “rifiuti del genere umano” “In nome della cultura, di tutte le donne e dei cittadini di tutte le classi”, ma il focus resta sull’eccezionalità e mostruosità dei colpevoli piuttosto che sulla responsabilità sociale strutturale di questo tipo di violenza. Il processo, apertosi il 30 giugno 1976 davanti alla Corte d’Assise di Latina con Angelo Izzo, Gianni Guido e il latitante Andrea Ghira come imputati, vide la presenza in aula di Tina Lagostena Bassi, avvocata di Donatella Colasanti e figura di spicco del femminismo italiano. Nonostante i tentativi della difesa di infangare le vittime, l’aula era stracolma di donne che sentivano di essere anche loro vittime in quanto donne: questo è un processo sulla condizione femminile in una società tutta per l’uomo.
La strategia del movimento femminista si sviluppò per trasformare le udienze in denunce pubbliche, facendo delle aule dei tribunali casse di risonanza di un messaggio centrale: la violenza sessuale è una questione strutturale di dominio e prevaricazione maschile che riguarda tutti. Sempre su questa scia di ribellione, Processo per stupro emanato dalla Rai nel 1979 denunciò l’adesione delle istituzioni, come forze dell’ordine e magistratura, alla logica patriarcale degli imputati. La rinnovata attenzione alla violenza maschile portò nel 1976 all’apertura dei primi Centri antiviolenza ad opera del Movimento di Liberazione della Donna (Mld) a Roma, Milano, Torino e altre città. Questi luoghi, che offrivano assistenza legale e psicologica, rivelarono come la violenza più diffusa fosse quella quotidiana, attraversasse tutti gli strati sociali e i colori politici e si scontrasse con la reticenza delle forze dell’ordine e un Codice penale inadeguato. Un passaggio fondamentale nella legislazione si concretizzò con la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare nel settembre 1979, elaborata dall’Mld, dall’Udi e da diversi collettivi romani: grazie a questo percorso, dal 1996 la violenza sessuale è stata finalmente identificata come un crimine contro la persona e non più contro la morale, e dal 2001 sono state previste misure cautelari come gli ordini di protezione e allontanamento dalla casa familiare. Come riportato nella rivista il Mulino “un passaggio fondamentale è avvenuto: il patriarcato è rotto”. Oggi, ogni donna ha la possibilità di scegliere come affrontare la violenza e di dare ai fatti la giusta misura, senza dare a nessuno il pretesto di credersi Dio. Il massacro del Circeo è stato un evento spartiacque che ha costretto l’Italia a confrontarsi con la brutalità della violenza di genere e le sue radici profonde e La scuola cattolica pur con le sue imperfezioni e le critiche ricevute, rappresenta un tentativo significativo di rileggere questa tragedia cinquant’anni dopo. La scuola cattolica e Mordini cercano di proporre a noi spettatori di esplorare quella “genesi del Male” che è presente non solo negli individui, ma anche nelle istituzioni e nei contesti sociali che possono fungere da incubatori di una certa violenza maschile.