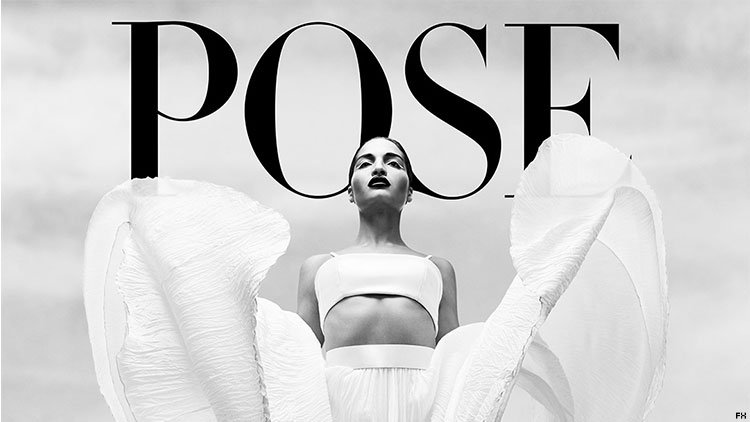Technicolor è il nome che raggruppa tutti quei procedimenti utilizzati nell’ambito del cinema a colori, una rivoluzione che ha trasformato la settima arte dopo il passaggio dal cinema muto al sonoro. Il nome deriva dall’omonima azienda, la Technicolor Motion Picture Corporation, fondata nel 1914 da Herbert Kalmus, Daniel Frost Comstock e W. Burton Wescott.
Quali sono le fasi evolutive del Technicolor?
| Processo | Anno | Innovazione principale |
|---|---|---|
| Process 1 | 1917 | Sintesi additiva con prisma a due fasci (rosso e verde). |
| Process 2 | 1922 | Sintesi sottrattiva: due pellicole incollate dorso contro dorso. |
| Process 3 | 1928 | Introduzione della stampa dye-transfer (trasferimento coloranti). |
| Process 4 | 1932 | Celebre sistema three-strip a tre colori primari. |
| Process 5 | 1954 | Utilizzo della pellicola monopack con stampa dye-transfer. |
| Process 6 | 1997 | Versione economica del dye-transfer per restauri e nuovi film. |
Indice dei contenuti
I primi tentativi di colorazione e il Technicolor process 1
Fin dalla nascita del cinema si cercò di inserire il colore nella pellicola. I metodi iniziali erano il viraggio (immersione in un’unica tinta) o la colorazione manuale, tecniche esplorate anche nel periodo del precinema. Un primo procedimento fu il Kinemacolor (1908), che usava filtri rossi e verdi in proiezione per creare l’illusione del colore. Il primo film girato con questo formato fu A Visit to the Seaside (1908).
Nel 1917, la Technicolor Motion Picture Corporation introdusse il Technicolor process 1. La tecnica, basata sulla sintesi additiva, consisteva nel riprendere su una pellicola in bianco e nero attraverso un prisma che divideva la luce in due fasci, filtrati in rosso e verde. I due negativi venivano poi proiettati simultaneamente con filtri corrispondenti, ma il sistema richiedeva una calibrazione costante per evitare immagini fuori sincrono. Fatta eccezione per il film di debutto, The Gulf Between (1917), il process 1 non fu più utilizzato.
Il process 2: il primo sistema sottrattivo
Nel 1922 fu introdotto il Technicolor process 2, il primo basato sulla sintesi sottrattiva. Dai negativi di selezione rosso e verde si ottenevano due positivi sottili che venivano colorati chimicamente (uno in rosso-arancio, l’altro in blu-verde) e poi incollati dorso contro dorso. Questo creava una singola striscia di pellicola proiettabile con proiettori standard. Il metodo presentava però dei limiti: la pellicola incollata tendeva a deformarsi (“cupping”) e a graffiarsi. Nonostante ciò, fu usato in film come Fior di Loto (1927). Questo approccio contrastava con le atmosfere cupe e distorte dell’espressionismo tedesco, che preferiva il bianco e nero per accentuare le ombre.
Il process 3: la rivoluzione del dye-transfer
Il Technicolor process 3 (1928) risolse i problemi del precedente. La novità fu la tecnica del dye-transfer (“trasferimento di coloranti”). Invece di incollare due pellicole, si creavano delle matrici in gelatina per ogni colore. Queste matrici venivano imbevute nei rispettivi coloranti (ciano e magenta) e poi stampate per contatto, una dopo l’altra, su un’unica pellicola vergine. Questo metodo garantiva colori stabili e una pellicola di spessore standard. Il primo film a usare questa tecnica fu I Vichinghi (1928), ma la Grande Depressione ne limitò l’uso. L’ultimo fu La maschera di cera (1933).
Il process 4: l’apice del three-strip
La vera rivoluzione arrivò nel 1932 con il three-strip Technicolor, o process 4. Una nuova, ingombrante cinepresa esponeva simultaneamente tre pellicole in bianco e nero attraverso un prisma. Una pellicola registrava il verde, mentre le altre due, in un bipack, registravano il blu e il rosso. Da questi tre negativi si creavano tre matrici per il dye-transfer con i colori complementari: ciano, magenta e giallo. La combinazione dei tre colori permetteva di riprodurre per la prima volta l’intero spettro cromatico con una saturazione e una brillantezza senza precedenti, come spiegato da fonti autorevoli come la voce dedicata su Wikipedia.
Il Technicolor nel cinema d’animazione e nei film live-action
A causa dei costi, il primo settore a impiegare massicciamente il three-strip fu l’animazione. Walt Disney firmò un’esclusiva e lo usò per le sue Silly Symphonies, come Flowers and Trees (1932), primo corto a vincere un Oscar. Il successo planetario di Biancaneve e i sette nani (1937), primo lungometraggio animato, decretò il trionfo del Technicolor. Nel cinema live-action, l’espressione massima delle sue potenzialità si ebbe con Il Mago di Oz (1939) e la celebre sequenza in cui Dorothy passa dal Kansas in bianco e nero al mondo colorato di Oz, una potente metafora del passaggio tecnologico.
Il process 5: la pellicola monopack
Dagli anni ’40, la concorrenza di pellicole a colori più pratiche come il Kodachrome si fece sentire. La Technicolor si adattò con il Technicolor process 5 (usato dal 1954), detto monopack. La ripresa avveniva su un unico negativo a colori, ma il processo di stampa utilizzava ancora il collaudato sistema del dye-transfer per creare le copie da proiezione. Questo garantiva la stabilità e la vividezza dei colori tipiche del Technicolor. Questo splendore cromatico arrivò mentre in Europa si affermavano stili più crudi e realistici come il cinema neorealista italiano. Molti film usarono questo sistema, tra cui Suspiria di Dario Argento (1977).
Il process 6 e l’era digitale
L’ultimo processo, il process 6, fu introdotto nel 1997. Era una versione perfezionata e più economica del dye-transfer, usata principalmente per il restauro di classici come Via col Vento e Apocalypse Now Redux, e per nuovi film come Pearl Harbor (2001). Tuttavia, il suo successo fu breve. La pellicola stessa stava per essere soppiantata dall’avvento del cinema digitale. Mentre registi della Nouvelle Vague francese come Jean-Luc Godard avevano sperimentato con i limiti della pellicola, l’era digitale ha riscritto le regole. Oggi, il marchio Technicolor sopravvive come una delle più grandi aziende di post-produzione, ma il processo chimico che ha reso iconici i suoi colori appartiene alla storia.
Ciro Gianluigi Barbato
Fonte immagine copertina: videoblocks.com
Articolo aggiornato il: 05/02/2026