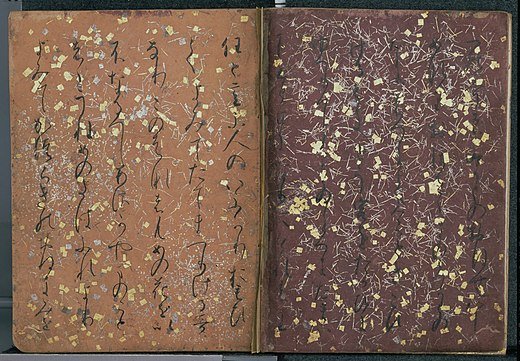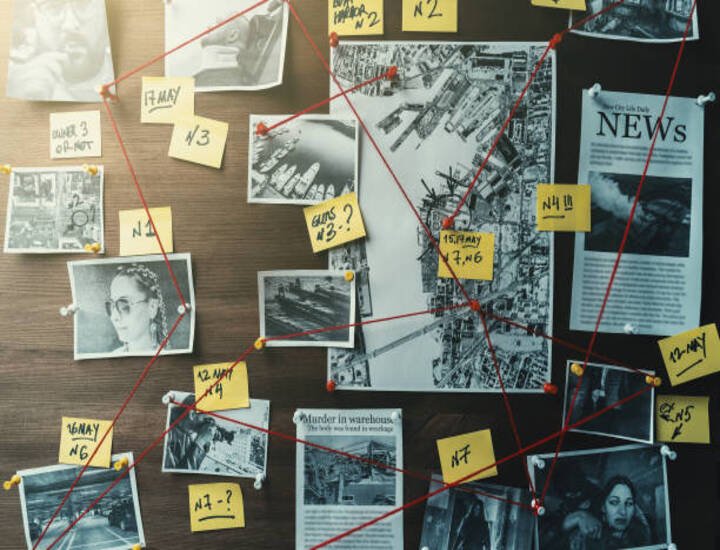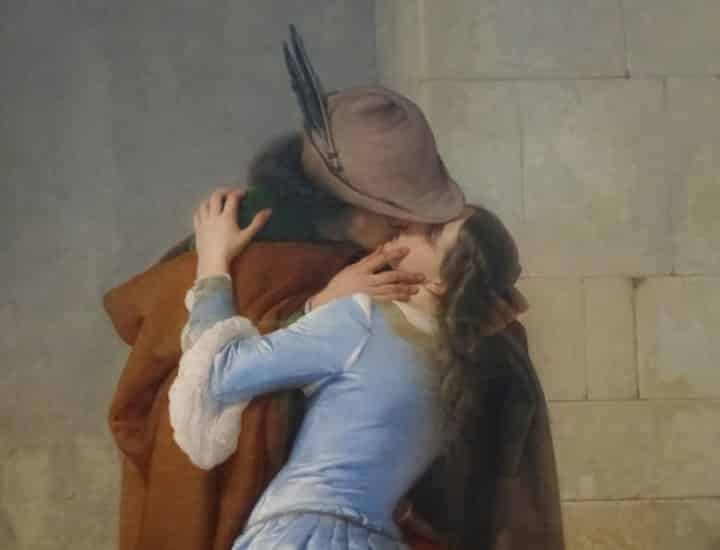Il castigliano, generalmente conosciuto come spagnolo, è una delle lingue più parlate al mondo: lo parlano più di 584 milioni di persone! È la seconda lingua parlata al mondo e la lingua ufficiale di 21 paesi. Ma in America Latina, in particolar modo in Argentina, il tipo di spagnolo parlato è ben diverso dal primo tipo: si chiama rioplatense ed è una varietà parlata principalmente in Río de la Plata, confine marittimo tra Argentina e Uruguay.
Indice dei contenuti
Quali sono le differenze linguistiche tra Spagna e Argentina?
| Aspetto linguistico | Spagnolo Castigliano (Spagna) | Spagnolo Rioplatense (Argentina) |
|---|---|---|
| Pronuncia C/Z | Interdentale (lingua tra i denti) | Suono “S” (Seseo) |
| Pronuncia LL/Y | Suono “GL” o “I” | Suono “SC” (Yeismo rehilado) |
| 2ª persona singolare | Tú | Vos |
| 2ª persona plurale | Vosotros | Ustedes |
Ecco una lista di 5 differenze tra lo spagnolo europeo e latino
1. La pronuncia
Nello spagnolo europeo la pronuncia della “z”+ vocale e della “c” + e/i sono pronunciate con una interdentale (quindi con la lingua in mezzo ai denti). Mentre in Argentina il suono interdentale non c’è. Sempre legato alla pronuncia, c’è la differenza della doppia “-ll” e della lettera “y”: in spagnolo di Spagna sono pronunciate come vocali (nel primo caso suono “-gl”, nel secondo caso suono “i”), invece nella varietà latina sono pronunciate con il suono di “-ch” di chanter in francese. Questo fenomeno è chiamato yeismo.
2. Il “voseo”
In castigliano la seconda persona singolare è il “tu”. Mentre in rioplatense la seconda persona singolare è rappresentata dal pronome “vos” utilizzato però informalmente, quindi, tra amici o familiari. Mentre per le situazioni formali è usato “usted” comunemente il “lei”.
3. “Ustedeo” plurale
In spagnolo di Spagna la seconda persona plurale è “vosotros” ovvero voi. In spagnolo dell’Argentina invece non viene usato vosotros, bensì “ustedes” che viene coniugato come la terza persona plurale (quindi con ellos/ellas).
4. Il vocabolario
Nonostante condividano buona parte di lessico, queste due varietà hanno differenze nel vocabolario. Ad esempio, il rioplatense possiede un gergo conosciuto come “lunfrado” usato anche nei film argentini: per esempio le parole “pibe/piba” ne fanno parte. Per quanto riguarda l’altra varietà invece ha -come tutte le lingue- delle proprie espressioni dialettali come per esempio “me importa un pepino” che significa “non mi importa nulla”. Altre parole diverse sono per esempio:
- “piscina” in castigliano e “pileta” in spagnolo latino;
- “coche” in spagnolo di Spagna e “auto” in argentino.
Se siete interessati nell’ampliare il lessico nella varietà argentina, è molto utile vedere serie tv, telenovelas in lingua originale: si fonde l’utile e il dilettevole!
5. Intonazione
L’intonazione è una delle differenze più evidenti i due idiomi: infatti nel caso del rioplatense l’accento è stato influenzato anche dalla presenza dell’italiano. Con quest’ultimo lo spagnolo latino condivide l’intonazione più melodica rispetto a quello europeo. Invece, nel caso di quest’ultimo viene posta un’enfasi maggiori sulle consonanti: per esempio la “s” finale viene pronunciata, a differenza dell’altra varietà che tende ad aspirarla.
Per concludere, spagnolo europeo e latino presentano delle distinzioni che, però, arricchiscono l’identità linguistica. Sono entrambe due varietà meravigliose dello spagnolo che presentano elementi interessanti.
Fonte immagine: Pixabay
Articolo aggiornato il: 1 Gennaio 2026
>