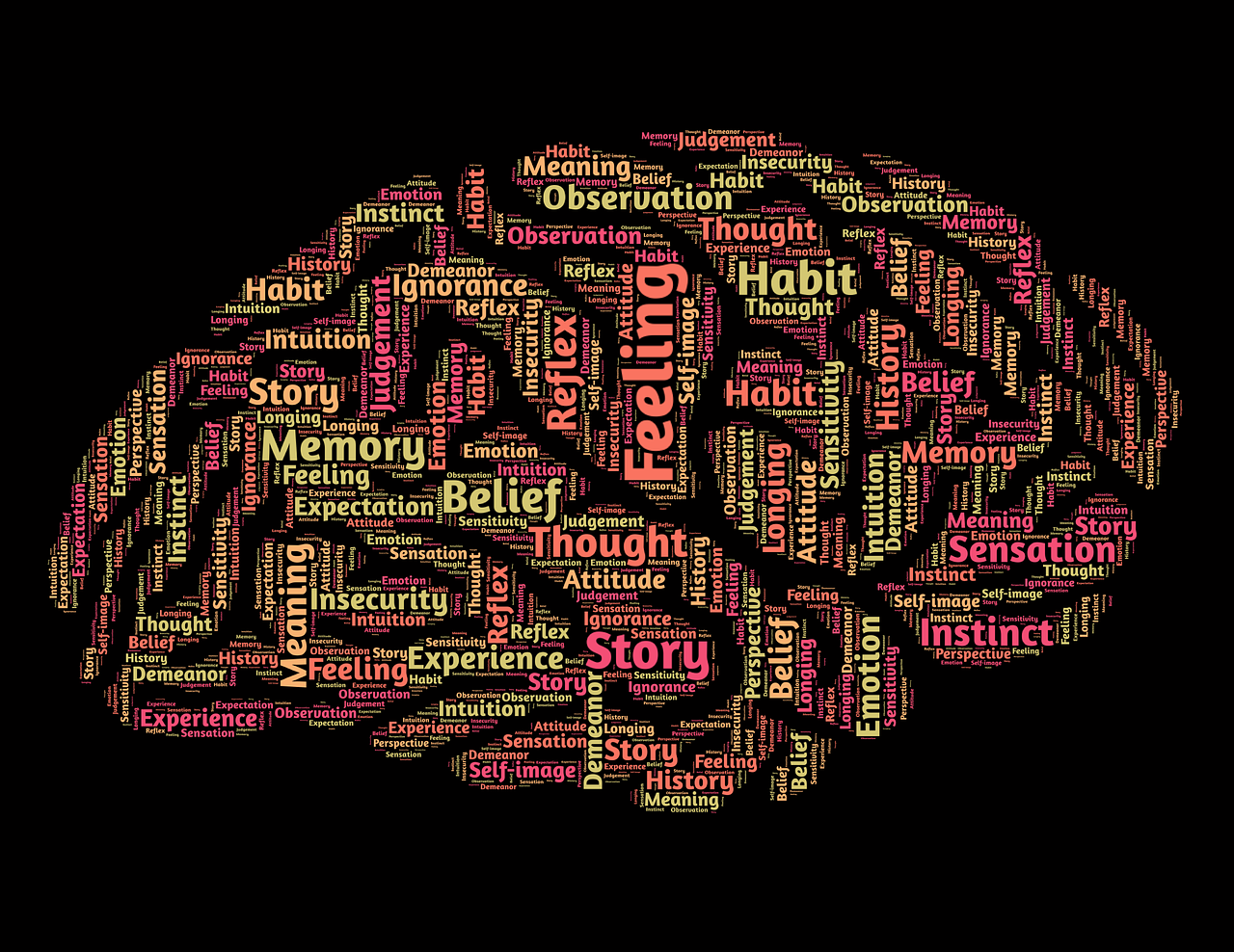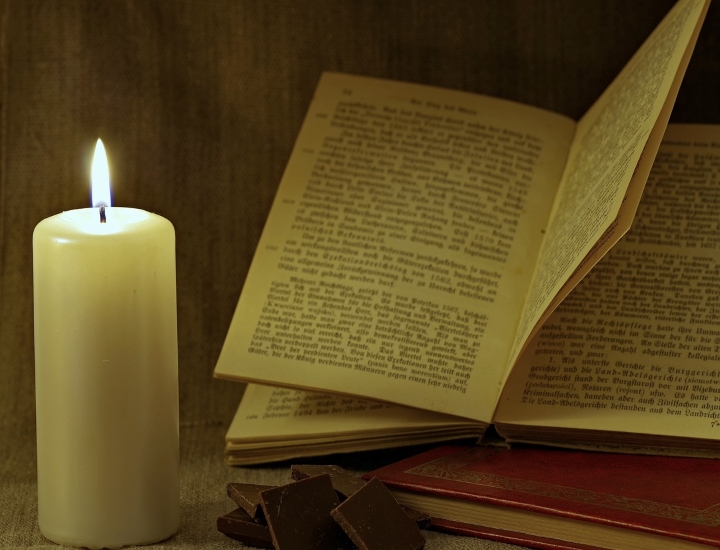Ogni anno, il 27 gennaio, si celebra la Giornata della Memoria, dedicata al ricordo delle vittime dell’Olocausto. Questa data ha un significato preciso: in questo giorno del 1945, le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, svelando al mondo l’orrore indicibile che vi si era consumato. Ricordare è un dovere morale e civile, affinché la barbarie non prevalga mai più.
A mantenere viva la memoria non sono solo i film e i saggi, ma anche la letteratura e la poesia. Attraverso i versi, autori che hanno vissuto l’orrore o che ne hanno colto la tragica essenza ci consegnano parole potenti. Leggiamo insieme alcune poesie sulla Shoah, per non dimenticare.
Indice dei contenuti
| Autore | Tema centrale e prospettiva |
|---|---|
| Primo Levi | L’annientamento della dignità umana e il dovere morale della testimonianza. |
| Joyce Lussu | L’orrore dell’infanzia negata e sterminata, attraverso un oggetto simbolo. |
| Pavel Friedman | La perdita della libertà e della bellezza naturale, viste con gli occhi di un prigioniero del ghetto. |
| Salvatore Quasimodo | La desolazione del paesaggio di Auschwitz e la riflessione sulla memoria come reliquia. |
1. Se questo è un uomo, Primo Levi
Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango
che non conosce pace
che lotta per mezzo pane
che muore per un si o per un no.
Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare
vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
stando in casa andando per via,
coricandovi, alzandovi.
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.
Questa poesia, posta in apertura del suo omonimo capolavoro, è il manifesto della testimonianza di Primo Levi. Non è una supplica, ma un comando morale. Levi, sopravvissuto ad Auschwitz, ci impone di considerare la disumanizzazione del lager, dove uomini e donne vengono privati di tutto, persino del nome. L’autore, come spiegato dal Centro Internazionale di Studi Primo Levi, sentì il dovere di raccontare. A lui dobbiamo il monito costante a ricordare, perché “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario“. La maledizione finale non è un atto di vendetta, ma un avvertimento terribile su cosa accade a una civiltà che sceglie di dimenticare.
2. Un paio di scarpette rosse, Joyce Lussu
C’è un paio di scarpette rosse
numero ventiquattro
quasi nuove:
sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica
“Schulze Monaco”.
C’è un paio di scarpette rosse
in cima a un mucchio di scarpette infantili
a Buchenwald
erano di un bambino di tre anni e mezzo
chi sa di che colore erano gli occhi
bruciati nei forni
ma il suo pianto lo possiamo immaginare
si sa come piangono i bambini
anche i suoi piedini li possiamo immaginare
scarpa numero ventiquattro
per l’ eternità
perché i piedini dei bambini morti non crescono.
C’è un paio di scarpette rosse
a Buchenwald
quasi nuove
perché i piedini dei bambini morti
non consumano le suole.
La scrittrice e partigiana Joyce Lussu affronta uno degli aspetti più inaccettabili della Shoah: lo sterminio sistematico dei bambini. La poesia si concentra su un oggetto concreto, un paio di scarpette rosse, per evocare l’assenza e l’orrore. Il dettaglio del numero, della marca, rende la vittima reale e vicina. Le scarpette “quasi nuove” diventano il simbolo straziante di una vita interrotta prima ancora di iniziare a correre. È un testo che, nella sua semplicità, trasmette l’enormità di un crimine contro il futuro stesso dell’umanità.
3. La farfalla, Pavel Friedman
L’ultima, proprio l’ultima,
di un giallo così intenso, così
assolutamente giallo,
come una lacrima di sole quando cade
sopra una roccia bianca
così gialla, così gialla!
L’ultima
volava in alto leggera,
aleggiava sicura
per baciare il suo ultimo mondo.
Tra qualche giorno
sarà già la mia settima settimana
di ghetto: i miei mi hanno ritrovato qui
e qui mi chiamano i fiori di ruta
e il bianco candeliere del castagno
nel cortile.
Ma qui non ho visto nessuna farfalla.
Quella dell’altra volta fu l’ultima:
le farfalle non vivono nel ghetto.
Scritta dal giovane poeta ceco Pavel Friedman nel ghetto di Terezín, prima di essere deportato ad Auschwitz, dove morì, questa poesia usa la farfalla come simbolo della libertà e della bellezza perdute. Il giallo intenso e vitale dell’insetto contrasta con la cupa realtà del ghetto, un luogo dove la natura stessa sembra non poter esistere. La frase finale, “le farfalle non vivono nel ghetto“, è una constatazione lapidaria che racchiude tutta la tragedia della reclusione e della negazione della vita.
4. Auschwitz, Francesco Guccini
Son morto ch’ero bambino
son morto con altri cento
passato per il camino
e adesso sono nel vento.
Ad Auschwitz c’era la neve
il fumo saliva lento
nel freddo giorno d’inverno
e adesso sono nel vento.
…
Io chiedo come può l’uomo
uccidere un suo fratello
eppure siamo a milioni
in polvere qui nel vento.
…
Io chiedo quando sarà
che l’uomo potrà imparare
a vivere senza ammazzare
e il vento si poserà.
Anche la musica si fa poesia per la memoria. Francesco Guccini, in questa celebre canzone, dà voce a uno degli innumerevoli bambini uccisi ad Auschwitz. Il bambino, ormai “polvere nel vento“, si fa portavoce di una domanda universale e senza tempo: come può l’uomo compiere un tale orrore? La canzone, nella sua melodia malinconica, diventa un inno alla pace e una condanna della violenza, chiedendosi quando la “bestia umana” smetterà di spargere sangue e il vento carico di cenere potrà finalmente posarsi.
Altre poesie per la memoria
Oltre a queste, molte altre voci hanno raccontato l’orrore. Salvatore Quasimodo, in “Auschwitz”, descrive il campo come un “inferno aperto da una scritta bianca”, mentre Barbara Sonek in “Olocausto” dà voce corale ai bambini uccisi, il cui appello risuona dalle ceneri. Anche Izet Sarajlić, con “Il proprietario delle scarpe n. 43”, riflette sulla colpa del sopravvissuto di fronte a un paio di sandali di bambino esposti nel museo di Auschwitz. Ogni verso è un frammento di memoria, una tessera necessaria per ricostruire un quadro che non dobbiamo mai smettere di guardare.
Fonte immagine per l’articolo sulle poesie sulla Shoah: Pixabay
Articolo aggiornato il: 05/09/2025