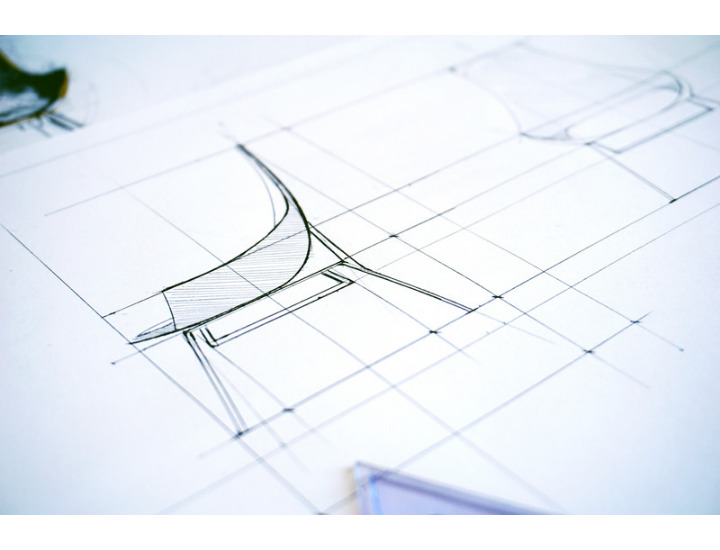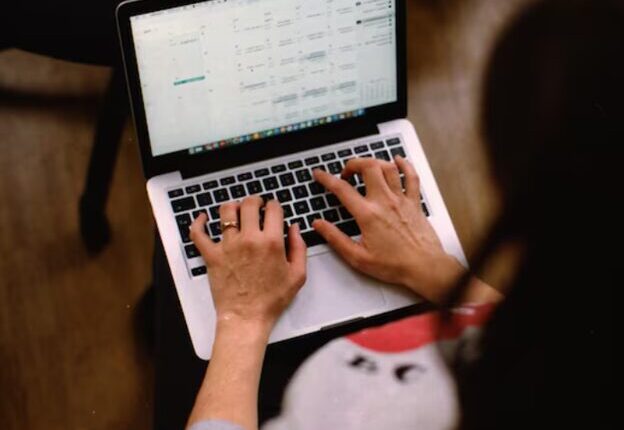L’economia keynesiana è una teoria macroeconomica sviluppata dall’economista britannico John Maynard Keynes, in particolare nella sua opera fondamentale “Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta” (1936). Questa scuola di pensiero si basa su una critica all’economia classica, la quale sosteneva la capacità del mercato di autoregolarsi e tornare spontaneamente a un equilibrio di piena occupazione. La Grande Depressione degli anni ’30 mise in crisi questo paradigma, spianando la strada alle teorie di Keynes.
Indice dei contenuti
I principi fondamentali dell’economia keynesiana
Il cuore del pensiero keynesiano è l’importanza della domanda aggregata, ovvero la spesa totale per beni e servizi in un’economia. Secondo Keynes, in periodi di crisi, la domanda aggregata è insufficiente a garantire la piena occupazione. Per questo, il concetto chiave diventa l’intervento statale attraverso la spesa in deficit (o deficit spending). Lo Stato, indebitandosi, finanzia grandi investimenti pubblici (infrastrutture, servizi) con due scopi principali:
- Ridurre la disoccupazione: assumendo direttamente lavoratori per le opere pubbliche.
- Stimolare la produzione: creando domanda per le industrie private (es. siderurgia, edilizia).
Questo meccanismo innesca il cosiddetto moltiplicatore keynesiano: ogni euro speso dallo Stato genera un aumento più che proporzionale del reddito nazionale, poiché i nuovi salariati spenderanno a loro volta, rimettendo in moto l’intero ciclo economico. Il debito creato dovrebbe poi essere ripagato con le maggiori entrate fiscali generate dalla ripresa economica.
La critica all’economia classica: il fallimento dell’autoregolazione
L’economia classica prevedeva che, in una crisi, i salari si sarebbero abbassati fino a quando le imprese non avessero trovato conveniente assumere di nuovo, riportando il sistema alla piena occupazione. Keynes definì questa visione irrealistica, introducendo il concetto di rigidità dei salari: nella pratica, i lavoratori e i sindacati si oppongono a drastiche riduzioni salariali. Di conseguenza, l’economia può rimanere bloccata in un “equilibrio di sottoccupazione” per un lungo periodo. La Grande Depressione fu l’esempio lampante di questa stagnazione.
| Principio economico | Confronto tra modelli |
|---|---|
| Ruolo dello stato | Classica: Minimo (“laissez-faire”). Il mercato si autoregola. Keynesiana: Fondamentale per sostenere la domanda e correggere gli squilibri. |
| Equilibrio economico | Classica: Tende naturalmente alla piena occupazione. Keynesiana: Può esistere un equilibrio stabile di sottoccupazione. |
| Flessibilità dei salari | Classica: I salari sono flessibili e si adattano per eliminare la disoccupazione. Keynesiana: I salari sono “rigidi” verso il basso, la disoccupazione può persistere. |
L’applicazione storica: il new deal di Roosevelt
Dopo il crollo di Wall Street del 1929, gli Stati Uniti si risollevarono grazie al New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt. Sebbene non fosse un’applicazione “pura” delle teorie di Keynes (che vennero formalizzate solo più tardi), il New Deal ne incarnava lo spirito. Furono avviati vasti programmi di lavori pubblici (strade, dighe, ponti) tramite agenzie come i Civilian Conservation Corps. Vennero approvate leggi di regolamentazione economica e bancaria, come l’Emergency Banking Act e il National Industrial Recovery Act. Queste misure, come documentato da archivi storici governativi (fonte: FDR Presidential Library), rappresentarono un massiccio intervento statale per rilanciare l’economia e l’occupazione.
Limiti e critiche al modello keynesiano
L’economia keynesiana ha dominato il pensiero economico fino agli anni ’70, quando il fenomeno della stagflazione (alta inflazione e alta disoccupazione simultanee) mise in crisi il modello. I critici, in particolare la scuola monetarista guidata da Milton Friedman, sostenevano che l’intervento statale continuo e la spesa in deficit potessero generare inflazione e distorcere il mercato, senza risolvere i problemi strutturali. Le principali critiche si concentrano sul rischio di un debito pubblico insostenibile e sulla difficoltà per i governi di ridurre la spesa una volta superata la crisi.
Fonte immagine: Pixabay
Articolo aggiornato il: 02/10/2025