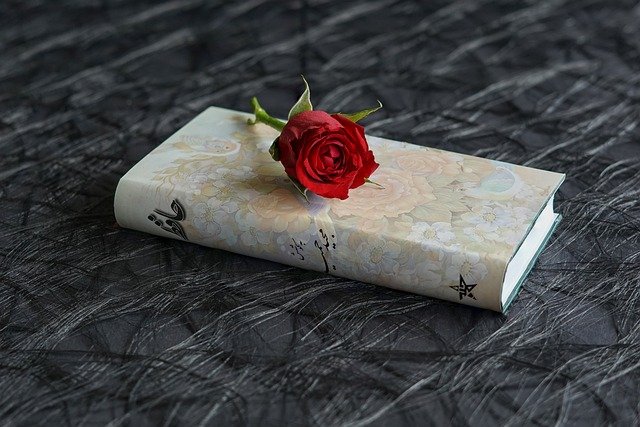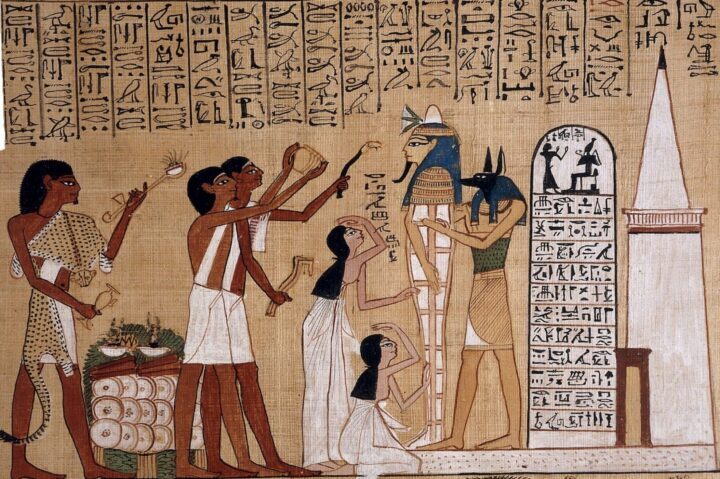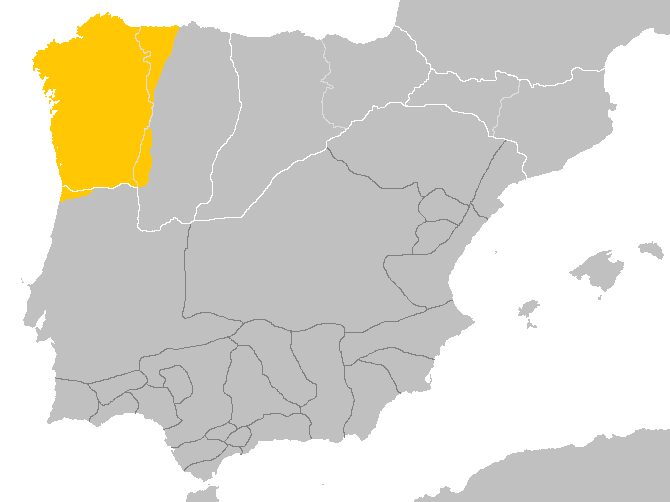Nell’arte poetica ricorrono frequentemente alcuni “artifici” che si allontanano dal normale uso linguistico: sono le cosiddette figure retoriche. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Indice dei contenuti
Quali sono le figure retoriche principali? Schema riassuntivo
| Figura Retorica | Concetto chiave | Esempio veloce |
|---|---|---|
| Allitterazione | Ripetizione di suoni uguali. | “Coca-Cola” |
| Onomatopea | Suono che imita la realtà. | “Din don” |
| Metafora | Paragone implicito. | “Sei un leone” |
| Ossimoro | Unione di contrari. | “Ghiaccio bollente” |
| Anafora | Ripetizione a inizio frase. | “Ascolta il vento, ascolta il mare” |
1. Cosa sono le figure retoriche? Definizione semplice
Le figure retoriche sono forme espressive che deviano dal linguaggio comune per rendere un messaggio più efficace e suggestivo. La loro funzione è comunicare una particolare carica emotiva, potenziare le immagini e ravvivare il linguaggio. Non sono esclusive della poesia, ma ricorrono anche nel parlare quotidiano e in altri linguaggi, come quello pubblicitario.
| Categoria | Obiettivo principale |
|---|---|
| Figure di suono | Creare musicalità, ritmo ed eco tramite la ripetizione dei suoni. |
| Figure di significato | Modificare il significato letterale per evocare immagini mentali. |
| Figure di posizione | Alterare l’ordine delle parole per dare enfasi o ritmo. |
2. Le figure retoriche di suono (o fonetiche)
Le figure retoriche di suono riguardano la musicalità e la ripetizione dei suoni. Servono a creare particolari effetti acustici e a sottolineare concetti chiave attraverso la combinazione di foni.
Allitterazione
L’allitterazione è la ripetizione di una lettera o di un gruppo di lettere all’inizio o all’interno di più parole.
- Esempio letterario: di me medesimo meco mi vergogno (F. Petrarca)
- Esempio moderno: lo slogan “Super Sconto”.
Assonanza
L’assonanza si ha quando due parole, a partire dalla vocale accentata, presentano le stesse vocali ma diverse consonanti.
- Esempio: piove sui nostri volti silvani (G. D’Annunzio)
Consonanza
La consonanza si ha quando due parole, a partire dalla vocale accentata, presentano le stesse consonanti ma diverse vocali.
- Esempio: tra gli scogli parlòtta la marétta (E. Montale)
Onomatopea
L’onomatopea è una parola che riproduce un suono, un rumore o il verso di un animale.
- Esempio letterario: nei campi / c’è un breve gre-gre di ranelle (G. Pascoli)
- Esempio moderno: il suono “click” del mouse.
Paranomasia
La paranomasia è l’accostamento di due parole con suoni simili ma significato diverso.
- Esempio letterario: sedendo e mirando (G. Leopardi)
- Esempio moderno: il detto “Chi non risica non rosica“.
3. Le figure retoriche di significato (o semantiche)
Le figure retoriche di significato incidono sul significato della parola e lo ampliano per creare immagini vivide e concetti più profondi.
Similitudine e metafora: differenze
Sono le figure di significato più comuni e spesso vengono confuse. La similitudine è un paragone esplicito, introdotto da “come” o “simile a”. La metafora è un paragone implicito, una “similitudine abbreviata”.
| Figura | Caratteristica ed esempio |
|---|---|
| Similitudine | Paragone esplicito. Esempio: “Sei furbo come una volpe”. |
| Metafora | Paragone implicito. Esempio: “Sei una volpe”. |
Antitesi e ossimoro
L’antitesi accosta concetti opposti in una frase (es. Pace non trovo e non ho da far guerra). L’ossimoro fonde due parole contrarie in un’unica espressione.
- Esempio di ossimoro: bianca nel tacito tumulto (Pascoli)
- Esempio moderno di ossimoro: l’espressione “lucida follia“.
Iperbole
L’iperbole è un’esagerazione per enfatizzare un concetto.
- Esempio letterario: ho sceso … almeno un milione di scale (E. Montale)
- Esempio moderno: “È un secolo che ti aspetto!”.
Metonimia e sineddoche
Entrambe sostituiscono un termine con un altro, ma si basano su principi diversi. La metonimia usa un rapporto di vicinanza logica, mentre la sineddoche un rapporto di quantità.
| Figura | Tipo di relazione ed esempio |
|---|---|
| Metonimia | Logica / qualitativa (es. l’autore per l’opera: “leggere Dante”). |
| Sineddoche | Quantitativa (es. la parte per il tutto: “le vele” per le barche). |
Altre figure di significato includono la litote (affermare con la negazione del contrario), la sinestesia (associare sensi diversi, es. “suono caldo”) e la personificazione (attribuire caratteri umani a oggetti o animali).
4. Le figure retoriche di posizione (o sintattiche)
Queste figure giocano con l’ordine delle parole per dare enfasi o un particolare ritmo.
Anafora
L’anafora è la ripetizione di una o più parole all’inizio di frasi o versi successivi.
- Esempio letterario: Per me si va ne la città dolente, / Per me si va… (Dante)
- Esempio moderno: “E poi, e poi, e poi… sarà quel che sarà” (Mina).
Altre figure di posizione sono l’anastrofe (inversione dell’ordine di due parole), il chiasmo (disposizione incrociata A-B-B-A) e il climax (successione in ordine di intensità crescente).
5. Come riconoscere le figure retoriche: consigli pratici
- Leggi ad alta voce: le figure di suono come l’allitterazione emergono più chiaramente.
- Cerca i paragoni: se vedi un “come”, è una similitudine. Se il paragone è implicito, è una metafora.
- Analizza l’ordine delle parole: se la frase suona “strana” o invertita, potrebbe esserci un’anastrofe.
- Fai attenzione ai sensi: se un testo mescola sensazioni diverse (es. un “urlo nero”), è una sinestesia.
6. Conclusione: perché sono importanti?
Le figure retoriche superano il semplice abbellimento. Sono il meccanismo del linguaggio creativo, strumenti che permettono a poeti e scrittori di trasformare un messaggio ordinario in un’esperienza memorabile. Riconoscerle significa comprendere più a fondo non solo la poesia, ma il potere stesso della parola.
A cura della docente Nunzia Serino.
Foto in evidenza: Pixabay
Articolo aggiornato il: 30/12/2025