La lingua napoletana vanta una tradizione viscerale fatta di gestualità, proverbi e modi di dire, dotati di tale bellezza e musicalità da acquisire una propria identità nazionale ed internazionale. Lingua, si ricordi, e non più mero dialetto, come affermato dall’Unesco, grazie alla sua innata capacità di diffondere e conservare modi di vita, arte e genuinità. Insieme alla spiccata arte del gesto, che accompagna la parola, la lingua partenopea offre un vasto repertorio di tipici modi di dire in napoletano che, nel tempo, l’hanno resa unica e preziosa.
Questi modi di dire affondano le loro radici nella storia, grazie all’influsso delle dominazioni straniere, ma anche nella tradizione religiosa, artistica, etimologica e folcloristica. Il risultato è una ricca e colorita gamma di espressioni, spesso intraducibili per l’efficacia del messaggio originale che intendono trasmettere.
Indice dei contenuti
Quali sono i migliori modi di dire in napoletano?
| Modo di dire | Significato e contesto |
|---|---|
| Figlio ‘e ‘ntrocchia | Persona astuta e scaltra, che sa cavarsela. |
| Chillo tene l’arteteca | Indica una persona iperattiva, che non sta mai ferma. |
| È fernuta ‘a zezzenella | È finito il periodo di abbondanza e benessere. |
| Aumm aumm | Fare qualcosa di nascosto, in segreto e velocemente. |
| Avimmo perduto a Filippo e ‘o panaro | Si è perso tutto, subendo sia il danno che la beffa. |
| L’uocchie sicche so’ peggio d’’e scuppettate | Il malocchio è peggio di una fucilata (contro l’invidia). |
L’origine dei modi di dire in napoletano
La lingua è frutto di contaminazioni e prestiti linguistici avvenuti nel corso dei secoli:
- Alcune parole come buatta (barattolo) o sciantosa (cantante esibizionista) derivano dal francese “boîte” e “chanteuse”.
- Altre come ammuìna (confusione) e ‘ngarrà (indovinare), dallo spagnolo “amohinar” e “engarrár”.
Origini storico-religiose
Uno tra i più diffusi modi di dire in napoletano, che affonda le sue radici nella storia e nella religione, è A Santa Lucia nu passe ‘e gallina, a Sant’Aniello nu passe ‘e pecuriello. Il riferimento è ai due santi. Il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, è tradizionalmente considerato il più breve dell’anno, che quindi si allunga “di un passo di gallina”. Il giorno successivo, Sant’Aniello, segna un ulteriore, piccolo allungamento, “un passo di agnello”.
Origini storico-etimologiche
Per definire una persona astuta si usa l’espressione Figlio ‘e ‘ntrocchia. Sebbene possa suonare offensivo, a Napoli è quasi un complimento. La parola ‘ntrocchia deriva dalle torce (“antorcule”) usate dalle prostitute nell’antica Roma. Un “figlio di lucciola” è quindi colui che, cresciuto per strada, ha dovuto sviluppare grande astuzia per sopravvivere.
Altri due modi di dire in napoletano che trovano spiegazione nell’etimologia sono Chillo tene l’arteteca e È fernuta ‘a zezzenella.
- Il termine “arteteca” deriva dal latino “arthritis” (artrite). Con il tempo, ha perso il suo significato medico per indicare una persona iperattiva.
- La seconda espressione indica la fine di un periodo felice. La “zezzenella” è una piccola mammella, e il detto si riferisce alla mungitura che finisce quando il latte si esaurisce. Perfetto per descrivere la fine delle vacanze!
Origini onomatopeiche
Molti modi di dire in napoletano derivano anche da suoni onomatopeici, come Aumm aumm e Sta arrivanno ‘o pata pata ‘e ll’acqua.
- La prima espressione significa fare qualcosa di nascosto e in fretta, richiamando il suono della bocca che mastica in silenzio.
- ‘O pata pata ‘e ll’acqua, invece, imita il suono delle gocce (pat pat) per annunciare un imminente acquazzone.
Origini artistiche
Anche il mondo dell’arte ha dato vita a celebri modi di dire in napoletano. È il caso di Avimmo perduto a Filippo e ‘o panaro, usato quando un’eccessiva attesa porta a perdere tutto, subendo il danno e la beffa. La frase deriva da un’antica farsa di Antonio Petito, in cui un servo di nome Filippo fugge dopo aver rubato una cesta di cibo (il “panaro”), lasciando il padrone senza servo e senza cesta. Per approfondire la storia del teatro napoletano e dei suoi protagonisti, si può consultare l’archivio della Treccani.
Origini folcloristiche
Uno dei più celebri modi di dire in napoletano è L’uocchie sicche so’ peggio d’’e scuppettate. L’espressione, che significa “il malocchio è peggio di una fucilata”, sintetizza la radicata credenza nella superstizione e il timore verso l’invidia altrui (gli uocchie sicche).
Si delinea così un panorama variegato, dove i modi di dire in napoletano rivelano toni di derisione, simpatia e l’immancabile cazzimma, quel neologismo che descrive un’astuzia impiegata per i propri scopi.
Cerchi la perfetta frase napoletana d’amore? Leggi “10 frasi d’amore in napoletano“
Foto di: Wikipedia
Articolo aggiornato il: 26/12/2025


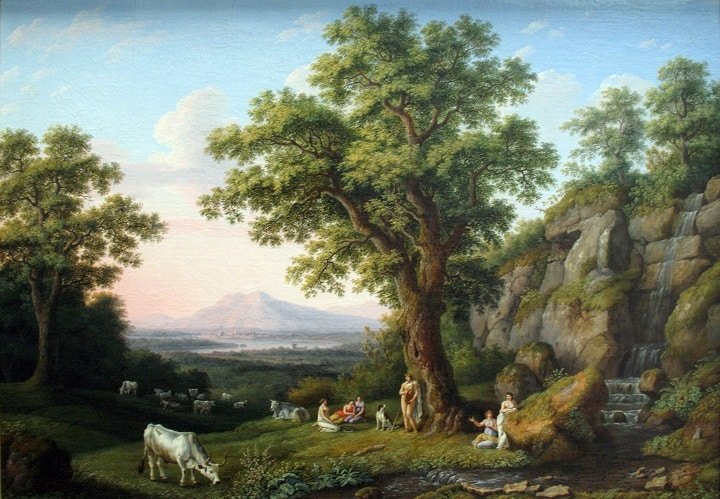



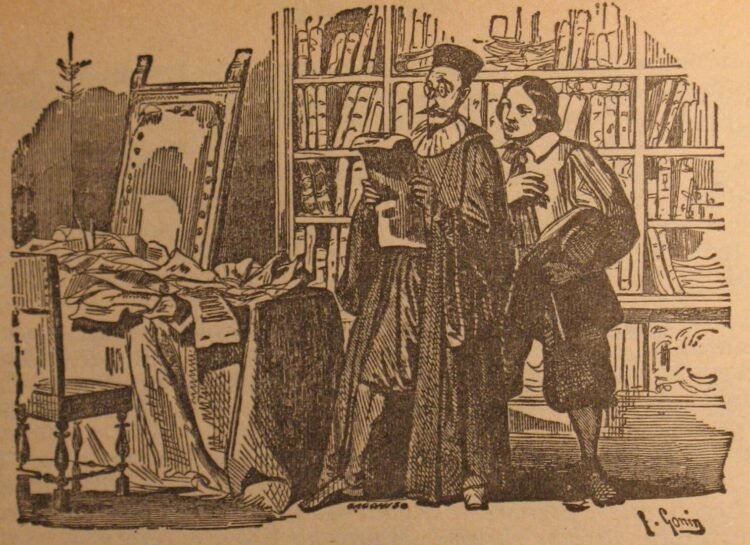




Buongiorno.
Ho letto il testo soprastante perchè spinto da una ricerca su una espressione tipica dell’italiano, ma da tradursi in dialetto napoletano. Non l’ho trovata nemmeno come affine rispetto al suo largo senso.
D’ogni modo, interessante quello che raccontate con riferimento al fenomeno della ibridazione fra popoli e nazionalità che hanno vissuto in riva al golfo.
Infine mi ha colpito nella digressione l’uso del termine <>: sto cercando proprio una frase da associare ad una foto che ha suscitato arrabbiatura istantanea e volontà di contrasto.