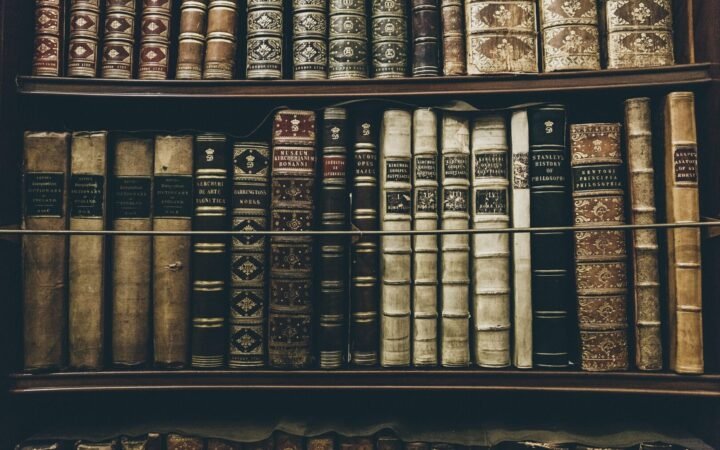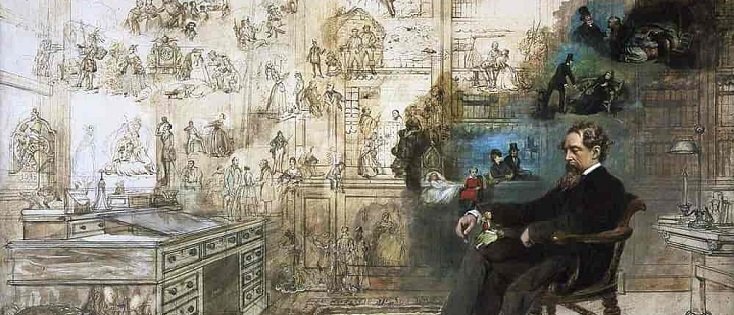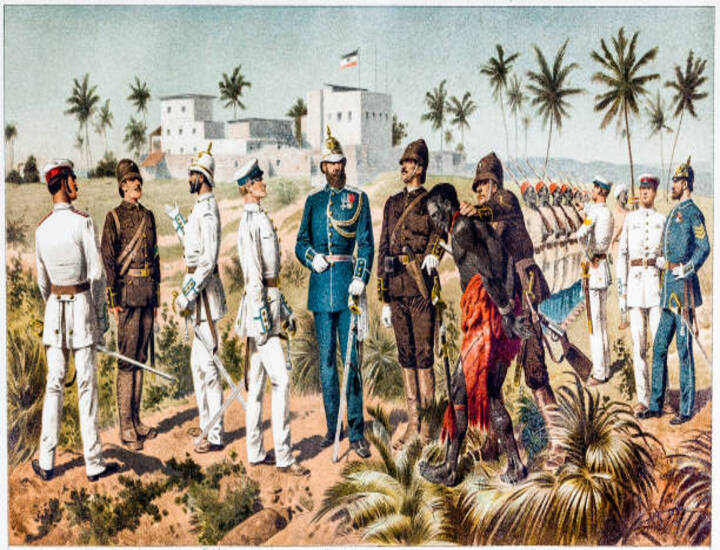Con il termine protogermanico si intende la fase ricostruita della lingua ancestrale delle popolazioni germaniche, sviluppatasi come ramo dell’indoeuropeo. L’elemento fonetico più importante e distintivo che separa il germanico dalle altre lingue indoeuropee è la prima mutazione consonantica, nota anche come Legge di Grimm.
Indice dei contenuti
La prima mutazione consonantica (Legge di Grimm)
Cosa dice la Legge di Grimm? Formulata da Jacob Grimm nel 1822, sulla base delle osservazioni del linguista Rasmus Rask, questa legge descrive la mutazione sistematica subita dalle consonanti occlusive indoeuropee nel loro passaggio al germanico. Quello ideato da Grimm è uno schema rotatorio (definito anche “rotazione consonantica”), che coinvolge tre serie di suoni.
| Consonante indoeuropea | Esito in germanico comune |
|---|---|
| Occlusive sorde (*p, *t, *k) | Diventano fricative sorde (*f, *þ, *h). |
| Occlusive sonore (*b, *d, *g) | Diventano occlusive sorde (*p, *t, *k). |
| Occlusive sonore aspirate (*bh, *dh, *gh) | Diventano fricative sonore (*β, *ð, *ɣ), che in seguito si evolvono in occlusive sonore (*b, *d, *g) in determinate posizioni. |
Presupponendo come punto di partenza le consonanti indoeuropee, lo schema rotatorio si può riassumere così:
- Le occlusive sorde indoeuropee (tenui) diventano fricative sorde in germanico.
- Le occlusive sonore indoeuropee (medie) diventano occlusive sorde in germanico.
- Le occlusive sonore aspirate indoeuropee (aspirate) diventano fricative sonore in germanico (e poi occlusive sonore).
La Legge di Verner: un’eccezione che conferma la regola
Qual è la differenza tra la Legge di Grimm e la Legge di Verner? La Legge di Verner, formulata dal linguista danese Karl Verner nel 1875, non è una legge separata, ma un corollario che spiega alcune apparenti eccezioni alla Legge di Grimm. Verner notò che, in alcuni casi, le occlusive sorde indoeuropee (*p, *t, *k) non davano come esito le fricative sorde (*f, *þ, *h) previste da Grimm, bensì le corrispondenti fricative sonore (*β, *ð, *ɣ).
Questo avveniva a due condizioni, legate all’accento musicale e mobile dell’indoeuropeo:
- la consonante si trovava in un contesto sonoro (tra due vocali o tra una vocale e una sonante);
- l’accento indoeuropeo non cadeva sulla sillaba immediatamente precedente alla consonante.
Questa sonorizzazione era probabilmente dovuta al fatto che, senza l’accento sulla sillaba precedente, l’articolazione della consonante si indeboliva (lenizione). La Legge di Verner è fondamentale perché dimostra la regolarità assoluta del cambiamento fonetico e conferma che la mutazione consonantica avvenne quando l’accento era ancora mobile, come in indoeuropeo, e non fisso sulla radice, come diventerà poi tipico del germanico.
Periodizzazione della mutazione consonantica
Quando è avvenuta la prima mutazione consonantica? Essendo il protogermanico una lingua ricostruita, è difficile stabilire una cronologia precisa. Tuttavia, attraverso la comparazione, fondamentale per la filologia germanica, e l’analisi dei prestiti linguistici, si possono formulare delle ipotesi. Poiché la Legge di Verner dipende da un accento mobile, essa deve essere avvenuta prima che l’accento germanico si fissasse. Analizzando i contatti linguistici (in particolare con il celtico e il latino), gli studiosi hanno ipotizzato che la mutazione sia iniziata intorno al V secolo a.C., per concludersi tra il II e il I secolo a.C.
Fonte immagine: Pixabay
Articolo aggiornato il: 02/09/2025