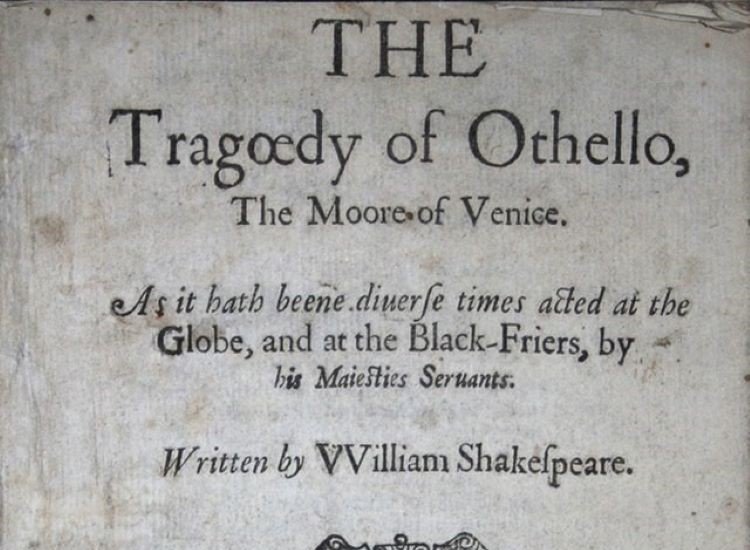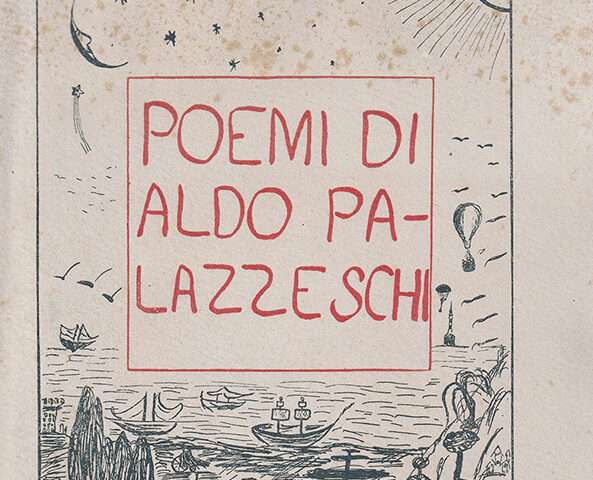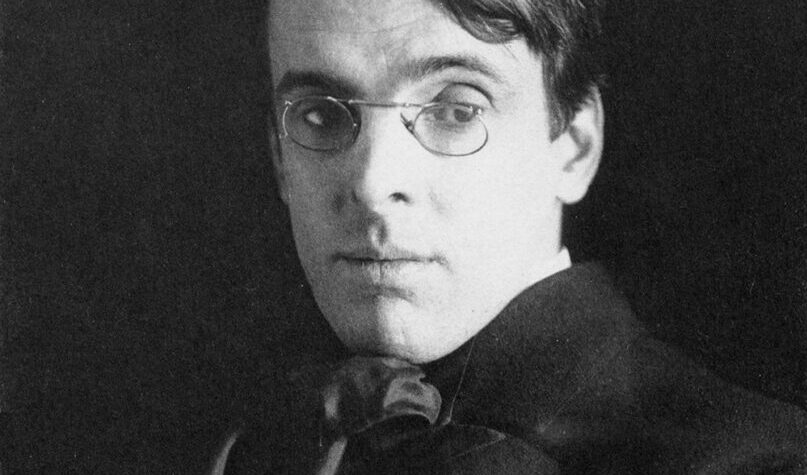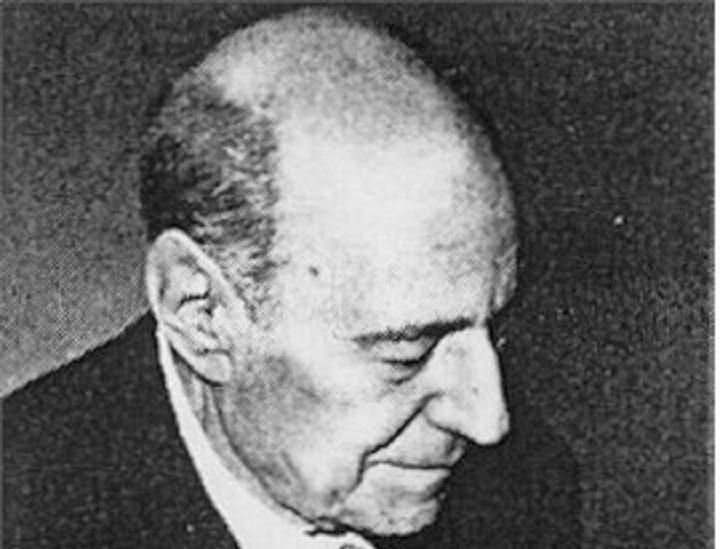L’imperatore Sutoku è il perno del racconto Shiramine (白峯, “Il Picco Bianco”), contenuto nella celebre raccolta Ugetsu Monogatari (雨月物語, “Racconti di Pioggia e di Luna”) di Ueda Akinari. Scritto nel 1776, durante il periodo Edo, questo testo è un capolavoro del genere kaidan (racconti di fantasmi). Il racconto mescola magistralmente eventi storici e figure reali, come il poeta Saigyō, con elementi sovrannaturali, trasformando un imperatore tradito in una delle figure più potenti e temute del folclore giapponese.
Sutoku: dalla storia al mito
L’antefatto storico: la Ribellione di Hōgen
L’apparizione di Sutoku in Shiramine
Analisi e temi: il dialogo tra rancore e compassione
L’eredità di Sutoku: da imperatore a spirito vendicativo
| Sutoku: dalla storia al mito | |
|---|---|
| La figura storica | La figura mitologica |
| 75° imperatore del Giappone (1123-1142), costretto ad abdicare dal padre. Sconfitto nella Ribellione di Hōgen, morì in esilio carico di rancore. | Dopo la morte, si trasforma in un onryō (spirito vendicativo), un potente tengu (demone corvo). È considerato uno dei “Tre Grandi Yōkai del Giappone”. |
| Durante l’esilio, tentò una riconciliazione inviando delle scritture sacre alla corte, che però furono rifiutate. | A seguito del rifiuto, si morse la lingua e scrisse con il sangue una maledizione contro la famiglia imperiale e la nazione. |
L’antefatto storico: la Ribellione di Hōgen
Sutoku (1119-1164) salì al trono a soli quattro anni, ma di fatto non governò mai. Suo padre, l’ex-imperatore Toba, mantenne il potere e lo costrinse ad abdicare in favore del fratello minore, Konoe. Alla morte di quest’ultimo, Toba scavalcò nuovamente Sutoku, ponendo sul trono un altro dei suoi figli. L’umiliazione e la frustrazione portarono Sutoku a organizzare un complotto, che sfociò nella Ribellione di Hōgen (1156). Questo breve ma sanguinoso conflitto civile, che vide contrapporsi anche i clan Taira e Minamoto, segnò la sconfitta di Sutoku e l’inizio dell’ascesa della classe guerriera (samurai) che avrebbe portato all’istituzione dello shogunato. Sutoku fu esiliato nella provincia di Sanuki, dove morì in povertà e oblio.
L’apparizione di Sutoku in Shiramine
Il racconto di Ueda Akinari inizia anni dopo, con il monaco e poeta Saigyō che, durante un pellegrinaggio, si imbatte nella tomba in rovina di Sutoku sul monte Shiramine. Commosso, decide di passarvi la notte a pregare. Al sorgere della luna, gli appare il fantasma dell’ex-imperatore, consumato da un odio che lo tiene ancorato al mondo. Sutoku racconta a Saigyō l’ultimo affronto subito in esilio: un suo gesto di riconciliazione – l’invio di sutra copiati a mano – fu respinto dalla corte per paura che contenessero una maledizione. Sentendosi umiliato, Sutoku consacrò allora se stesso e le sue scritture al male, giurando di diventare un demone per perseguitare la dinastia imperiale.
Analisi e temi: il dialogo tra rancore e compassione
Il cuore del racconto è il dialogo filosofico tra le due figure. Saigyō, incarnazione del distacco buddista, esorta Sutoku ad abbandonare l’attaccamento alle passioni terrene e a perdonare. Sutoku, al contrario, rivendica il diritto alla ribellione contro un sovrano ingiusto, secondo i principi confuciani. Incapace di placare la sua ira, Saigyō assiste terrorizzato alla sua trasformazione in un terrificante tengu, un demone dalle sembianze di un uccello rapace. Tuttavia, quando il poeta recita una poesia carica di compassione, il volto del demone sembra rasserenarsi per un istante, prima di svanire.
L’eredità di Sutoku: da imperatore a spirito vendicativo
La figura di Sutoku, come raccontata da Ueda Akinari, ha cementato il suo posto nel folclore giapponese. Dopo la sua morte, una serie di calamità colpì la capitale, tra cui incendi, tempeste e la morte prematura di diversi membri della famiglia imperiale. Questi eventi furono attribuiti al suo spirito vendicativo (onryō). Per placare la sua ira, la corte imperiale lo deificò, costruendo santuari in suo onore. Ancora oggi, Sutoku è considerato uno dei “Tre Grandi Yōkai del Giappone”, insieme a Sugawara no Michizane e Taira no Masakado: tre potenti figure storiche la cui rabbia post-mortem, secondo la tradizione, ha potuto scuotere le fondamenta della nazione. Questa complessa figura è un esempio perfetto di come la cultura giapponese, come evidenziato da istituzioni come il British Museum, abbia spesso trasformato le sue figure storiche più tragiche in potenti entità sovrannaturali.
Fonte immagine in evidenza: Wikipedia
Articolo aggiornato il: 30/09/2025