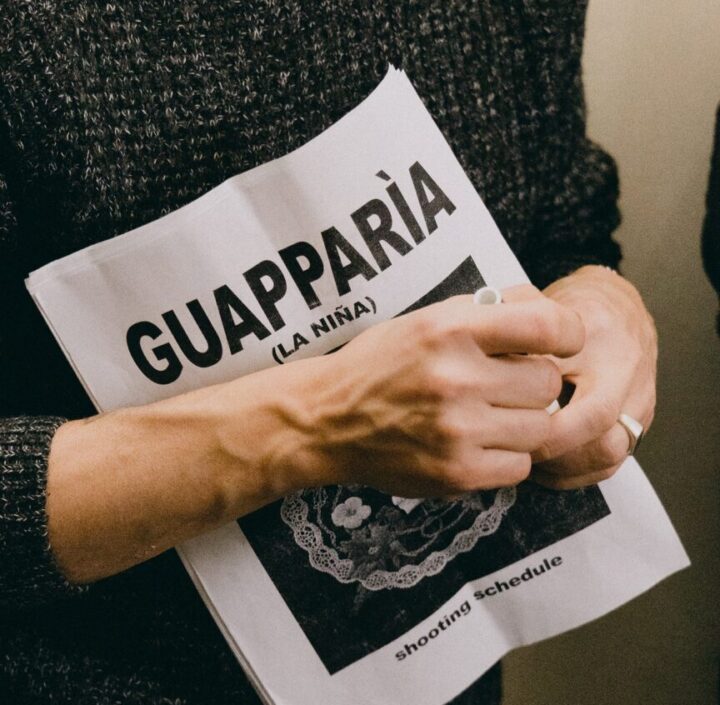A tre anni dall’uscita del suo ultimo album, Dove volano le aquile, Luchè torna sulla scena musicale con Il mio lato peggiore in uscita il 16 maggio. Un progetto che si distingue per sonorità cupe e testi introspettivi: l’ex membro dei Co’Sang si mette a nudo, esplorando una dimensione ancora più intima e riflessiva.
Le radici di Luchè
Luca Imprudente, in arte Luchè, nasce a Napoli il 7 gennaio 1981 e cresce nel quartiere popolare Marianella, una zona segnata da forti contrasti sociali e culturali che influenzeranno profondamente la sua musica. Fin da giovane, l’artista sviluppa la passione per la musica e nel 1997, insieme all’amico e rapper Ntò, fonda il gruppo Co’Sang. Il duo si distingue, fin da subito, per l’uso del dialetto napoletano e per testi che raccontano la realtà delle periferie partenopee, diventando così un simbolo per una generazione cresciuta tra difficoltà sociali. Dopo lo scioglimento del gruppo, avvenuto nel 2012, Luchè decide di intraprendere la carriera da solista.
L’evoluzione musicale
Nel 2012, pubblica il suo primo album da solista, L1. Due anni dopo arriva L2 che consolida il suo stile personale, fatto di introspezione e atmosfere intense. Il punto di svolta arriva nel 2016 con Malammore, in cui Luchè introduce sonorità più cupe e riflessive, ma è con Potere, nel 2018, che Luchè si afferma definitivamente nella scena urban nazionale. Nel 2022 pubblica Dove volano le aquile, album che segna una nuova fase della sua carriera e affronta temi come l’ambizione, il successo, le relazioni, il tradimento e la solitudine. Il titolo stesso è una metafora della crescita personale: “volare alto” nonostante gli ostacoli.
Il mio lato peggiore
Il cantante, prima di svelare l’intero album, ha già aperto uno spiraglio sul suo lato peggiore con due singoli Autostima, inedito insieme a Night Skinny e Anno Fantastico ft. Tony Boy e Shiva. A comporre Il mio lato peggiore sono 18 tracce, un disco che mescola urban e melodia, tra confessioni e confronti artistici con alcune delle voci più forti della scena italiana. Tra i featuring, infatti, spiccano nomi come Giorgia, Marracash, Geolier, Sfera Ebbasta e molti altri ancora.
Tracklist:
1. IL MIO LATO PEGGIORE CON LELE ADANI
2. MIAMI VICE FT. SFERA EBBASTA, SIMBA LA RUE
3. GINEVRA FT. GEOLIER
4. UN MILIONE DI MANI FT. ROSE VILLAIN
5. LA MIA VITTORIA FT. GIORGIA, MARRACASHI
6. ILARY FT. GUÈ, NERISSIMA SERPE
7. NESSUNA
8. AUTOSTIMA
9. INCREDIGILE FT. KAASH PAIGE
10. RED FLAG FT. COCO
11. MORIRE VUOTO
12. LETTERA ALLA PISTOLA ALLA MIA TEMPIA
13. SE NON CI FOSSE LA RABBIA
14. BUONA FORTUNA
15. PUNTO G ET TONY EFFE
16. ANNO FANTASTICO FT. SHIVA, TONY BOY
17. XXX
18. VENG ‘A INT’ ALL’INFERN FT. NTÒ
Il ritorno sul palco
Con l’uscita de Il mio lato peggiore, Luchè è pronto a riportare la sua musica anche sul palco. Il 5 giugno inaugurerà il suo tour con un evento storico: la sua prima esibizione nello Stadio Diego Armando Maradona. Un traguardo che segna non solo il suo ritorno, ma anche un momento simbolico per la sua carriera e la città.
Ecco le date e le città confermate per il Luchè Summer Tour:
| Date | Città | Luogo |
| 5 giugno 2025 | Napoli | Stadio Diego Armando Maradona |
| 22 luglio 2025 | Termoli (CB) | Termoli Summer Festival |
| 24 luglio 2025 | Roma | Rock in Roma |
| 8 agosto 2025 | Riccione (RN) | Versus Festival |
| 16 agosto 2025 | Gallipoli (LE) | Raffo Parco Gondar |
| 21 agosto 2025 | Diamante (CS) | Teatro dei Ruderi |
| 29 agosto 2025 | Castellammare del Golfo (TP) | Castellammare Music Fest |
| 4 settembre 2025 | Empoli (FI) | Beat Festival |
| 15 settembre 2025 | Milano | Unipol Forum |
I biglietti sono disponibili su TicketOne.
Fonte immagine: Spotify