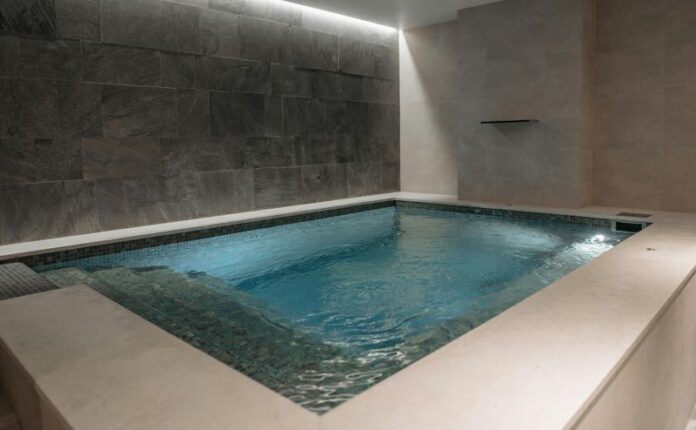Il termine hanok deriva dalla combinazione delle parole coreane “han”, che significa “Corea”, e “ok”, che significa “casa”. Si riferisce alle abitazioni tradizionali coreane e viene usato per distinguerle dalle abitazioni in stile occidentale, note in Corea come yangok.
Indice dei contenuti
Caratteristiche principali delle Hanok
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Materiali | Legno, pietra, argilla. |
| Riscaldamento | Ondol (sistema a pavimento). |
| Principio guida | Pungsu-jiri (Feng Shui coreano). |
| Posizione ideale | Montagna alle spalle, acqua di fronte. |
| Stile | Varia in base allo status sociale (nobile o contadino). |
Le hanok nel tempo
Origini storiche e declino
Le hanok fecero la loro prima comparsa durante la dinastia Joseon e rimasero una presenza costante nel paesaggio urbano e rurale fino alla guerra di Corea. Dopo la divisione della penisola nel 1953 e la successiva modernizzazione della Corea del Sud, emerse la necessità di ospitare più persone in spazi ristretti, portando all’adozione di abitazioni in stile occidentale come condomini e grattacieli. Questo sviluppo causò la demolizione di molti villaggi hanok.
Rinascita e tutela
A partire dal 2001, il governo sudcoreano ha avviato un programma nazionale per la tutela e il restauro delle hanok superstiti, riconoscendole come simboli del patrimonio culturale coreano.
L’importanza del feng shui
La costruzione di una hanok non iniziava mai con i lavori manuali: prima di posare anche solo una pietra, era necessario seguire un processo accurato e quasi rituale, profondamente radicato nei principi del pungsu-jiri—l’equivalente coreano del feng shui. Ogni dettaglio veniva ponderato con attenzione, a partire dalla scelta del terreno, considerata fondamentale. Il luogo ideale? Un’area con una montagna alle spalle, simbolo di protezione, e una fonte d’acqua di fronte, emblema di prosperità e buon flusso energetico.
Solo dopo aver trovato il sito perfetto si passava alla progettazione della pianta della casa, che poteva essere quadrata o rettangolare. Anche la disposizione interna delle stanze non era lasciata al caso: ogni ambiente veniva collocato rispettando le regole dell’antica arte geomantica.
Materiali e caratteristiche
Le hanok sono realizzate con soli tre materiali naturali: legno, pietra e argilla. Una scelta che va ben oltre la semplicità costruttiva e rivela una filosofia abitativa profonda, dove l’uomo non domina la natura, ma vi si integra in perfetto equilibrio.
Le abitazioni si sviluppano interamente su un unico piano, ma la loro struttura poteva variare in base allo status sociale dei proprietari. Le famiglie contadine vivevano solitamente in abitazioni più semplici e compatte, composte da un unico edificio che racchiudeva tutte le funzioni domestiche. Al contrario, le famiglie nobili godevano di spazi più ampi e articolati: le loro case avevano più edifici separati dedicati a diverse attività.
Il sistema di riscaldamento ondol
Tra gli elementi più affascinanti di queste case tradizionali, spicca senza dubbio l’ondol, il tradizionale sistema di riscaldamento a pavimento, ancora oggi utilizzato nelle case moderne per la sua straordinaria efficienza. Il funzionamento è tanto semplice quanto geniale: sotto il pavimento si trova uno strato di pietra che viene riscaldato da una fornace esterna. Bastano pochi pezzi di legna per mantenere il calore per oltre 24 ore, grazie alla naturale capacità della pietra di trattenere e rilasciare il calore lentamente.
L’importanza dell’argilla
A rendere tutto ancora più efficace ci pensa l’argilla, che utilizzata nei muri e nei tetti, funge da isolante naturale: in inverno trattiene il calore, in estate lo respinge, contribuendo anche a regolare l’umidità interna. Non è un caso, infatti, che i coreani abbiano da sempre vissuto, mangiato e dormito a terra: il pavimento non era solo una superficie, ma il cuore caldo e accogliente della casa.
Le hanok nobiliari: spazi e stanze influenzate dal neoconfucianesimo
In una tradizionale abitazione nobile coreana, ogni ambiente aveva una funzione ben precisa e rispecchiava l’ordine sociale e familiare del tempo. Queste residenze, più articolate rispetto alle semplici case contadine, erano composte da più padiglioni distribuiti intorno a un cortile centrale e suddivisi tra spazi pubblici e privati, maschili e femminili, in linea con i principi neoconfuciani sulla separazione dei ruoli di genere.
Com’è organizzata una casa nobile coreana: stanze e funzioni
Il Jeongja, spazio aperto tra natura e contemplazione
Tra gli elementi immancabili troviamo il Jeongja (정자), una sorta di padiglione aperto simile a un portico o terrazza. Era utilizzato per il riposo, la meditazione o l’osservazione della natura, esprimendo l’ideale armonia tra l’uomo e l’ambiente.
Il Sadang: un luogo per il culto degli avi
Il Sadang (사당) era il tempio degli antenati, qui si svolgevano i riti confuciani in occasione di ricorrenze e festività tradizionali. Questo spazio sacro rafforzava il legame con la famiglia estesa e con le generazioni passate, fondamentale nella visione confuciana.
Il Madang: fulcro della vita domestica
Al centro dell’abitazione si trovava il Madang (마당), il cortile principale, uno spazio aperto che fungeva da punto d’incontro tra le varie sezioni della casa. Ci si muoveva attraverso il cortile per accedere alle stanze, e spesso veniva utilizzato per giochi dei bambini o eventi familiari.
La separazione dei ruoli di genere negli spazi domestici
Il Sarangchae: l’area maschile
Il lato orientale era occupato dal Sarangchae (사랑채), l’area riservata esclusivamente agli uomini. Qui si trovavano le stanze per lo studio, la lettura e la ricezione degli ospiti maschili. Era un luogo formale, simbolo del ruolo pubblico e intellettuale dell’uomo.
L’ Anchae: l’area femminile
Sul lato occidentale si trovava invece l’Anchae (안채), l’area privata riservata alle donne e considerata il cuore operativo della casa. Qui si trovavano la cucina e la Jangdokdae (장독대), una piattaforma esterna su cui venivano disposte grandi giare in terracotta contenenti salsa di soia, gochujang e kimchi, lasciati a fermentare naturalmente.
La Gyubang, lo spazio creativo delle donne tra ago e tessuto
All’interno dell’Anchae, una stanza particolarmente significativa era la Gyubang, uno spazio dove le donne si riunivano per dedicarsi al cucito e ad altre attività artigianali. Utilizzando ritagli di tessuto avanzato, realizzavano piccoli oggetti decorativi, elementi ornamentali per gli abiti o doni fatti a mano, esprimendo creatività e identità personale anche in un contesto fortemente regolato.
Fonte immagine: Archivio personale
Articolo aggiornato il: 04/01/2026
“`