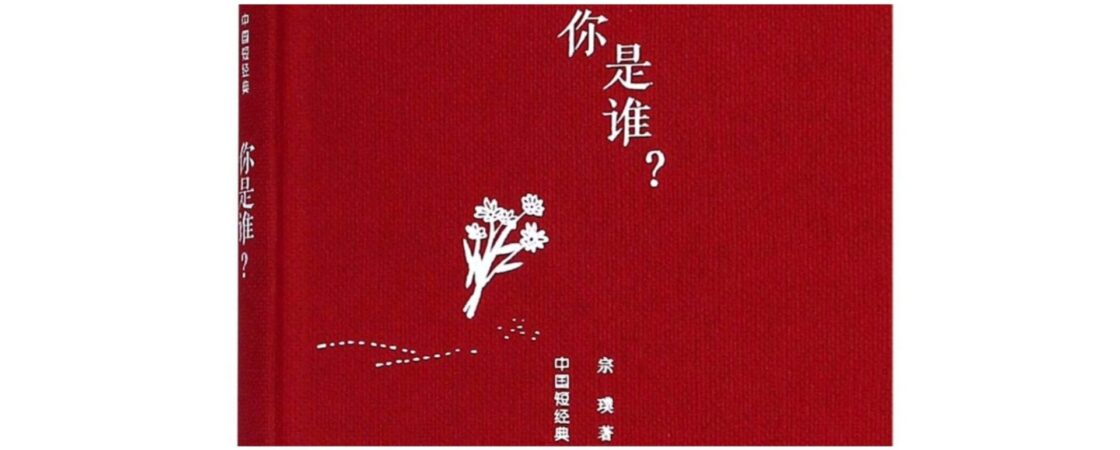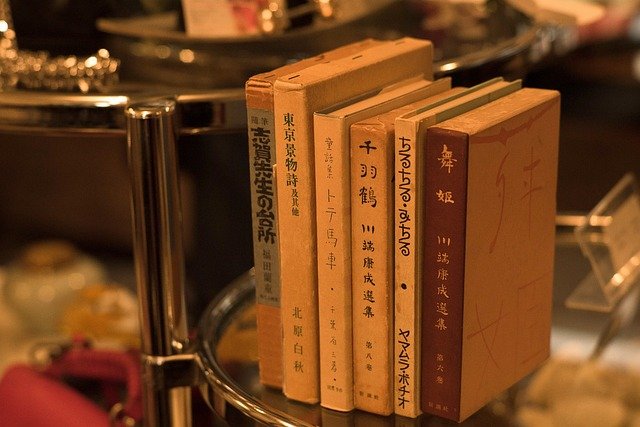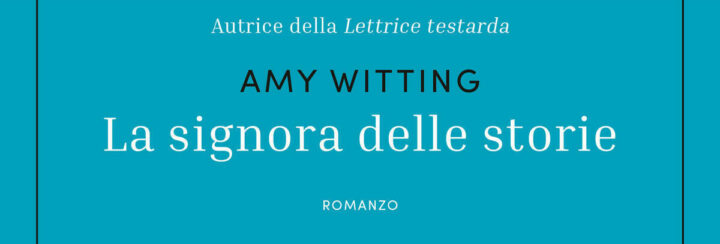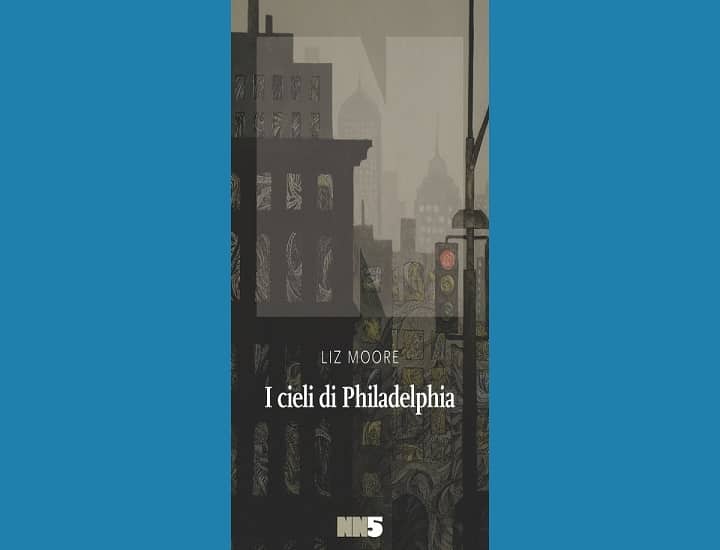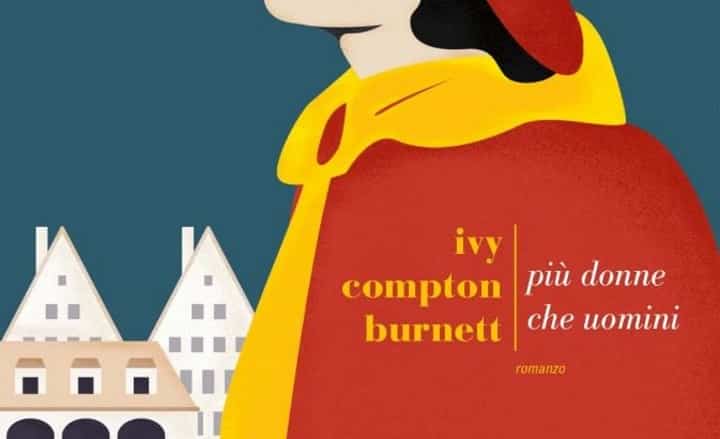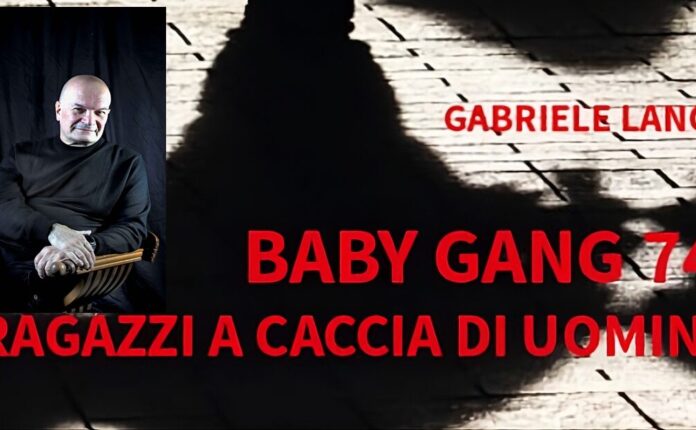La letteratura delle cicatrici (伤痕文学, shānghén wénxué) è una tendenza letteraria emersa alla fine degli anni ’70 in Cina, dopo la morte di Mao Zedong. Considerata la prima corrente letteraria dell’epoca post-maoista, il suo fine era testimoniare e ricordare le ferite, il dolore e lo smarrimento provati durante la Rivoluzione Culturale (1966-1976).
Indice dei contenuti
Contesto e caratteristiche del movimento
Dopo la Rivoluzione Culturale e il fallimento del Grande Balzo in avanti, la Cina si affaccia agli anni ’70 sfinita. La letteratura delle cicatrici nasce in questo clima per denunciare i crimini delle Guardie Rosse. Il movimento prende il nome dal racconto “La cicatrice” (伤痕, *Shānghén*) di Lu Xinhua del 1978. Si tratta di una letteratura semi-autonoma: da un lato vuole liberarsi dagli schemi maoisti, ma dall’altro ne conserva la dicotomia tra bene e male, capovolgendola. I protagonisti non sono più gli eroi rivoluzionari, ma le vittime e i reduci delle violenze. Questo sfogo letterario celebrava anche il nuovo potere politico, che dopo la morte di Mao iniziava ad abbracciare istanze più moderate, come spiegato da diverse analisi storiche.
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | Fine anni ’70 – inizio anni ’80 (epoca post-maoista) |
| Contesto storico | La fine della Rivoluzione Culturale e la morte di Mao Zedong |
| Obiettivo principale | Denunciare i traumi, le violenze e le ingiustizie subite durante la Rivoluzione Culturale |
| Protagonisti tipici | Intellettuali, giovani e famiglie perseguitati come “antirivoluzionari” |
| Stile | Realistico ma con elementi surreali e psicologici, spesso influenzato da autori come Kafka |
Analisi di un’opera manifesto: “Chi sono io” di Zong Pu
Un’opera rappresentativa di questo movimento è Chi sono io (我是谁, 1979) di Zong Pu, autrice la cui opera è oggetto di numerosi studi accademici. In questo racconto osserviamo uno stile che si discosta dal realismo maoista, incorporando elementi surreali per rappresentare le assurdità della Rivoluzione Culturale. La narrazione è filtrata attraverso la prospettiva di Wei Mi, una protagonista afflitta da disturbi mentali a causa delle persecuzioni subite.
La storia si svolge in un campus universitario a Pechino, un luogo di conoscenza trasformato in teatro di violenza. La protagonista è oggetto di pesanti insulti mirati a distruggere la sua identità. Le parole riflettono il lessico della Rivoluzione Culturale, mentre l’atmosfera è pervasa da un senso di oscurità, con il colore rosso che evoca sia il comunismo sia il sangue. Nonostante la narrazione suggerisca una colpa da parte della protagonista, i lettori sono consapevoli della sua bontà. Lei e suo marito sono intellettuali che rappresentano lo spirito autentico del socialismo, distorto dalla violenza della lotta di classe.
Chi sono io diventa quindi l’emblema dell’intellettuale che si identifica con la coscienza collettiva, ribadendo il valore della scienza come fondamento per un nuovo socialismo. La risposta al titolo non è “io sono io”, ma “io sono io all’interno di una comunità“, sottolineando il ruolo essenziale dell’individuo nella società, in contrapposizione all’annullamento della persona promosso dalla Rivoluzione Culturale.
Fonte immagine in evidenza: copertina della casa editrice People’s Literature Publishing House presa da Amazon
Articolo aggiornato il: 08/09/2025