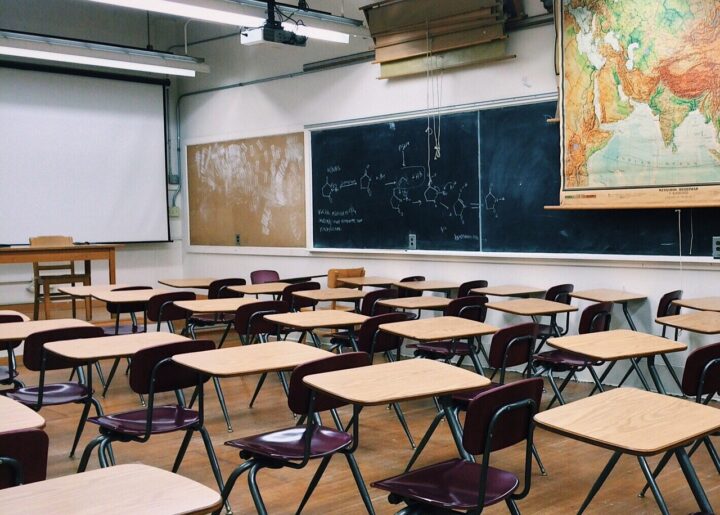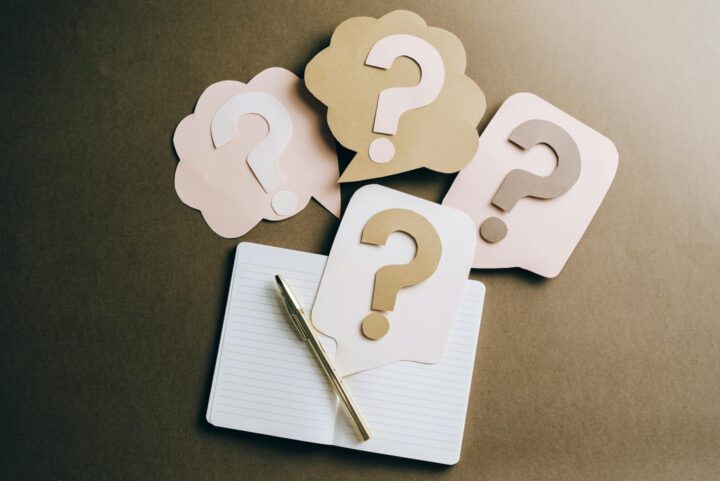Negli ultimi anni, sull’onda lunga della cultura americana e del suo bisogno di riscatto sociale e inclusivo, si è diffusa nella letteratura per ragazzi un’immagine nuova, accattivante, apparentemente rivoluzionaria: quella del corpo non conforme che finalmente non viene più condannato, ma celebrato. Il personaggio grasso non è più il bersaglio delle battute o la macchietta comica di contorno, ma diventa protagonista, simbolo di autoaffermazione, figura che rivendica il diritto ad esistere così com’è, senza modificarsi, senza cedere alla pressione estetica. Mentre mangia cupcakes e waffles, patatine e sciroppo d’acero, viene sostenuto da genitori amorevoli che gli dicono: “Ti amiamo così come sei”. E questo, in superficie, è un traguardo importante. La lotta al body shaming, alle umiliazioni legate all’aspetto fisico, al bullismo scolastico e sociale, ha fatto passi da gigante, e chiunque abbia attraversato l’adolescenza con un corpo fuori norma sa quanto possa essere dura sentirsi sbagliati solo per come si è fatti.
Tuttavia, c’è un aspetto che comincia a inquietare, un nodo che si fa più stretto ogni volta che si assiste alla trasformazione di un principio giusto in una narrazione sbilanciata, perché se è vero che l’inclusione è un valore irrinunciabile, se è sacrosanto dire a ogni ragazzo “meriti amore, rispetto e dignità a prescindere dal tuo corpo”, è altrettanto vero che non si può educare al benessere saltando completamente il discorso sulla salute. L’obesità non è un’opinione, non è una preferenza estetica, è una condizione medica connessa a numerose patologie: diabete, ipertensione, problemi cardiovascolari, riduzione dell’aspettativa di vita. Non è un giudizio morale, è un dato. Le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità lo dicono chiaramente: nel mondo si muore più per le conseguenze dell’eccesso di peso che per denutrizione. Eppure, paradossalmente, parlare di tutto questo è diventato scomodo. Dire a un adolescente sovrappeso che ha bisogno di muoversi di più o mangiare meglio viene percepito da molti come body shaming mascherato.
C’è un clima culturale, importato in parte da un’America in bilico tra trauma e progresso, che tende a trasformare ogni forma di limite in un’offesa, ogni richiamo alla responsabilità in una violenza simbolica. È il trionfo del desiderio elevato a diritto, della narrazione individuale che scavalca ogni dato biologico, ogni vincolo fisico, ogni realtà misurabile. Si vuole far credere che tutto sia trasformabile a piacere, che ogni desiderio possa legittimarsi come rivendicazione identitaria, anche quando è autodistruttivo. Il problema non è l’accettazione del corpo, è l’abdicazione al principio educativo. Non si tratta di correggere le persone, ma di prendersene cura. E prendersi cura significa anche, anzi, soprattutto, dire la verità. Una verità che può suonare scomoda, certo, ma che può essere detta con amore, con attenzione, con rispetto. Non serve dire “sei ciccione e basta”, serve costruire un discorso in cui il benessere diventa una parte dell’accettazione, non il suo opposto. Accettarsi significa riconoscere i propri limiti, anche quelli imposti dal corpo, dalla genetica, dall’età, dal tempo. Ma riconoscere i limiti non significa inchinarsi a essi, bensì agire nel loro perimetro, fare spazio alla possibilità di evoluzione.
La distorsione più pericolosa, in fondo, è questa: confondere accoglienza con deresponsabilizzazione. Dire a un figlio “ti amo così come sei” dovrebbe essere il punto di partenza, non il punto di arrivo. Da lì si dovrebbe costruire un percorso, insieme, che lo aiuti a stare bene davvero, nel corpo e nella mente. Perché se l’autostima si costruisce solo sulla negazione dei problemi, è un castello di sabbia. Se l’identità si forma solo per opposizione allo stigma, senza strumenti per affrontare la realtà, rischia di collassare al primo confronto serio con il mondo.
Invece oggi si preferisce l’illusione che tutto sia sempre legittimo, che ogni scelta sia neutra, che l’autoindulgenza sia un atto politico, ma la realtà non fa sconti. E il corpo, che è la nostra interfaccia con il mondo, non si lascia convincere dai messaggi inclusivi quando soffre, quando arranca, quando si ammala. Bisogna allora recuperare un’idea complessa, profonda, forse antica, ma oggi rivoluzionaria: l’educazione come atto d’amore. Non imposizione, non correzione autoritaria, ma guida affettuosa. Non vergogna, ma consapevolezza. Non giudizio, ma responsabilità.
Insegnare ai ragazzi che il mondo non li amerà sempre come mamma e papà. Che il corpo, per quanto unico e prezioso, ha bisogno di essere ascoltato, mosso, nutrito bene. Che non si può desiderare tutto e non pagare alcun prezzo. Che non tutto è modificabile, non tutto è negoziabile, e che va bene così. C’è una forma di bellezza, di dignità, di verità nell’accettare che non siamo onnipotenti. È un antidoto contro la deriva individualista e consumista in cui siamo immersi. E forse è il solo modo per restituire significato all’educare: non imporre modelli irraggiungibili, ma accompagnare ciascuno verso la versione più sana, libera e consapevole di sé.
Foto di Towfiqu barbhuiya: https://www.pexels.com/it-it/foto/persona-pancia-pancetta-gonfio-11773868/
Yuleisy Cruz Lezcano