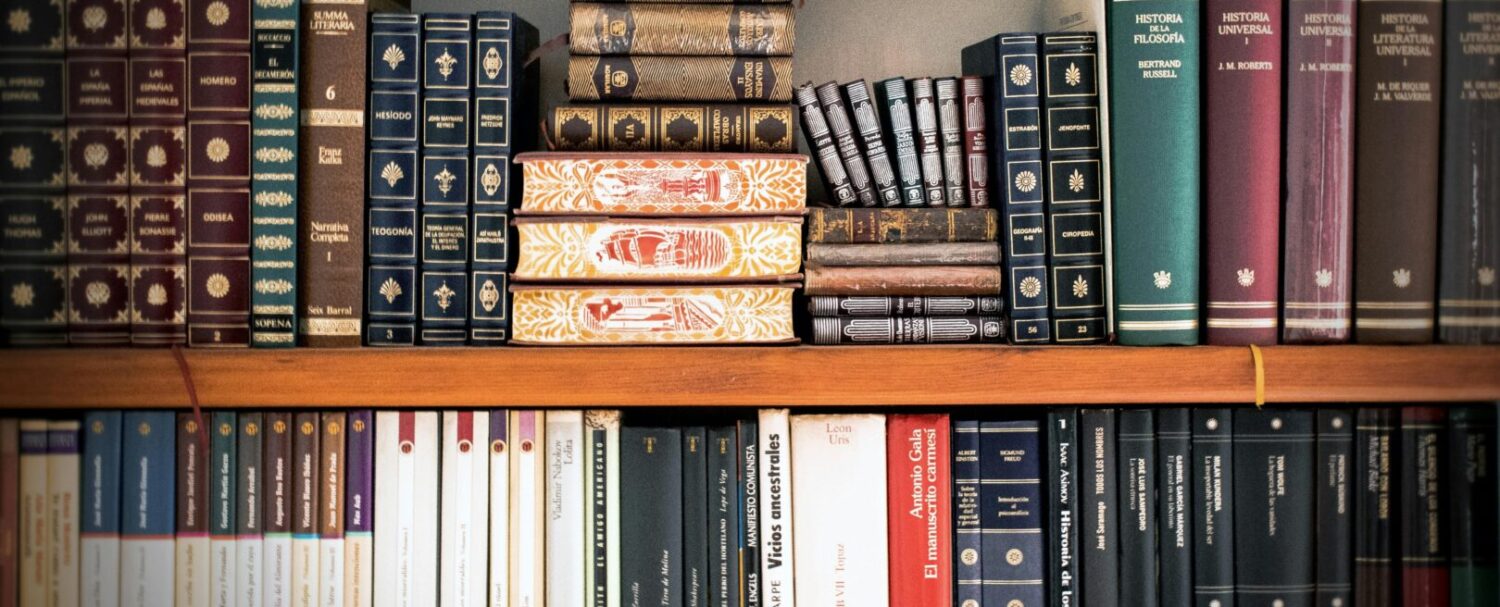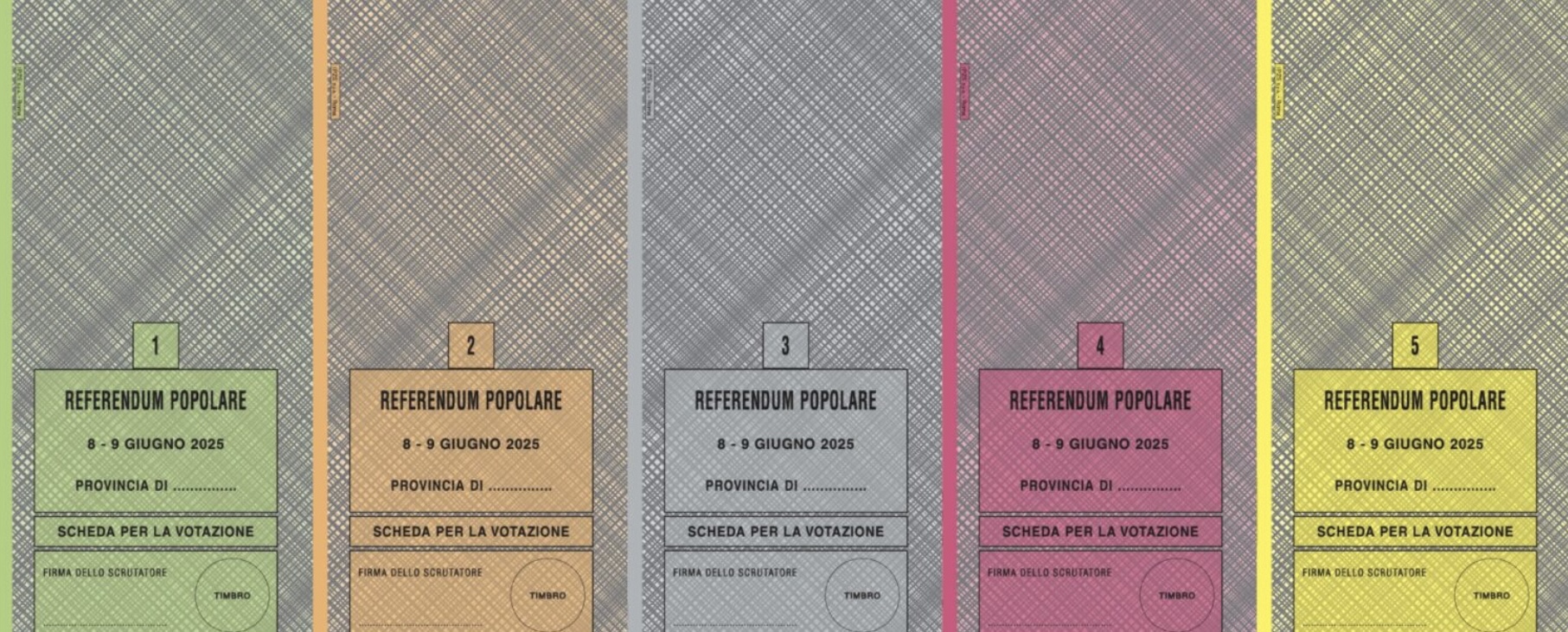Nella spirale della violenza di genere, il tempo è un fattore decisivo. Ogni giorno di attesa, ogni denuncia presa sottogamba, ogni sottovalutazione istituzionale, può trasformarsi in un giorno di paura, di dolore, a volte di morte. La violenza domestica non è mai un fulmine a ciel sereno: è un processo graduale, una trappola che si chiude lentamente, fatta di piccoli segnali ignorati, di parole sminuite, di richieste d’aiuto rimandate, di donne lasciate sole proprio quando cercano di alzare la testa.
Chi lavora nei centri antiviolenza lo sa bene: il momento della denuncia è spesso il più difficile e pericoloso e già arrivare a riconoscere di essere vittime non è semplice. Per molte donne, la violenza non è “un reato”, ma qualcosa di “sbagliato”, oppure “qualcosa che è successo”. Secondo l’Istat, il 49% delle donne che hanno subito violenza fisica o sessuale da un partner non la riconosce come tale. Il 20% la considera un evento neutro, senza una connotazione negativa. Questo dato non è un problema di percezione individuale, ma la fotografia di una cultura ancora profondamente radicata nella normalizzazione della sopraffazione e del possesso. Ed è proprio questo che rende così complessa la denuncia: quando non si sa dare un nome alla violenza, come si può combatterla? E anche quando una donna trova il coraggio di denunciare, troppo spesso si scontra con una rete istituzionale lenta, distratta, non formata o, peggio, complice di una cultura che ancora tende a minimizzare, colpevolizzare, giustificare. Quando lo Stato sceglie di non credere, di rimandare, di aspettare “prove più solide”, di considerare le richieste d’aiuto come “eccessive” o “emotive”, allora diventa parte del problema.
Un caso recente, arrivato fino alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha messo nero su bianco questa responsabilità. La Corte ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 8 della Convenzione europea, per non aver protetto adeguatamente una donna che aveva denunciato violenze domestiche da parte dell’ex partner. La sua richiesta di protezione fu ignorata: nessuna valutazione del rischio, un’udienza fissata nove mesi dopo la richiesta urgente, due mesi di attesa solo per la registrazione della denuncia. Nel frattempo, la violenza continuava, così lo Stato ha fallito, ha scelto di non vedere, non ascoltare, non agire. E non si tratta di un caso isolato. A ottobre, una donna è stata soccorsa in lacrime con il volto insanguinato, dai carabinieri. Il convivente l’aveva picchiata e minacciata di morte. Le violenze, ha raccontato, andavano avanti da più di un anno, ma solo quella sera, dopo essere stata ridotta così, ha ottenuto l’arresto dell’uomo e una misura cautelare. Prima da allora, silenzio e solitudine. A Sorrento, un 24enne si è appostato sotto casa della sua ex per impedirle di uscire, perché “non accettava la fine della relazione”. Quando i carabinieri sono intervenuti, li ha aggrediti. È stato necessario sedarlo per arrestarlo, e mentre questo accadeva, a Siracusa, un altro uomo accoltellava la sua ex compagna appena uscita dal lavoro. Sono coincidenze? Proprio no! Sono espressioni diverse della stessa radice: l’idea che la donna sia proprietà, che la separazione sia un affronto, che il rifiuto sia una sfida da spezzare con la forza.
Molte donne rimangono in relazioni violente non perché non vogliono andarsene, ma perché non sanno come farlo in sicurezza, perché hanno paura di ritorsioni, perché non hanno risorse economiche, perché sono emotivamente intrappolate in cicli di manipolazione e speranza. Ma anche perché sanno, e spesso lo hanno sperimentato, che chi dovrebbe proteggerle potrebbe non crederle, o intervenire troppo tardi.
Ogni singola violenza ha radici nella cultura patriarcale e negli stereotipi di genere che la sostengono. Ma è l’assenza di risposte rapide e competenti da parte delle istituzioni a rendere il terreno fertile per il loro ripetersi. Quando i segnali di allarme vengono ignorati, quando le parole di una donna restano sospese nel vuoto, si apre la strada alla tragedia. La responsabilità non è solo dell’aggressore, ma anche di chi ha avuto la possibilità di intervenire e non lo ha fatto. Rompere questa spirale non è semplice, ma è possibile. Serve formazione specifica per chi lavora nella giustizia, nelle forze dell’ordine, nei servizi sociali, perché è necessario agire in fretta. Ma, soprattutto, serve smettere di trattare la violenza come un’emergenza straordinaria e iniziare a riconoscerla per ciò che è: una realtà quotidiana, sistemica e strutturale, che solo un cambiamento profondo può davvero disinnescare.
Yuleisy Cruz Lezcano