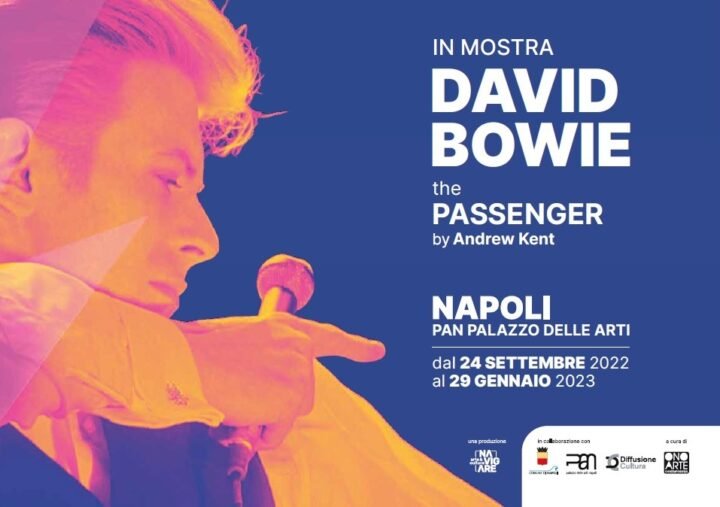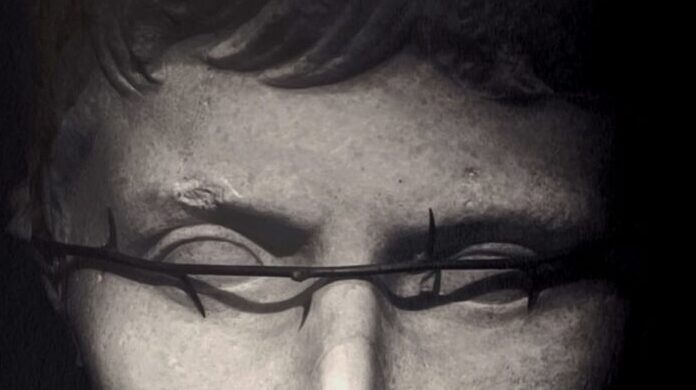A Palazzo Cavalcanti, a Napoli, il 5 maggio, Nicola Lagioia ha aperto il primo appuntamento di un ciclo di incontri ideato dal Comune di Napoli. Dialoghi è la nuova rassegna in collaborazione con la rivista multimediale Lucy. sulla cultura; ad accompagnare Lagioia c’era Claudia Durastanti, insieme al sindaco Gaetano Manfredi, nella suggestiva cornice di Palazzo Cavalcanti – Casa della Cultura.
Il ciclo di eventi prevede 5 appuntamenti in programma fino a ottobre che trasformeranno Napoli non solo in un polo culturale ma anche in un laboratorio di riflessione e confronto su temi contemporanei, mettendo in luce e facendo dialogare alcune tra le voci più influenti del panorama culturale italiano.
Tradimenti e infedeltà letterarie: il primo incontro con Lagioia
Il primo incontro, dal titolo “Tradimenti, bugie e altre infedeltà letterarie“, è stato presentato da Nicola Lagioia, scrittore, sceneggiatore, conduttore radiofonico e direttore editoriale del magazine Lucy. sulla cultura, il quale ha dialogato con Claudia Durastanti, anche lei scrittrice e traduttrice nonché finalista (o vincitrice, se confermato) del Premio Strega. Il tema trattato è stato quello del tradimento, inteso non solo in senso sentimentale ma anche come dinamica sociale e culturale. Il filo conduttore del dibattito è stata la conversazione, che ha attraversato i confini tra realtà e scrittura. “Un’occasione per riflettere anche su una città come Napoli, con la sua storia stratificata e la sua resilienza ai cambiamenti” – cita Lagioia.
Il programma ricco di voci e tematiche
Il calendario con gli altri eventi in programma proseguirà giovedì 22 maggio con Antonella Lattanzi e Guido Vitiello in “È tutta scena! Tra cinema, serie tv e social”, dove si parlerà del bisogno di rappresentarsi al giorno d’oggi e del confine tra realtà e finzione.
Poi il 26 giugno, Giulia Muscatelli e Kenta presenteranno “Incoscienti giovani: conflitti generazionali e dialoghi sull’amore”, dove si porrà uno sguardo sulle nuove sfide generazionali e sui linguaggi giovanili. Andando avanti con la rassegna, giovedì 25 settembre Vito Mancuso sarà presente per “Tutto quello che ho capito finora sull’amore”, con una lezione aperta dedicata al sentimento, affrontato attraverso la religione – Mancuso è teologo – la letteratura e la storia. Infine, giovedì 23 ottobre ci sarà la chiusura con Silvia Bencivelli e Ilaria Gaspari in “Napoli, una magnifica invenzione della mente”, un dialogo tra scienza e filosofia per indagare il pensiero umano e le sue rappresentazioni.
Il progetto, gratuito, è stato realizzato da Lucy Agency, la concessionaria esclusiva della rivista Lucy. Sulla cultura e Lucy. sui mondi. Si propone come modello di cultura partecipativa; è possibile partecipare gratuitamente previa semplice prenotazione.
Con Dialoghi, Napoli si conferma capitale della cultura viva e condivisa, capace di mettere in relazione arte, scienza, pensiero critico e partecipazione civica.