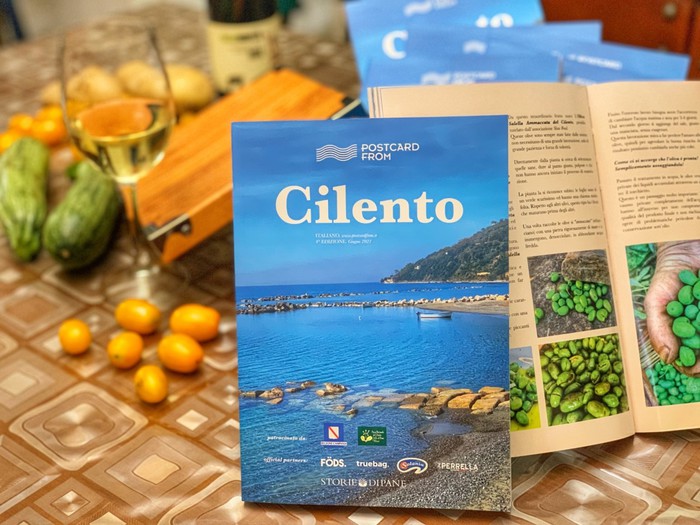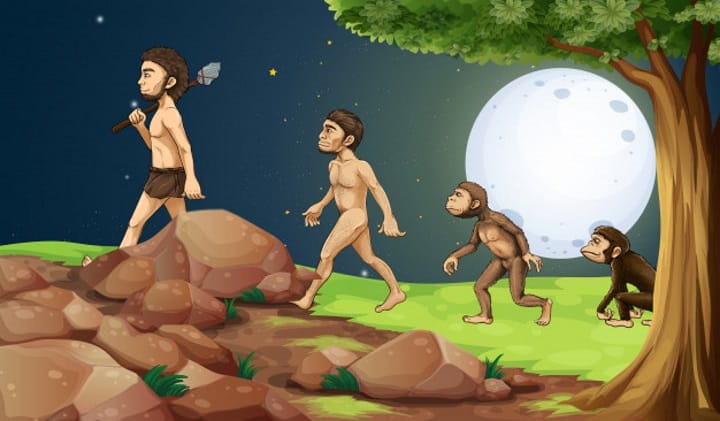Lo Studio Ghibli è uno degli studi d’animazione più discussi e amati dell’ultimo ventennio. È riuscito a far breccia nei cuori di milioni di appassionati scalzando giganti americani come la Disney, la DreamWorks e la Pixar. Ormai sono poche le persone che non hanno mai almeno sentito parlare de Il Castello Errante di Howl (ハウルの動く城, 2004) o del film vincitore del premio Oscar come miglior film d’animazione nel 2003, La Città Incantata (千と千尋の神隠し, 2001).
Tuttavia, celati dietro agli splendidi fondali e alle storie fantastiche di eroine ed eroi in due dimensioni, ormai diventati una cifra stilistica dello Studio Ghibli, non è raro trovare sottotrame che trattano dell’importanza di guerra e memoria.
Analizziamo i principali lavori dei due cofondatori dello Studio, Miyazaki Hayao e Takahata Isao, che affrontano questi temi.
Takahata Isao
Nel 1988, nelle sale cinematografiche giapponesi, debuttava Hotaru no Haka (火垂るの墓, Una tomba per le lucciole), diretto da Takahata Isao. Il film, basato sull’omonimo racconto semi-autobiografico di Nosaka Akiyuki (野坂 昭如, 1930-2015) del 1967, sposta lo sguardo dai due epicentri dell’olocausto atomico alla città di Kōbe. Così facendo, offre un’analoga prospettiva devastante sull’ingiustizia della guerra attraverso la tragica vicenda dei due giovani protagonisti Seita e Setsuko, costretti a soccombere di stenti durante la carestia post-bellica.
I passanti che, il 21 settembre 1945, ignorano il corpo senza vita di Seita nella stazione di Kōbe, diventano l’emblema di una società desensibilizzata e profondamente segnata dal trauma del conflitto mondiale.
Tale rappresentazione avvalora la tesi del critico letterario Nakano Kōji (中野孝次), secondo cui il ritardo nella diffusione della genbaku bungaku (原爆文学, letteratura della bomba atomica) non dipende solo dalla censura, ma anche da un desiderio endemico di dimenticare l’accaduto e la discriminazione nei confronti degli hibakusha.
Grazie a opere come Una tomba per le lucciole, però, guerra e memoria sono state incise per sempre nella storia, ormai impossibili da ignorare o dimenticare.
Miyazaki Hayao
Dopo Takahata, anche Miyazaki ha esplorato il tema della guerra, in maniera trasparente e diretta (tende ad essere un sottotema di numerosi suoi film), attraverso opere come Kurenai no Buta (紅の豚, Porco Rosso, 1992) e Kaze Tachinu (風立ちぬ, Si alza il vento, 2013).
Nel primo, ambientato tra le due guerre mondiali, la maledizione che trasmuta l’aviatore italiano Marco Pagot in maiale, diventa metafora dell’assurdità e della disumanizzazione che la guerra porta con sé.
Col secondo, raccontando la vita di Horikoshi Jirō, progettista del caccia Zero, Miyazaki Hayao esplora come l’amore per l’ingegneria aerea si scontri con il dolore causato dal suo impiego bellico.
Questi personaggi, pur afflitti da perdite devastanti e immersi in mondi segnati dalla distruzione, non smettono mai di sognare. Essi riflettono l’ostinazione dell’immaginazione umana, la capacità di proiettarsi verso un domani migliore, anche se incerto.
Lo Studio Ghibli e la letteratura atomica
Il parallelismo tra i più grandi successi a tema bellico dei due colossi giapponesi dell’animazione con il più grande scrittore della letteratura atomica, Hara Tamiki, è inevitabile. Come loro, Hara continuava a sognare: della sua Hiroshima, di sua madre e sua sorella, di sua moglie Sadae (venuta a mancare un anno prima della fine della Seconda guerra mondiale, dopo una lunga battaglia con la tubercolosi) e della vita che aveva conosciuto prima dell’atomica. Nonostante alla fine si sia tolto la vita, arrendendosi al peso del suo dolore, attraverso la sua prosa, la sua voce ha continuato a risuonare, offrendo alle generazioni future non solo una testimonianza dell’orrore, ma anche un toccante invito a non dimenticare e a riflettere sull’indissolubile natura di guerra e memoria.
Fonte immagine: Depositphotos