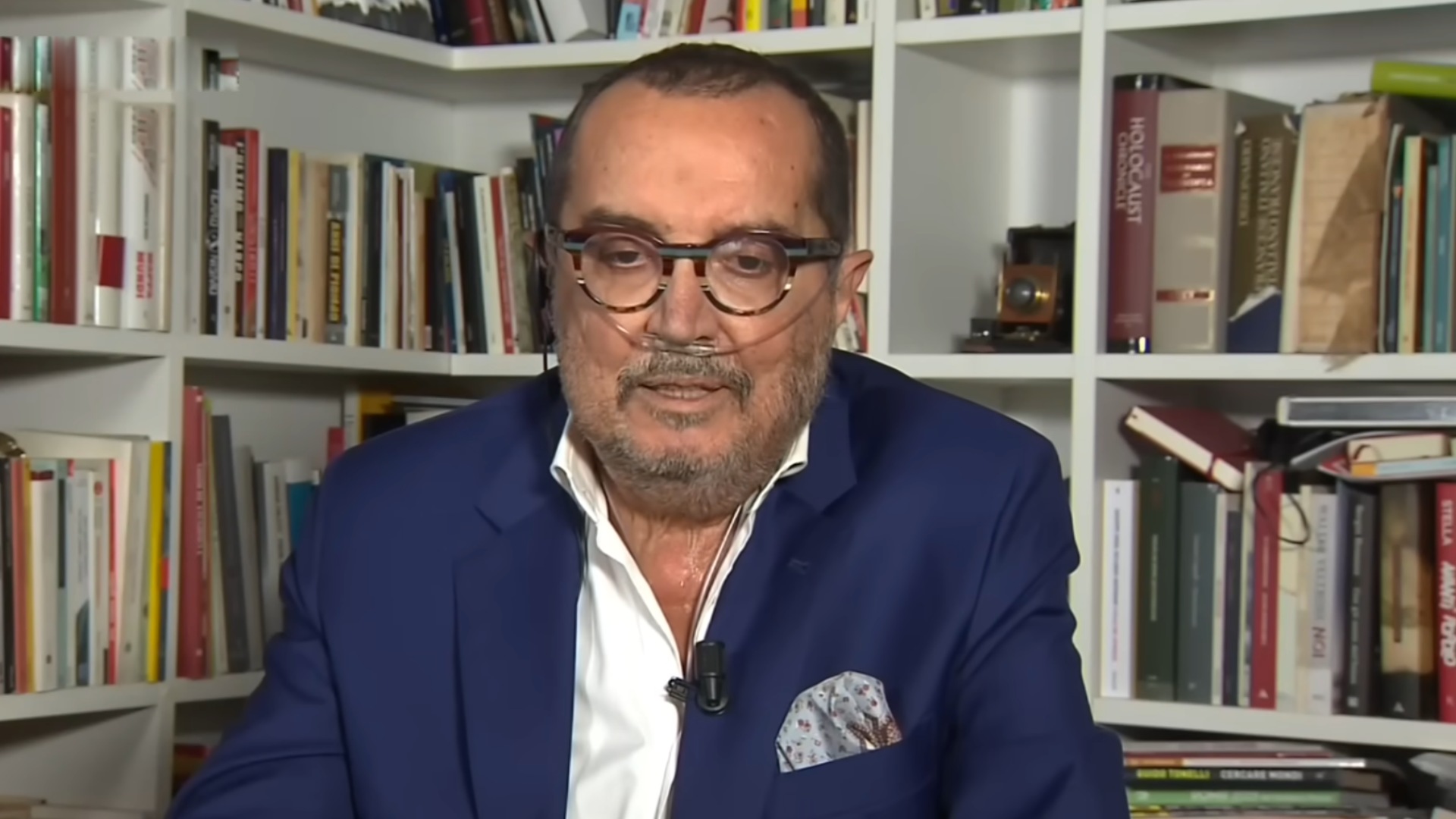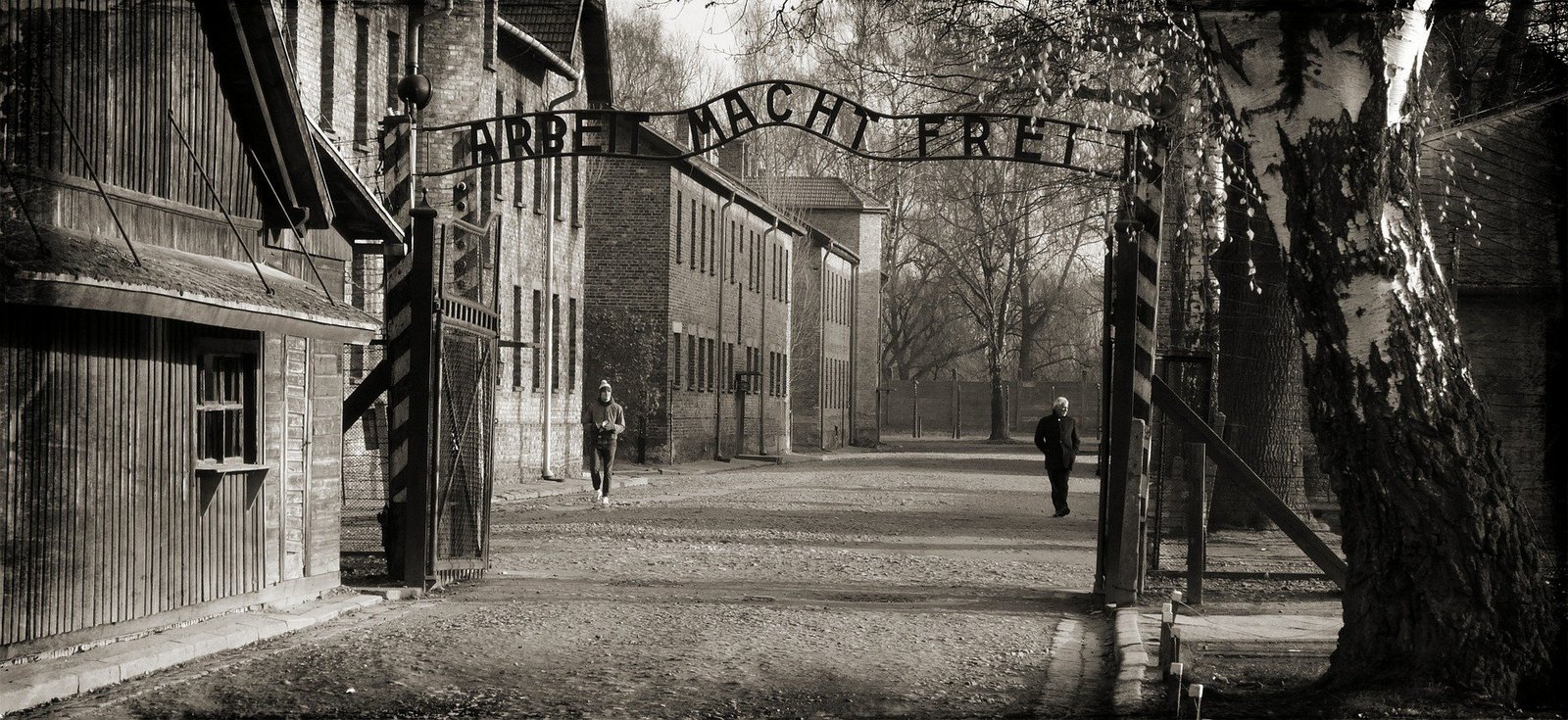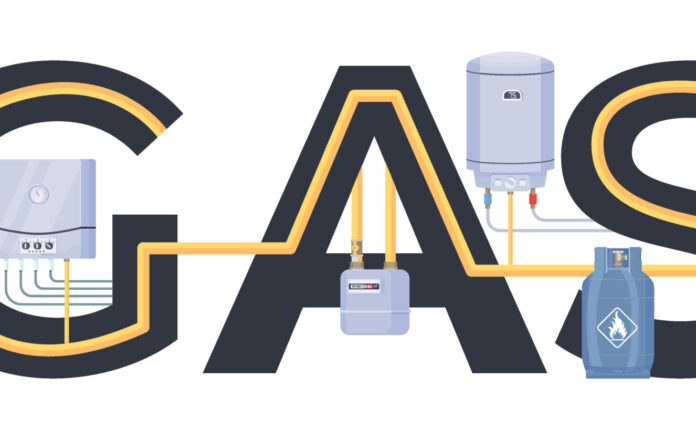I test di ammissione all’università rappresentano un metodo di valutazione che ha lo scopo di selezionare gli studenti per l’accesso a determinati percorsi di studio. In Italia, l’accesso programmato è stato normato in modo strutturato con la Legge 2 agosto 1999, n. 264, per regolare i flussi di iscritti in alcuni corsi di laurea.
Indice dei contenuti
Tipologie di accesso programmato in Italia
È importante distinguere tra due tipi di “numero chiuso”. Esistono corsi a programmazione nazionale, i cui test e modalità sono definiti direttamente dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Questi includono:
- Medicina e chirurgia;
- Odontoiatria e protesi dentaria;
- Medicina veterinaria;
- Scienze della formazione primaria;
- Architettura.
Molti altri corsi, invece, prevedono un numero chiuso a programmazione locale, stabilito in autonomia dai singoli atenei in base alle risorse disponibili. Per l’accesso a questi ultimi, così come per la verifica delle conoscenze iniziali, molte università si affidano ai test TOLC erogati dal consorzio CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), che rappresentano ormai uno standard per un’ampia gamma di facoltà.
Pro e contro dei test di ammissione
L’utilizzo dei test selettivi è da sempre oggetto di opinioni contrastanti. Generalmente, si sostiene che siano necessari per migliorare la qualità del percorso formativo e il rapporto tra docenti e studenti. Vediamo nel dettaglio le principali argomentazioni a favore e contro.
| Argomenti a favore dei test di ammissione | Argomenti contro i test di ammissione |
|---|---|
| Valutano le conoscenze specifiche necessarie per affrontare un determinato percorso di studi, selezionando studenti preparati. | Limitano il diritto allo studio e il principio di pari opportunità, garantito nelle moderne democrazie. |
| Offrono un metodo di valutazione standardizzato e oggettivo, riducendo il rischio di favoritismi e gestendo un gran numero di candidati. | Possono non riflettere le reali capacità dello studente, che ha una singola opportunità condizionata da ansia e stress. |
| Gestiscono in modo sostenibile le risorse pubbliche (aule, laboratori, docenti), che sono per definizione limitate. | Creano disuguaglianza, favorendo chi può permettersi corsi di preparazione costosi e risorse aggiuntive. |
| Contribuiscono a ridurre il tasso di abbandono universitario, ammettendo studenti più motivati e consapevoli della scelta fatta. | Generano forte pressione psicologica, con un impatto negativo sulla salute mentale degli studenti. |
Il dibattito attuale e le possibili alternative
Negli ultimi mesi il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, si è più volte espresso contro i test, con un riferimento particolare alla facoltà di Medicina. Secondo il Presidente, tali metodi non misurano le reali competenze, ma si basano su quesiti che hanno poco a che fare con gli studi futuri. Il CISIA ha ribattuto alle parole del governatore, sostenendo che i quesiti vengono preparati in maniera professionale e coerente con i percorsi a cui gli studenti aspirano. Il dibattito non si limita alla critica, ma riguarda anche i modelli alternativi. Una delle proposte più discusse è il cosiddetto “modello francese”, che prevede il libero accesso al primo anno e una selezione severa basata sugli esami sostenuti per poter proseguire gli studi. Diversi atenei stanno già valutando sistemi misti per integrare la valutazione dei test con altri fattori, come il rendimento scolastico.
In conclusione, la questione dei test di ammissione rimane complessa, con validi argomenti da entrambe le parti. La sfida consiste nel bilanciare la necessità di una formazione di qualità con il diritto all’accesso universale agli studi, come previsto dalla normativa di riferimento, tra cui la già citata legge 264 del 1999.
Articolo aggiornato il: 21/09/2025