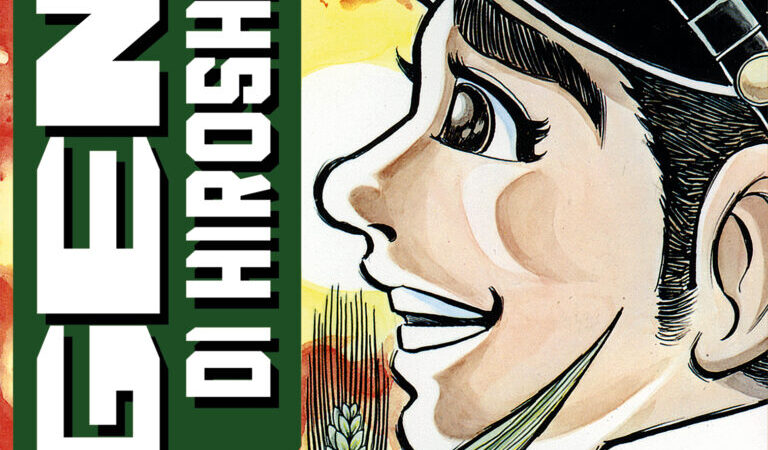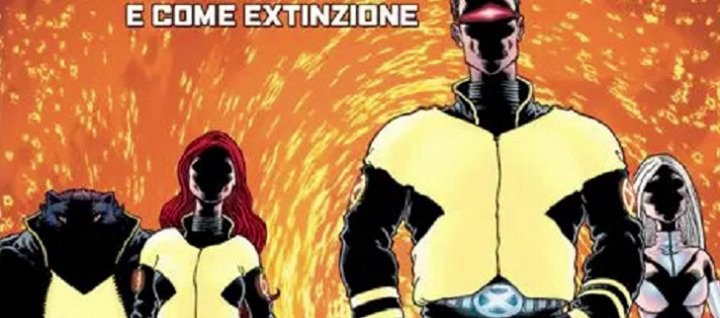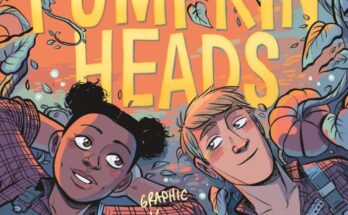La narrazione post-apocalittica a fumetti raggiunse il suo apogeo nel 1973, con l’inizio della pubblicazione di Hadashi no Gen (はだしのゲン, “Gen a piedi scalzi“, in Italia pubblicato come “Gen di Hiroshima“), nato dalla penna di Nakazawa Keiji.
L’autore, nativo di Hiroshima, e sua madre furono gli unici della famiglia a sopravvivere all’esplosione del Little Boy.
Con la sua magnum opus, Keiji riuscì a compiere qualcosa di impensabile per l’epoca, dimostrando che era arrivato il momento di raccontare l’irraccontabile e che eventi di simile caratura storica ed emotiva potevano essere veicolati dal fumetto in maniera inedita ed eccellente.
Le premesse del fumetto
Il piccolo Nakaoka Gen è lo specchio dell’infanzia dell’autore, non nel ritratto fittizio della gioventù che gli venne negata ma nella dolorosa cronaca di ciò che fu costretto a vivere: incarna l’amore per la vita, il disprezzo per la guerra e la speranza per un futuro migliore.
La frase «come sempre, sono i più deboli e anonimi a morire in guerra per pochi potenti», accompagnata dall’orribile sfondo della disperazione che ha seguito l’esplosione della bomba, è un grido di protesta contro l’ingiustizia della guerra: un capriccio di pochi eletti che costa la vita a milioni di innocenti. Custode del prezioso ricordo di suo padre, artista dal forte spirito sovversivo e antimilitarista, il fumettista riversò nelle sue tavole gli ideali da lui tramandati.
Nel primo volume, al protagonista e ai suoi compagni di classe viene assegnato il compito di comporre dei seikatsu tsuzurikata (生活綴り方, letteralmente “composizioni letterarie di vita”), cronache di vita reale scritte dagli studenti come esercizio per discernere la realtà dalla finzione e da inviare ai soldati al fronte. Gli altri bambini, nelle loro brevi composizioni, augurano la morte agli avversari e tessono le lodi del Giappone, terra degli Dei e del Vento Divino. Il piccolo Gen, erede dello spirito del padre di Nakazawa, rappresenta un elemento dissonante per lo standard giapponese dell’epoca: fortemente convinto di non voler svendere i propri principi pacifisti, va fiero di considerarsi figlio di suo padre, e non dell’imperatore o della Nazione, nonostante venga visto come un traditore dal suo dispotico insegnante.
Ne è una chiara dimostrazione il momento in cui afferma: «Il mio papà dice che il Giappone non dovrebbe fare la guerra. La Guerra toglie la vita alle persone e distrugge ogni cosa… anch’io la penso così. Cari soldati, non morite per favore. Sarebbe un grande dispiacere per i vostri genitori».
Gen di Hiroshima nel contesto storico
Il fumetto è un caso assurdo di irriverenza anacronistica: i suoi personaggi non sono solo contrari agli ideali imperialisti, ma li disprezzano. Non hanno remore a incolpare l’imperatore, “l’assassino supremo” per ciò che è successo, assieme ai ministri funzionari del gabinetto Tōjō e i capi militari dell’esercito e della marina che avevano «iniziato la guerra con la superbia di chi pensa che basti combattere per vincere». L’opera si conclude con l’affermazione che la definitiva conclusione del conflitto fosse stata spinta soltanto dall’orrore e della distruzione portate dalle bombe atomiche, che avevano aperto gli occhi del mondo intero sull’insensatezza della guerra. Inoltre, il protagonista sostiene che tutti i paesi del mondo sono debitori a Hiroshima e Nagasaki per aver dimostrato quanto fossero spaventosi gli effetti degli ordigni nucleari, impedendo una guerra che avrebbe provocato l’estinzione della vita sulla Terra.
Gen di Hiroshima si conclude con un toccante messaggio di resilienza; il ricordo di suo padre riaffiora tra le lacrime del protagonista, mentre è sul treno che lo sta portando via dalla città in cui è cresciuto. Le parole «Gen, sii come il grano, che mette i germogli in pieno inverno… che per quanto calpestato, pianta salde le sue radici nel terreno e cresce forte e dritto fino a portare i suoi frutti» sono incise nella sua memoria: un indelebile testamento paterno. Gen abbraccia l’idea di diventare come il grano maturo, rifiutando la possibilità di farsi sconfiggere, qualunque dolore dovesse assalirlo: «vivrò, virò, sopravvivrò fino alla fine».
Conlcusioni
Ad oggi, Hadashi no Gen e Maus, il memoir a fumetti di Art Spiegelman (basato sull’esperienza del padre, sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti), sono tra i principali lavori impegnati a mantenere vivo il triste ma imprescindibile ricordo della disumanità della guerra, attraverso la semplicità e la dolcezza tipiche della letteratura a fumetti.