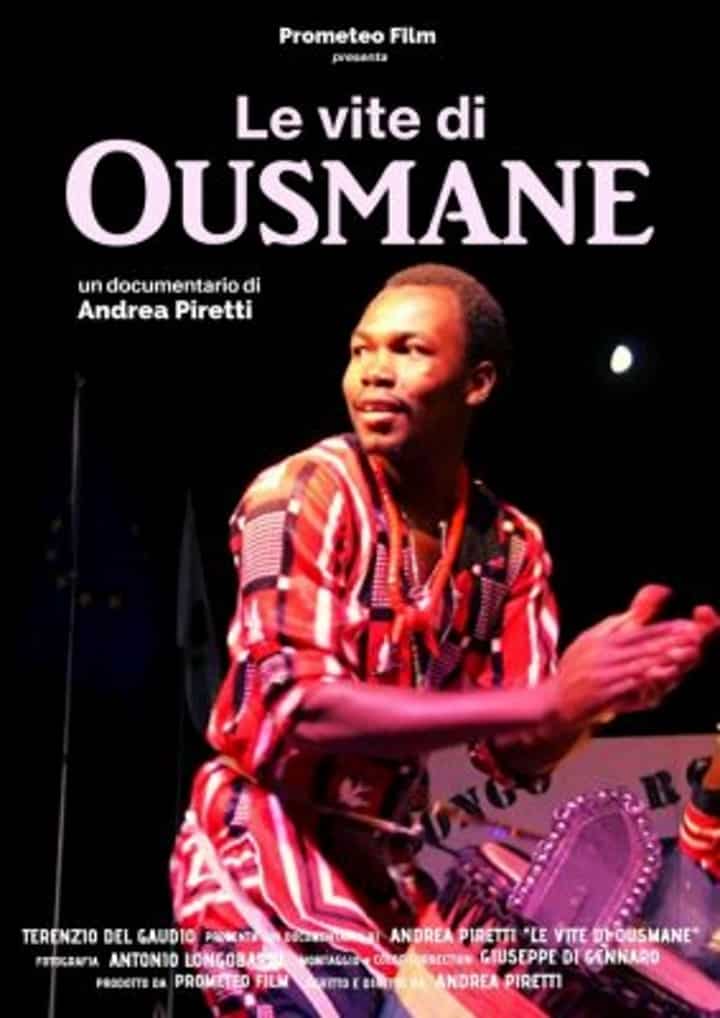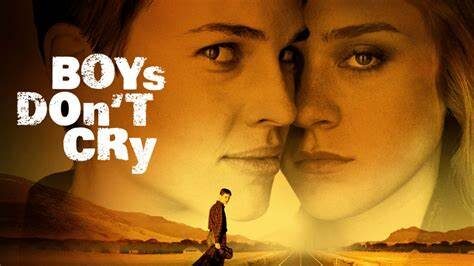Il film Fratelli di carne della regista Paola Beatrice Ortolani sarà proiettato, in occasione della rassegna NiC – Napoli in Cinema, il 18 dicembre presso il Cinema Vittoria di Napoli, inaugurando la manifestazione cinematografica che anima il capoluogo partenopeo dal 2022.
Nello specifico Fratelli di carne è un’opera che attua un profondo scavo negli archetipi dell’inconscio e che indaga sul significato della colpa e su quello dei conflitti interiori. Paola Beatrice Ortolani, attraverso la storia di Luigi (Corrado Taranto), Michele (Giovanni Battaglia) ed Anna (Simona Buono), rievoca il sentimento di irrisolto interiore che attanaglia gli esseri umani, quella “terra del rimorso”, citando uno dei capolavori dell’antropologo Ernesto De Martino, che è sfondo emotivo delle azioni umane. Il film, attraverso suggestioni, sguardi e silenzi, estremamente eloquenti, racconta di una ferita interiore e di un tentativo di redenzione posto in atto attraverso il recupero di un io frammentato.
Paola Beatrice Ortolani trasferisce sulla pellicola numerose suggestioni inerenti all’immaginario archetipico di cui ogni spettatore attento è in grado di riconoscerne i simboli universali.
Fratelli di carne: intervista a Paola Beatrice Ortolani
Paola Beatrice Ortolani, il tuo Fratelli di carne è un film ricco di suggestioni che sembrano richiamare gli archetipi dell’inconscio. Come lo hai concepito e sviluppato?
Fratelli di carne è nato in seguito alla mia prima visita alla Grotta di San Michele Arcangelo a Olevano sul Tusciano, un luogo che già al primo ingresso ha risvegliato in me un immaginario ricco di mistero. Infatti, questa grotta, in epoca medievale, era meta di pellegrinaggio: i penitenti affrontavano la ripida salita portando con sé delle pietre proporzionate alla gravità delle proprie colpe, come gesto di espiazione. Quest’atto fisico, che materializzava un peso interiore, è diventato il cuore del cortometraggio. Il protagonista, Michele, incarna proprio questa dualità: il peso di un’azione che porta con sé conseguenze irreversibili unito al peso che deriva dal dover convivere con un senso di colpa così grande. Attraverso il suo percorso, ho voluto esplorare temi universali come la colpa, l’espiazione e la redenzione, intrecciando le mie suggestioni personali con i racconti delle persone del luogo, che mi hanno parlato di storie di litigi familiari, emigrazioni e tradimenti. Questi frammenti di vita reale hanno permesso agli archetipi universali di emergere in un contesto locale, rendendoli quindi più autentici e concreti. Ho poi lavorato sugli elementi simbolici cercando di integrarli con naturalezza nel racconto, senza forzature.
La vicenda dei due “fratelli di carne”, Michele e Luigi, si snoda attraverso la figura, carnale anch’essa, di Anna. Cosa hai tenuto presente per creare i rapporti psicologici (espressi, almeno inizialmente, con i soli sguardi) che intercorrono tra i protagonisti di questo triangolo?
Per costruire i rapporti psicologici tra i protagonisti, sono partita proprio da Anna: lei è una ragazza bella, libera e inconsapevole del proprio potere seduttivo. Essendo stata amica d’infanzia di Michele e Luigi (vivono nello stesso paesino in cui più o meno si conoscono tutti), si relaziona con loro come quando erano bambini, senza accorgersi che però ormai sono adulti, con desideri e pulsioni completamente diversi. Come spiegai all’attore Amato D’Auria, che interpreta Michele, Anna è “inconsapevolmente crudele”. Non c’è malizia nelle sue azioni, ma una leggerezza che rischia di ferire chi la circonda. Poi ho lavorato molto sulla dinamica familiare tra i due fratelli. Ad esempio, una scena tagliata li mostrava da bambini: Michele in difficoltà, portato da Luigi a esplorare l’uliveto di notte, ma lasciato in balia delle sue paure, deriso invece che aiutato. Questo momento racconta una rivalità innata tra i due (come poi si vede anche nel flashback dell’altalena), che non è solo frutto delle circostanze, ma anche della loro diversità caratteriale. Michele è timido, goffo, con un’anima più introspettiva; Luigi, invece, è sveglio, estroverso e già da bambino sembra un piccolo adulto. Ho cercato di tradurre questa complessità psicologica attraverso gli sguardi, che spesso rivelano ciò che le parole non dicono.
Il ritorno di Michele al suo paese d’origine non è un semplice fare i conti col proprio passato; piuttosto pare significare recupero del proprio io frammentato, un ritorno nel grembo materno (da egli stesso violato) della propria terra. Cosa puoi spiegarci a proposito di questo?
Il ritorno di Michele al suo paese d’origine, anche se motivato dalla richiesta di Anna, rappresenta qualcosa che va oltre il semplice confronto con il passato. Credo che Michele portasse dentro di sé, anche inconsciamente, il desiderio di affrontare le sue ferite legate a quel luogo, ma che avesse cercato di ignorarlo per riuscire a sopravvivere. La grotta, in questo senso, assume un significato simbolico centrale: è un “ventre della terra”, uno spazio primordiale e materno dove si è costretti a confrontarsi con le proprie ombre. Entrarci significa accettare di attraversare un processo di trasformazione, un percorso intimo e doloroso per ritrovare se stessi e, in qualche modo, ricomporsi.
Vedendo Fratelli di carne, è parso di cogliere uno stretto legame tra la figura, angelica e passionale, di Anna e l’immaginario del paese d’origine: come ha connotato il rapporto dei protagonisti con la propria terra?
Il legame tra i protagonisti e la loro terra è stato reso principalmente attraverso dettagli visivi e linguistici. I costumi, ad esempio, sono stati pensati per sottolineare questa connessione: Luigi (interpretato da Corrado Taranto), fortemente legato alla tradizione, lavora nell’azienda di famiglia e il suo abbigliamento, sia da giovane che da anziano, ne rispecchia l’appartenenza al mondo rurale. La sorella Agnese, interpretata da Dora Romano, incarna il ruolo della tipica donna di famiglia, sempre impegnata in cucina e nelle faccende domestiche. Michele, invece, è un personaggio che appare fuori dal coro, estraneo non solo nei modi ma anche attraverso il linguaggio. Ho scelto Giovanni Battaglia per interpretare Michele proprio per questa ragione: essendo originario del Nord Italia, il suo distacco culturale e linguistico rispetto agli altri personaggi si riflette anche nel modo in cui parla, rendendo più autentico il senso di estraneità che lo contraddistingue.
A proposito dell’ambientazione, essa non sembra essere il mero sfondo su cui si intrecciano le vicende dei personaggi, ma, attraverso scorci e sfondo, il ‘paese’, così come è definito nel film, assume una fisionomia preponderante nello sviluppo psicologico dei personaggi, quasi un ulteriore personaggio tra i personaggi. In che modo hai definito l’ambientazione?
Ogni ambientazione non è mai casuale, ma pensata per rispecchiare e amplificare le emozioni e i conflitti dei personaggi e per costruire il senso profondo della storia. Il frantoio Fierro, ad esempio, è stato fondamentale non solo per le scene interne e per la scena della festa, ma anche per il significato che porta con sé: è stato il proprietario, Luigi, a raccontarmi tante storie legate a tradizioni, amori e famiglie emigrate, che hanno ispirato alcuni dettagli del racconto. Anche i vasti uliveti di Olevano sono un elemento cruciale nell’ambientazione di Fratelli di carne. L’ulivo, infatti, è da sempre simbolo di pace, ma nel contesto del film acquista un valore più profondo; con la sua longevità e solidità, rappresenta la speranza di una riconciliazione. La fontana, che attinge direttamente alla sorgente e scorre di continuo, è un simbolo di rinnovamento e purificazione; non a caso, l’acqua attraversa tutto il cortometraggio come un filo conduttore, assumendo un valore “battesimale”. Infine, il convento abbandonato, luogo in cui si consuma lo stupro, è stato scelto per la sua forza evocativa: un luogo isolato e decadente, perfetto per rappresentare la perdita di purezza e l’irruzione del male.
Il mondo rappresentato è un mondo ancora fondato sulle tradizioni: il coprire lo specchio nelle stanze in cui giacciono i defunti, la tarantella e il suono della tammorra, la presenza del vernacolo… In che modo ciò contribuisce a restituire il senso di un ritorno archetipico alle proprie radici recise?
Penso che le radici familiari siano difficili da spezzare, nonostante i tentativi di allontanarsi. L’atto di coprire gli specchi, ad esempio, non è solo un rito funerario, ma un atto di protezione e di separazione dal mondo dei vivi, un simbolo del passaggio ad un’altra dimensione: è anche quello che ha fatto Michele all’epoca dei fatti, fuggendo via dal suo paese. La tarantella e il suono della tammorra sono legati a riti ancestrali di esorcismo: la danza e la musica servono a provocare un’esplosione di energia vitale che permette ai personaggi di confrontarsi con le proprie ombre, proprio come accadeva nella grotta di San Michele Arcangelo in epoca medievale, dove venivano effettuati dei veri e propri esorcismi nei confronti delle persone che venivano ritenute affette dal “morso dalla tarantola”. Esprimersi in dialetto è un atto di rivendicazione della propria identità culturale e familiare, un ritorno a una lingua che è legata alla memoria storica; in questo caso, però, ha anche la funzione di aumentare il distacco che c’è tra Michele e il resto della famiglia.
Sono molteplici, come si diceva, gli spunti che Fratelli di carne può offrire: la ricorrenza del colore rosso e quella dell’acqua, l’immaginario legato alla tammorra e alla tarantella, le figure di Agnese e di suo nipote, la presenza e l’assenza del dialetto in Luigi e Michele… Soffermandoci sul titolo, esso sembra contenere molteplici allusioni riferite a Luigi e Michele: fratelli ‘carnali’, nati dal medesimo grembo; fratelli in quanto figli della stessa terra; fratelli in quanto presi dalla medesima passione per la stessa donna; Fratelli di carne, però pare recare una significanza più ampia che parla ad ogni individuo, ‘fratello di carne’ di se stesso. Cosa puoi dirci a proposito di questo titolo?
La “carne” simboleggia quella parte più vulnerabile e istintiva dell’essere umano che spesso guida le azioni, ma che può anche distruggere. La carne è sia un legame che una separazione: da un lato, Michele e Luigi sono fratelli appunto “carnali”, figli della stessa terra e dello stesso grembo materno; dall’altro, il legame tra loro è spezzato proprio dalla carne, dall’intensità di un desiderio che coinvolge Anna, la figura che diventa il catalizzatore del loro conflitto. Ma in senso più ampio, il concetto di “fratelli di carne” va oltre la relazione tra i due protagonisti, si riferisce a quel legame universale che ogni individuo ha con se stesso, con la propria carne, i propri desideri, le proprie contraddizioni e i propri conflitti interiori. È il confronto con la propria vulnerabilità e con le ombre che abitano in ciascuno di noi.
Immagine di copertina: da Fratelli di carne di Paola Beatrice Ortolani.