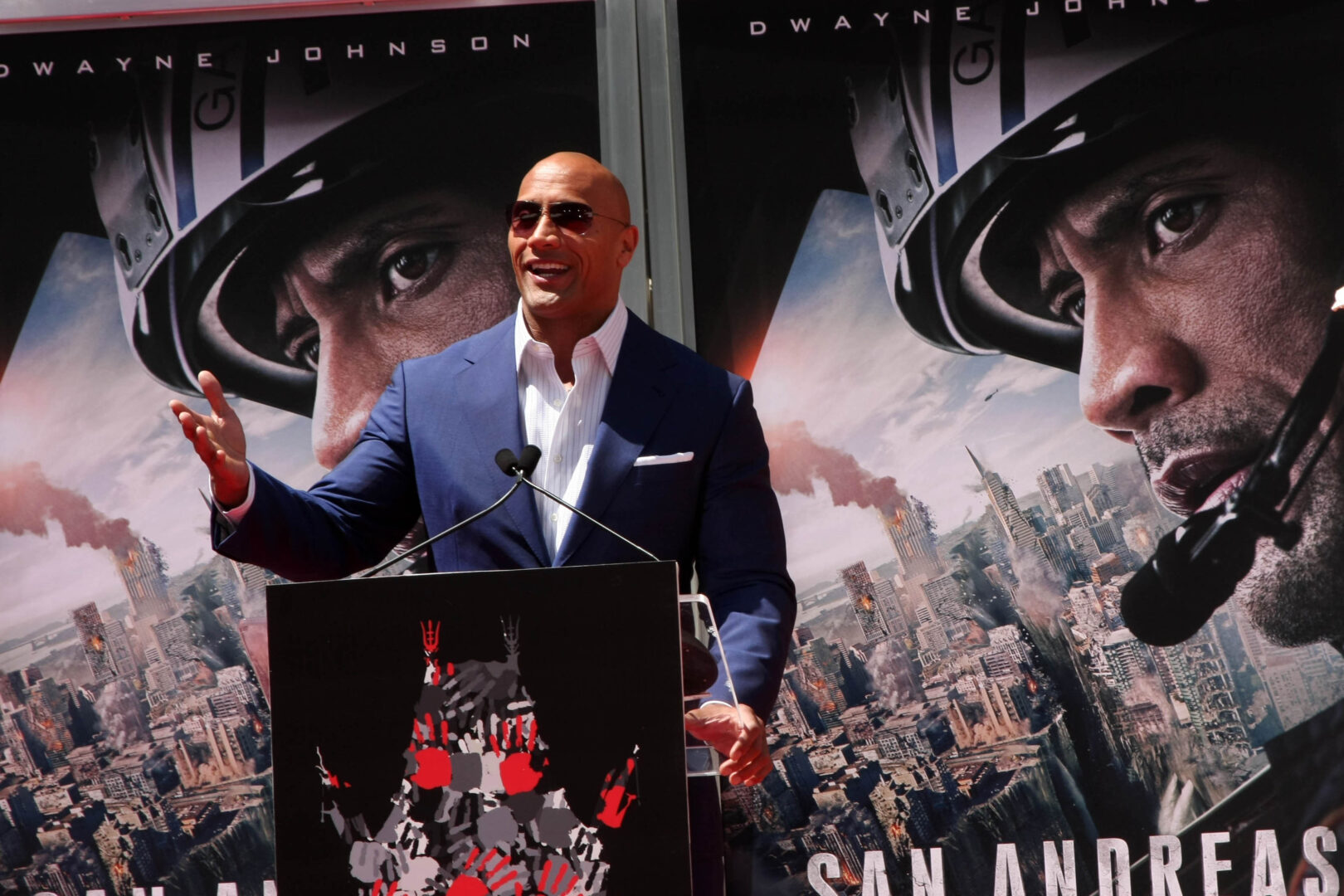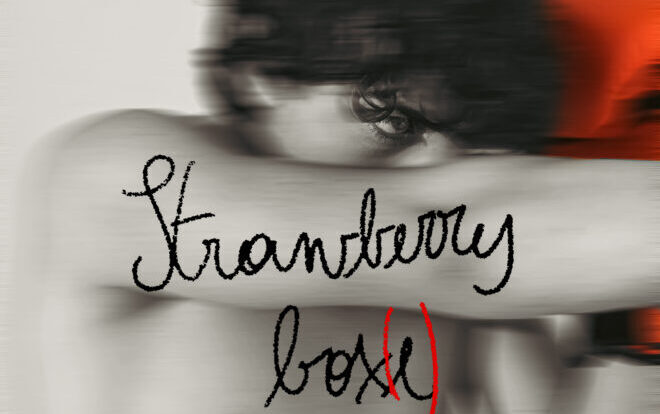Dopo la morte di Mao Zedong nel 1976, la Cina si trova in condizioni economiche disastrose dopo la Grande Rivoluzione Culturale (1966-69), un’ideologia ormai delegittimata ed un grosso problema da risolvere: ciò che il partito avrebbe voluto veicolare, come doveva presentarsi e cosa doveva fare per avere il supporto del popolo, ormai astioso dopo le ingenti perdite della rivoluzione. Con Deng Xiaoping, leader del partito comunista cinese dal 1978 al 1992, abbiamo un cambio di rotta, tutto ciò che Mao temeva quando prese in mano le redini del potere ideologico si era avverato: il comunismo si avviava ad una borghesizzazione delle classi e al capitalismo. Se negli anni 80’ abbiamo delle politiche di maggiore apertura per distanziarsi da ciò che era successo durante l’era maoista, negli anni 90 ci sarà un cambiamento irreversibile di rotta: l’avvio alla liberalizzazione del mercato e il socialismo di mercato cinese. Gli anni ’80 si concludono nel 1989 con gli eventi di Tienanmen, che rappresentano una svolta epocale, e lo stesso anno segna anche il crollo generalizzato del comunismo in tutto il mondo. Gli eventi di piazza Tienanmen si presentano come proteste di aperta critica al governo a Pechino e in altre città cinesi, queste innescheranno una crisi politica e sociale: il partito avvia una repressione, gli intellettuali sono costretti al silenzio e molti emigrano.
Nel 1992 Deng Xiaoping decide di prendere in mano le redini dell’economia, allontanare i conservatori con visioni maoiste e promuovere riforme economiche mirate allo sviluppo della Cina. Lo sviluppo aveva il compito di creare arricchimento e soddisfazione tra la popolazione, consolidando il consenso popolare per il Partito Comunista, evitando così il destino dei partiti comunisti di altri paesi che erano tutti crollati o sull’orlo del fallimento. Nasce così un nuovo ordine e modello economico: il socialismo di mercato cinese. Jiang Zemin, nuovo segretario del partito, istituisce il progetto di costruzione dell’economia di mercato socialista, che presenta due aspetti contrastanti: da un lato una radicale liberalizzazione economica che trasforma la struttura sociale, dall’altro una persistente autorità politica. Questa visione del socialismo di mercato cinese risulta abbastanza contraddittoria sia a livello ideologico sia per come era stata interpretata l’economia fino ad allora. La liberalizzazione economica comporta un’espansione della sfera privata in Cina, permettendo agli individui maggiore libertà nelle loro vite private rispetto al passato, quando il Partito esercitava un controllo più stretto. Se dal punto di vista economico il socialismo di mercato cinese rendeva l’individuo più autonomo, dal punto di vista politico la reazione agli eventi di Tiananmen interrompe a tempo indeterminato qualsiasi prospettiva di democratizzazione della Cina. Si instaura così una combinazione di libertà economica e autoritarismo politico: mentre l’economia offre grandi libertà, il Partito Comunista continua a governare in modo autoritario. L’obiettivo principale del Partito è che la popolazione lavori e guadagni, senza preoccuparsi della politica, portando quindi ad una progressiva depoliticizzazione della vita sociale, in netto contrasto con il periodo maoista. Per unire la società e dare un senso di identità collettiva, il Partito cerca di fomentare un sentimento nazionalista, spesso utilizzando elementi della cultura tradizionale cinese.
Dal punto di vista letterario e culturale, gli anni ’90 vedono una grande trasformazione: la mercatizzazione della produzione culturale (Shichuanhua, 市场化). Fino agli anni ’80, gli scrittori erano organizzati dallo stato, stipendiati dalle unità culturali, e le loro opere non finivano sul mercato poiché non esisteva un mercato nella Cina socialista. Le opere venivano pubblicate gratuitamente su riviste culturali e circolavano attraverso vari sistemi non a pagamento. Con il crollo di questo sistema negli anni 90’ e l’avvento del socialismo di mercato cinese, gli scrittori devono trovare nuovi modi per guadagnarsi da vivere, come scrivere copioni e script televisivi. Infatti questo periodo vedrà nascere una vera e propria mania che continua ancora ad oggi: l’ossessione dei cinesi per le serie televisive. La commercializzazione, nuovo ideale del socialismo di mercato cinese, infatti, introduce nuove forme di cultura, incluse varie produzioni televisive, la letteratura diventa una nicchia e le serie emergono come forma dominante di narrazione popolare. Queste serie, importanti per comprendere la società cinese, affrontano i problemi della vita sociale con soluzioni conciliatorie all’insegna dell’armonia. Le serie TV devono passare tre livelli di censura prima di essere approvate e mandate in onda, diventano estremamente popolari, ne vengono prodotte centinaia ogni anno e trasmesse continuamente anche per interesse del Partito Comunista, che cercando di promuovere una cultura popolare che educhi i cittadini, ha subito riconosciuto le serie televisive come un utile strumento per la diffusione di valori come il sacrificio personale, la bontà, l’altruismo e delle critiche velate ma leggibili ai nemici del partito. Quali sono serie televisive più famose e amate nate durante il socialismo di mercato?
Negli anni ’90, due serie televisive cinesi si distinsero: “Aspirazioni” ( 1990) e “Pechinesi a New York” (1993). Questi due programmi non solo catturarono l’attenzione del pubblico, ma divennero anche modelli per le produzioni successive, integrando messaggi ideologici e riflettendo le trasformazioni sociali e culturali in corso in Cina che veicolavano proprio il socialismo di mercato cinese. “Aspirazioni” è una serie che ruota attorno alla vita di una donna operaia, una figura buona e altruista, che racconta la sua storia dal periodo della Rivoluzione Culturale fino agli anni ’80. La protagonista, nonostante le avversità, adotta una bambina abbandonata e sposa un intellettuale perseguitato durante la Rivoluzione. Tuttavia, negli anni ’80, quando gli intellettuali riacquistano prestigio, il marito la abbandona, mettendo in luce una critica velata verso l’egoismo degli intellettuali. La trama si conclude tragicamente con la protagonista che rimane paralizzata in seguito a un incidente, ma il messaggio finale è un inno alla bontà e all’altruismo. In questo periodo, il Partito Comunista Cinese iniziò a incoraggiare gli artisti a creare opere che non solo avessero successo commerciale, ma che avessero anche un impatto sociale positivo seguendo i valori del socialismo di mercato cinese. “Aspirazioni” rispondeva a queste aspettative, aumentando la consapevolezza critica del pubblico sui problemi sociali presenti nella società cinese e promuovendo valori positivi legati al socialismo di mercato.
“Pechinesi a New York” è un’altra serie che, in modo diverso, servì a promuovere gli interessi ideologici del governo cinese e del socialismo di mercato cinese. Basata su un romanzo cinese, racconta la storia di due musicisti che emigrano negli Stati Uniti alla fine degli anni ’80 per inseguire il sogno americano, un’idea molto popolare tra gli studenti di Piazza Tienanmen. Tuttavia, una volta arrivati, si scontrano con la dura realtà di una società capitalista spietata. Costretti a lavorare come sguatteri, finiscono per trovare impiego in una fabbrica tessile, proprietà di un giovane americano che ruba la moglie a uno dei protagonisti. Questo evento scatenante porta il protagonista maschile a una spietata competizione con l’americano. Alla fine, apre una fabbrica tessile e sfruttando la manodopera dei connazionali cinesi, riesce a diventare ricco, rovinare il rivale e riprendersi la moglie. La serie presenta una delle prime narrazioni sull’imprenditore di successo cinese, esalta il mito dell’imprenditorialità e incorpora un forte elemento nazionalista presente in quel periodo storico e più vivo che mai nella contemporaneità: la competizione tra Cina e America.
Entrambe le serie televisive non solo intrattennero milioni di spettatori, ma rappresentarono le dinamiche sociali e politiche del tempo come il socialismo di mercato cinese, esplorando temi come il sacrificio personale, l’egoismo intellettuale, la durezza della vita all’estero e la competizione economica, messaggi che il Partito Comunista teneva a veicolare.
Fonte immagine “Il socialismo di mercato cinese: il boom delle serie tv”: wikipedia