“Bestia divina” di Mario Fresa è una raccolta sulla contro-intuitività poetica.
Recensione dell’opera
Sembra un ricacciare in una mano tutto il linguaggio-non linguaggio minacciato da una imminente balbuzie della lingua, del capo e della mano stessa che sorregge, Bestia divina di Mario Fresa, edito La Scuola di Pitagora editrice.
In Bestia divina, infatti, il linguaggio è un mostro ibrido a tre teste: soggetto, predicato, complemento si rassomigliano e si scambiano, nessuna logica semantica li contrassegna. L’umanità pure è mostruosa nella sua risolutezza di essere razionale tanto da intrappolare la bestialità divina della parola: il raziocinio è una trappola in cui quest’ultima si dimena bramando libertà.
Il soggetto poetico qui sfuma, sfugge e si contorce nei versi poiché è il linguaggio stesso il soggetto, il suo regime poetico è l’anarchia.
«Era una lingua, un salto. Mica per noi, mica un insulto. […] Così stordita,/ s’alza dai ragazzi ed è ben fatta:/ ed è prossima a trasformarsi in un/ gemello puro, in un fulmine lavoro di altri tempi./ Oppure che sia fatta, di sicuro,/ di un’altra lingua più aceto./ Qui c’è madre orologio, come un istante nervo./ E poi gambe di esclamativi, miracoli di/ atomici pittori.»
Nella presentazione di Bestia divina, Andrea Corona parla di frase-affetto per cui vale ciò che vale anche per il linguaggio onirico: la frase-affetto non segue le regole di nessun genere di discorso ma sospende o interrompe i concatenamenti, dando vita a un dissidio logico traducibile in un torto alla frase articolata, un torto che dissimula un gioco poetico.
Un gioco che si costruisce intorno all’incompiutezza dell’inafferrabile è quello che si concede Mario Fresa: confondere il lettore, disseminando nei suoi versi leitmotiv e dipanando un personalissimo filo rosso fatto di nomi propri che si ripetono – rimandi letterari ed artistici? – e inconcludenti “Soluzioni finali”, poste in appendice al testo.
Difendere l’intrattabile, difendere l’illogicità dell’onirico equivale a prendersi gioco della razionalità del lettore incallito, il quale si sforza alla ricerca di un senso che sente nascosto ed è anzi convinto di poterlo trovare laddove a scorgersi è solo la parvenza di un non-senso. «Che fare allora, di questi verbi? Il nome c’è/ così allarmato da venirgli addosso. Ma credo proprio / che sia di un altro.» (Parole della morte a sua madre, p. 52). «Oppure, certo, l’alternativa è diventare/ un altro nome; o una mosca, diciamo, d’allegria.» (I Musici, p. 38)
Quello stesso linguaggio che differenzia l’uomo dalle bestie, in Bestia Divina adesso si fa estraneo, non vuole più appartenerci e ci riesce divenendo incontrollabile. Come un usurpato, disserta le articolazioni della frase e il poeta è il «Vero soldato /pronto a morire per una lingua che non passa/ più mercato[…] Soldato che diventa puro crollare,/ colla di ballerina; una sonora mente/ di balbuzie!»
Oscura ed enigmatica, in preda alla frenesia del nominare il possibile, un quotidiano che ci inganna e ci spaesa, la poesia di Mario Fresa ci restituisce alla nostra natura bestiale. Bestie divine, noi uomini che «carnivori e infelici» (da Sparirà, prima poesia della raccolta), «siccome tutto è un puro/ asciugarsi, anzi un odore vocabolario» noi che « siamo piccoli/ mostri perciò uniti» diveniamo nell’ultimo componimento «carnivora felicità».
Infine un interrogativo, un salto: «Siamo più umani senza una lingua?»
Lo abbiamo chiesto all’autore.
Bestia divina: intervista a Mario Fresa
Chiediamo al poeta, giocoliere della parola, se noi “siamo più umani senza una lingua”?
Se la smettessimo di usare la lingua come uno strumento di inganno, di distrazione, di imbroglio, di superstizione, allora sì che saremmo più umani (cioè meno ipocriti, meno trincerati dietro le piccole morali che ci danno l’illusione di stare in pace con la nostra cosiddetta coscienza). Ma poi dovremmo, in questo caso, rinunciare alle bellurie retoriche dei discorsi dei politici, dei preti, degli sbirri, dei governanti, dei burocrati, dei farisei; insomma di tutti i piccoli Jahweh dispensatori di prescrizioni e di leggi.
A me, poi, non interessa l’umano o il disumano, ma… l’oltreumano (direi meglio: il mostruoso, l’impensato o l’impensabile, il non detto, l’abnorme, l’osceno). Ciò che riesce, insomma, a confutare e a vincere, anche soltanto nello spazio di un attimo infinitesimale, i poveri e oscuri limiti entro i quali ci ha costretto la Natura, la dea più orrenda che esista. E sa qual è il mezzo per renderci vittoriosi contro di essa? L’arte.
Nei voluti “dissidi logici” dei componimenti di “Bestia divina”, quanta logica e razionalità ha richiesto il processo poetico di scrittura?
Per quanto mi riguarda, non c’è nessun dissidio logico (che bell’ossimoro!) nei componimenti del libro. Ai miei occhi tutto è trasparente e tutto è stato scritto secondo un preciso significato, secondo una trama ben chiara. Nessuna parola è casuale. Ma questo il lettore non può saperlo. Non si possono spiegare o capire fino in fondo, per nostra fortuna, i processi onirici altrui…
Ricorre con regolarità la metafora animale (il titolo, la copertina – Loredana Müller, Locuste dell’abisso -, l’animalesco citato nei componimenti, che molto spesso prende le forme di un cane) e insieme anche quella mostruosa e infine quella della morte. Che importanza e che significato hanno per Lei l’animalesco, il mostruoso, la morte?
La figura del cane che spesso appare nel libro è un omaggio al travestimento di Mefistofele nel Faust goethiano. Sa chi è Mefistofele? È l’artista ideale (l’anti-uomo, l’antiAdamo) che nega sempre e che sempre si ribella alla logica della morte e della fine, accogliendo in se stesso le alte virtù dell’azione ciclica, dissidente, rivoluzionaria della metamorfosi e del rovesciamento delle leggi naturali e morali. Mefistofele è una contraddizione in termini, comica e tragica. E proprio come l’artista – il grande dimentico di se stesso, illuso dalle sue stesse metamorfosi continue – è appunto una bestia divina.
Torno, dunque, al concetto espresso in precedenza: il cosiddetto mostruoso è, per me, il superamento dell’uomo naturale, che di solito è una specie di fallimento totale. E ribadisco: dell’umano salvo solo coloro che si contrappongono ad esso; cioè gli artisti. Tutti gli altri sono accidenti fisiologici – persone “produttive”, come direbbe qualche nostro ragioniere-governante. Preferisco, dunque, l’uomo del caos (con tutti i suoi atti estremi, inconsueti, prodigiosi) alla rispettabile ordinarietà dell’individuo asservito agli ipocriti orrori del lavoro, della famiglia, delle istituzioni statali o religiose. E preferisco i santi idioti, quelli stanchi del proprio Io e della cosiddetta realtà, ai ragionevolissimi, e noiosissimi, uomini-mercanti che pensano soltanto al loro miserabile incasso quotidiano.
Francisco Goya, Luigi Pirandello (con riferimento a I Giganti della Montagna), Franz… Kafka? È tra le possibilità interpretare queste poesie come un sotteso, voluto dialogo di complicità artistica tra Lei e gli artisti a cui fa riferimento?
Ci sono moltissimi riferimenti, rimandi, citazioni e riprese da opere musicali, pittoriche, teatrali, cinematografiche. Non è il caso di spiegarli o di indicarli minutamente. Il lettore-investigatore li troverà da solo. Franz non è Kafka, come qualcuno ha già suggerito. Si tratta di un personaggio (un ex soldato; un disertore) che era comparso in alcune mie raccolte precedenti (come Uno stupore quieto e Svenimenti a distanza). Lo stesso discorso vale per molti altri personaggi (Emme, Luisa, Luigi, eccetera…). Vivevano già altrove, in libri precedenti, e sono poi rimbalzati nella mia nuova raccolta, Il mantello di Goya, che sarà pubblicata tra un paio di anni. Rimbalzati in una nuova metamorfosi: come il diavolo-cane di cui prima si parlava. Sto costruendo, insomma, per tasselli e per deviazioni, un unico grande libro che è una specie di poemario-romanzo, in cui i frammenti delle storie di vari personaggi ritornano, s’intrecciano, si trasformano, riemergono come in una sorta di infinito gioco dell’oca. Alcuni passi di Bestia divina, per esempio, sono spiegati o integrati nelle raccolte precedenti o successive.
In epigrafe a Bestia divina leggiamo: «Vi sono de’ giorni ch’io non posso fidarmi di me.» Jacopo Ortis, «Non so più cosa son, cosa faccio…» Cherubino. Queste sono citazioni che ci aprono a una perdizione del sé accompagnata da un grande desiderio di ritrovarsi. Mario Fresa ritrova se stesso, un senso, una soluzione, una compiutezza nelle sue poesie?
No, per carità. Arimane mi guardi dal ritrovarmi, dal ritrovare me stesso. L’arte può avere una sua compiutezza, un suo senso; la vita (e la biografia) no. E poi, quale “io” o “me stesso” dovrei ritrovare? Quello di adesso o di un giorno fa o di dieci anni fa? Ma non è meglio dimenticarseli o cancellarli una buona volta, tutti questi importuni “io”? Lascio il “Conosci te stesso” a quelli che vogliono salvarsi l’anima. Io ne ho già abbastanza.
Una dritta per il lettore che decide di addentrarsi in Bestia divina?
Diventate ciò che leggete. Per un attimo, sarete miracolosamente salvi da voi stessi.
Fonte immagine di copertina: La scuola di Pitagora editrice.

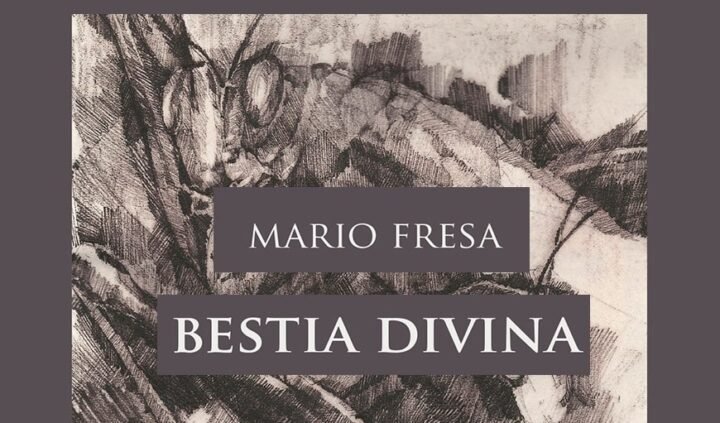



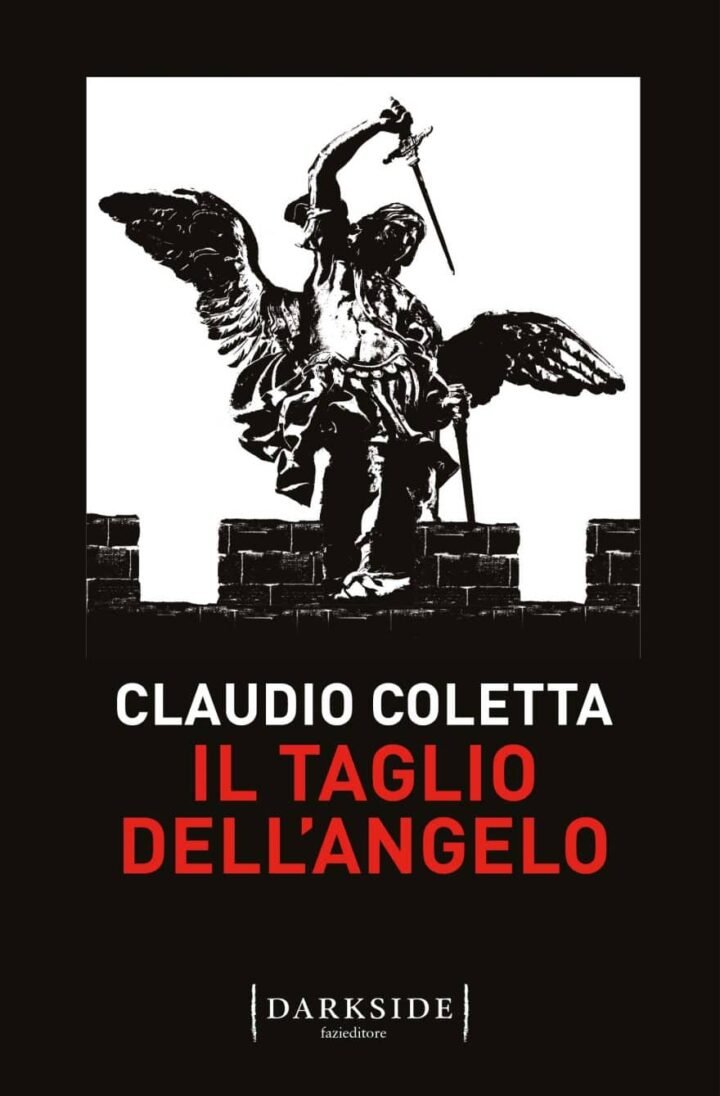


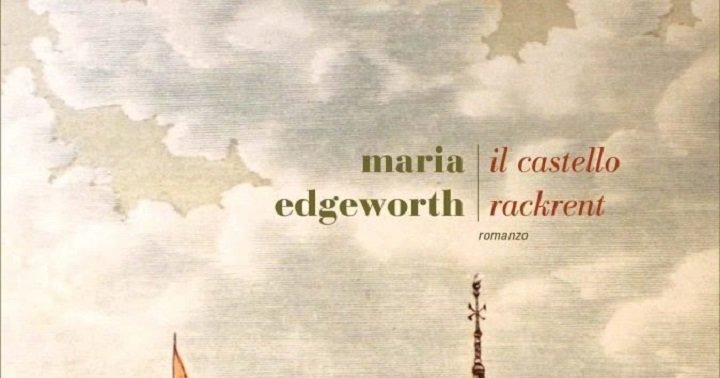


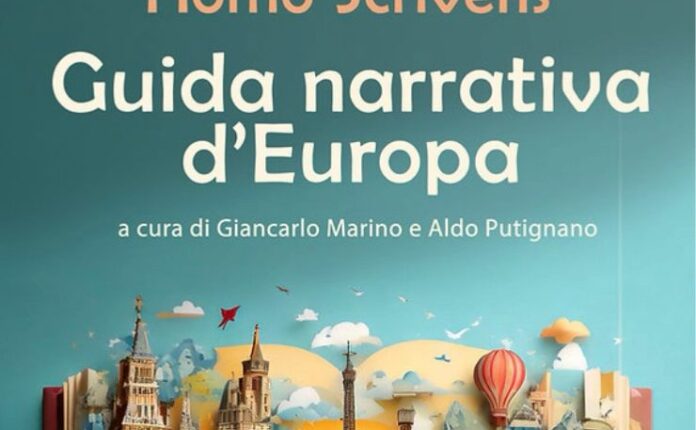
2 Comments on “Bestia divina: il gioco anarchico del regime poetico di Mario Fresa”