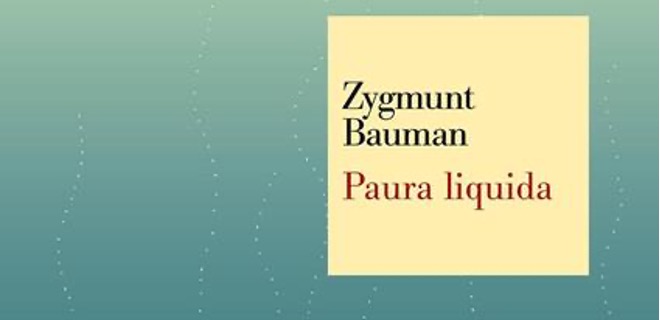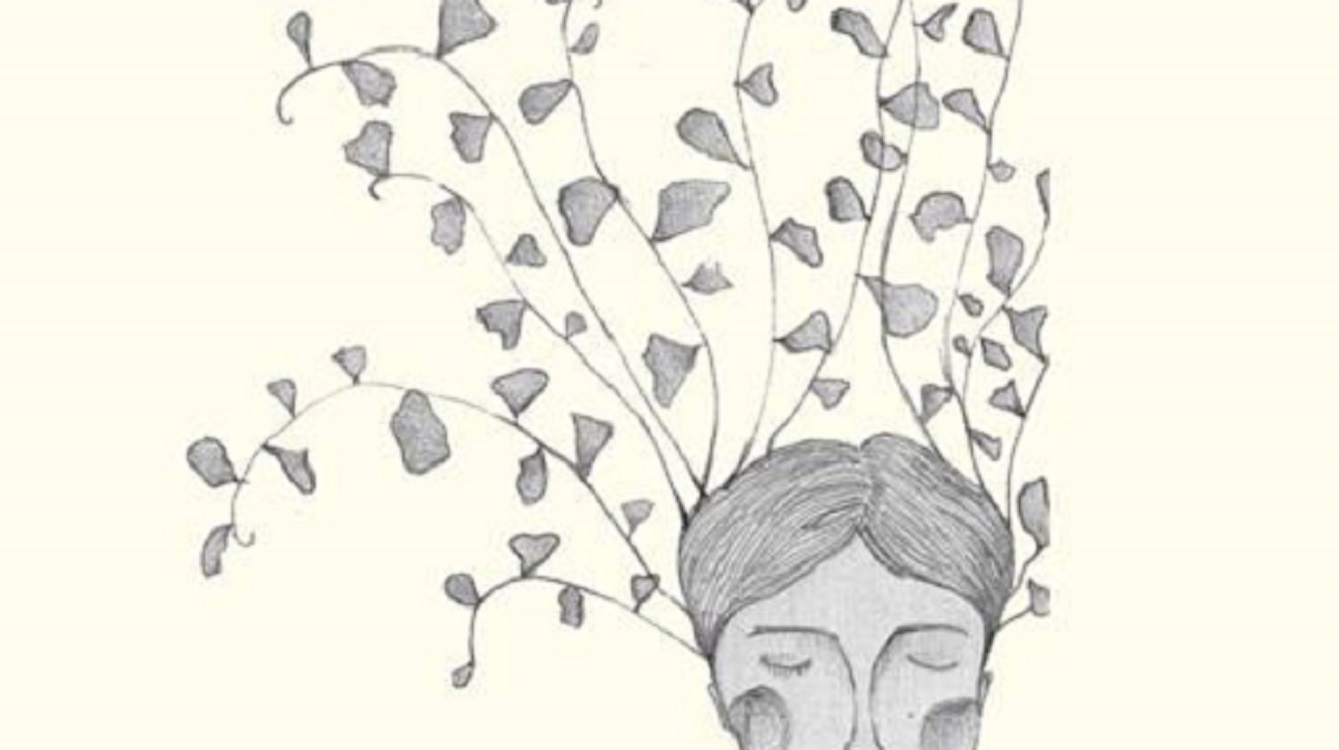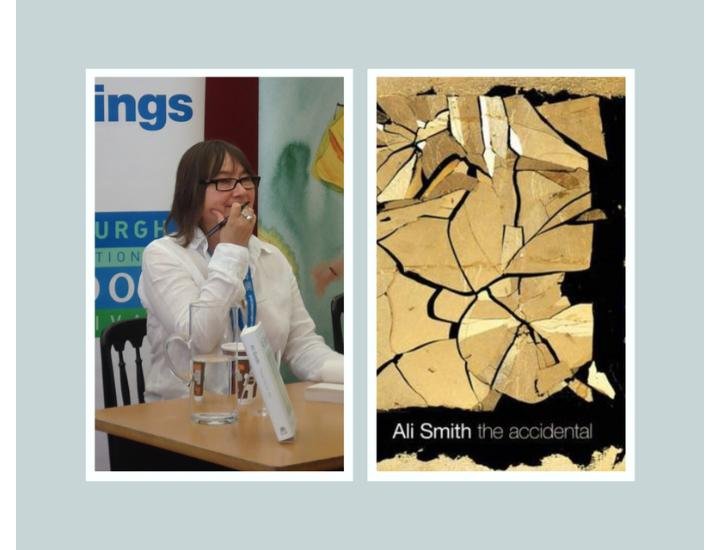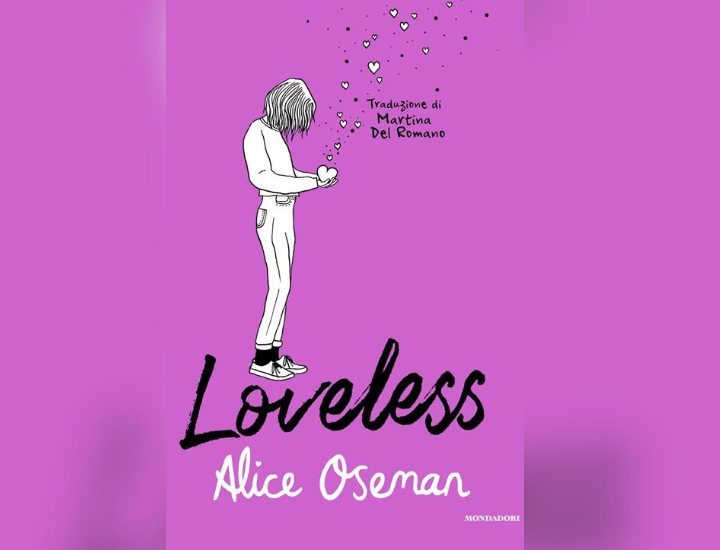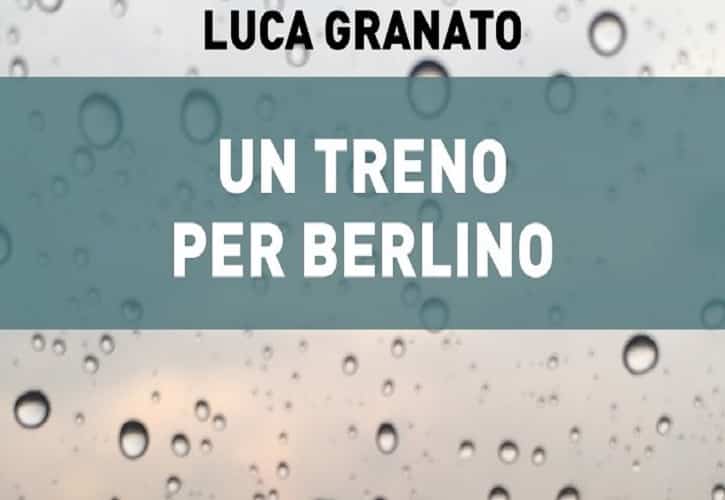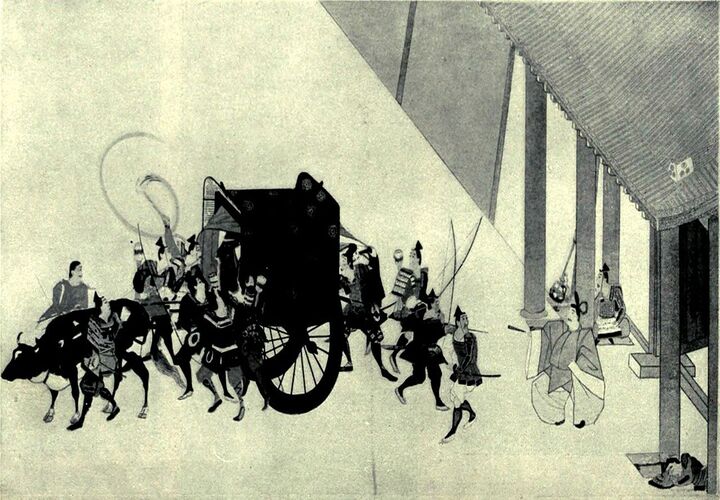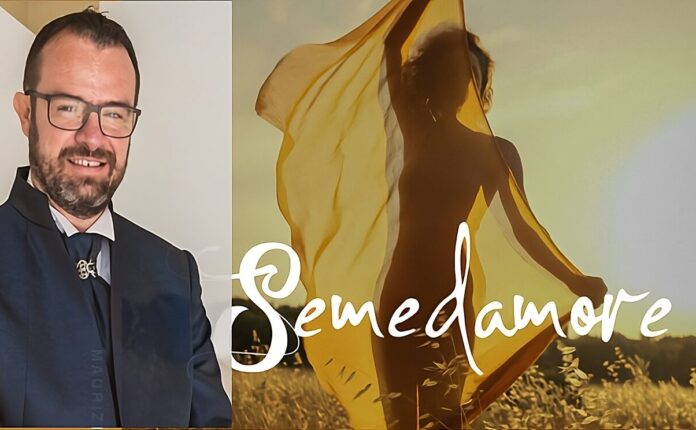Zygmunt Bauman è stato un noto pensatore polacco molto influente. Con il suo saggio Paura liquida, ci invita a riflettere sul ruolo imponente che la paura occupa nella nostra società. Bauman la collega al concetto di modernità liquida, che lui stesso ha coniato e oggi fa parte del nostro modo di parlare. Attraverso le sue parole mostra come la paura non sia più soltanto un’esperienza individuale, ma una condizione collettiva. Una sensazione che trova la sua forza nei profondi cambiamenti economici, culturali e politici innescati dalla globalizzazione.
Paura liquida: cosa vuol dire?
Nel suo pensiero, Bauman affronta la paura osservandola da due angolazioni complementari: quella macrosociologica e quella microsociologica. La prima prospettiva allarga lo sguardo alle grandi trasformazioni globali: pensiamo alla fine di un’epoca come il secolo breve o all’omogeneità che il capitalismo globale impone. Secondo Bauman, questi fenomeni hanno contribuito a creare un mondo dove le differenze si assottigliano, un mondo senza alterità. La seconda angolazione, invece, esamina come questi stessi mutamenti abbiano inciso profondamente sui nostri legami personali. Bauman nota come questo scenario possa portarci ad autoisolarci e vivere le relazioni quasi come fossero beni di consumo. Ed è qui che entra in gioco il concetto chiave di liquidità: per Bauman, è proprio questa la caratteristica principale della nostra modernità, una condizione fluida, priva di forme stabili, segnata da un’insicurezza e un cambiamento che sembrano non avere mai fine.
Paura liquida e trasformazioni del lavoro nella società contemporanea
Nel passaggio dalla modernità solida alla modernità liquida si assiste a una trasformazione profonda della struttura del lavoro e delle forme di identità. Mentre nella modernità solida il lavoro era la base della funzione sociale e anche della costruzione dell’identità, oggi prevale un modello precarizzato e flessibile che produce insicurezza, stress e depressione. Il concetto chiave è quello di esubero: non più il disoccupato che temporaneamente è fuori dal sistema produttivo, ma l’esubero, ovvero chi è considerato superfluo. Questo meccanismo produce vite di scarto, individui espulsi dal circuito produttivo come i migranti, i poveri e i carcerati.
Quali sono i livelli della paura liquida?
La paura liquida è difficile da localizzare e affrontare. Si articola in diversi livelli: la paura immediata, legata alla sopravvivenza fisica e materiale; la paura strutturale, legata alla perdita di collocazione sociale e di riconoscimento e la paura esistenziale, che riguarda la fragilità dell’identità. La società liquida è priva di un progetto condiviso e produce un eterno presente, in cui ogni giorno è un tentativo di sopravvivere all’esclusione, all’invisibilità, all’oblio. È la sindrome del Titanic: la consapevolezza che non esistono scialuppe di salvataggio per tutti, che nella catastrofe sociale non siamo tutti uguali.
La paura liquida e il concetto di morte sociale
Bauman propone una riflessione anche sulla morte, intesa non solo come evento biologico ma come una pratica sociale, esclusione sistemica, perdita di dignità. Questa morte è rappresentata metaforicamente nei reality show, dove l’eliminazione è parte del gioco e nessuno viene escluso per colpa morale ma semplicemente perché il sistema prevede che qualcuno debba uscire. Questa dinamica produce assoluzione morale: nessuno è colpevole e ciò disintegra ogni possibilità di solidarietà. Il sistema di valori si riconfigura in funzione della sopravvivenza individuale, in un mondo dove il successo personale è l’unico criterio di legittimazione.
Identità, consumo e relazioni nella modernità liquida
L’identità nella modernità liquida, è costruita sul consumo: non si è più qualcuno perché si produce, ma perché si consuma. Tuttavia, il consumo compulsivo produce anch’esso insicurezza perché implica la possibilità costante di essere tagliati fuori. Chi non può consumare abbastanza è considerato difettoso. Ciò vale anche per le relazioni interpersonali che diventano fragili e soggette al continuo ricambio. La paura di essere scartati, rifiutati o abbandonati accompagna tutte le esperienze umane nella società liquida.
Paura liquida e controllo sociale
Il problema, secondo Bauman, è che nella società contemporanea non sappiamo più distinguere chiaramente tra pericolo e paura. Le paure diventano indeterminate, generalizzate, spesso strumentalizzate dal potere per fini di controllo. In questo senso, la paura diventa un prodotto da consumare, fonte di profitto e potere, come nel caso della sicurezza privata, dei cosmetici anti-età e della cronaca nera spettacolarizzata.
La sparizione del futuro e il dominio dell’eterno presente
La dimensione temporale della modernità liquida è segnata dalla sparizione del futuro. Non si fanno più progetti a lungo termine. Esiste solo un presente da sfruttare. Le due regole del vivere contemporaneo, secondo Bauman, sono: vivere ogni giorno come se fosse l’unico e mantenere le relazioni il più superficiali possibile, per non essere feriti quando finiscono. Tuttavia, questo stile di vita produce una angoscia diffusa: desideriamo relazioni autentiche e durature ma il sistema ci costringe alla superficialità.
Paura liquida: un saggio che fa riflettere
Per concludere, Bauman ci mostra come la paura, oggi, non sia solo qualcosa che proviamo individualmente, ma una condizione che condividiamo, spesso senza rendercene conto. È un saggio che fa riflettere senza offrire soluzioni facili, certamente, Ma ci invita silenziosamente a guardare diversamente il mondo che ci circonda e il modo in cui ci muoviamo. Capire la paura che abitiamo può essere un primo passo per vivere in modo più consapevole e meno soli.
Fonte immagine: Laterza