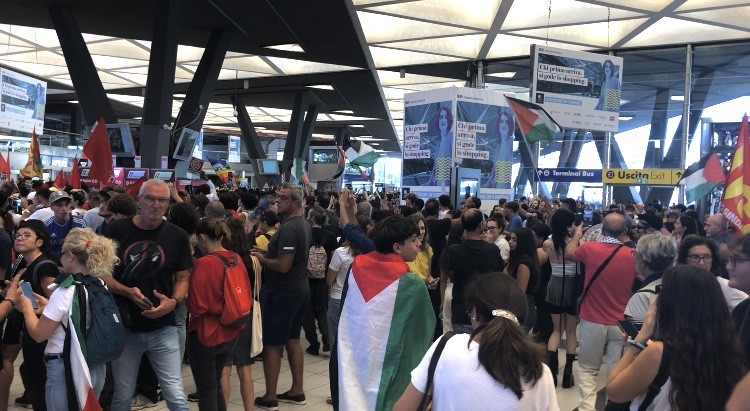L’arresto di Nicolás Maduro e l’operazione militare che lo ha reso possibile segnano un punto di non ritorno nel modo in cui gli Stati Uniti intendono esercitare il proprio ruolo sulla scena internazionale. Non si tratta di un episodio isolato né di una risposta emergenziale: ciò che è avvenuto in Venezuela si inserisce con coerenza nella visione politica di Donald Trump e nel meccanismo di espansione che ha guidato, sin dal suo primo mandato, la sua idea di politica estera.
Trump ha sempre concepito il potere internazionale come un confronto diretto tra Stati, meglio ancora tra potenze, in cui il diritto, le istituzioni multilaterali e i trattati hanno valore solo se utili a rafforzare una posizione di vantaggio. Questa mentalità rifiuta l’idea di un ordine globale fondato su regole condivise. Per Trump, l’ONU, l’Unione Europea e le grandi organizzazioni internazionali non sono strumenti di equilibrio, ma strutture lente e inefficaci che ostacolano l’azione immediata. La sua politica estera non cerca legittimazione collettiva, ma risultati visibili e immediati.
L’azione contro il Venezuela riflette perfettamente questa impostazione. La cattura di Maduro è stata costruita come un atto di forza esemplare. Il messaggio è che gli Stati Uniti possono intervenire direttamente se ritengono che questo rientri nei propri interessi strategici. In questo schema, la sovranità diventa un concetto negoziabile, subordinato alla narrativa della sicurezza. Fonti internazionali hanno sottolineato come la scelta di inquadrare l’operazione sotto l’egida della DEA non sia casuale: trasformare un presidente in un “narcos” consente di spostare il terreno del conflitto dal piano politico a quello penale, evitando il confronto diretto con il diritto internazionale.
Non è più un’aggressione tra Stati, ma un arresto. Questa ambiguità è il cuore della strategia: neutralizzare le tutele giuridiche attraverso la ridefinizione del nemico. La fotografia diffusa durante l’arresto diventa parte integrante dell’operazione: l’immagine precede il dibattito, costruisce una verità visiva che non ammette repliche. È la giustizia spettacolarizzata, che non chiede prove ma adesione emotiva.
Questa logica non nasce oggi. Durante il suo primo mandato, Trump aveva già dimostrato di preferire l’azione unilaterale alle mediazioni diplomatiche (come nel caso Soleimani). Ciò che cambia ora è la scala e la chiarezza con cui questa visione viene applicata. L’America non si propone più come arbitro, ma come attore diretto che ridisegna gli equilibri attraverso interventi mirati.
All’interno degli Stati Uniti, tuttavia, questa politica non è priva di opposizione. Organizzazioni come l’ACLU e Code Pink hanno denunciato apertamente l’operazione come una violazione del diritto internazionale e un pericoloso precedente, sottolineando come la lotta al narcotraffico venga usata come copertura per interventi politici e militari. Ex diplomatici e analisti hanno evidenziato come l’erosione delle regole multilaterali finisca per indebolire la stessa credibilità degli Stati Uniti, alimentando instabilità. Se il principio diventa quello dell’intervento diretto contro leader sgraditi, nessun sistema di sicurezza collettiva può reggere.
Trump, tuttavia, appare coerente con la propria visione. La sua politica internazionale non si fonda sull’idea di cooperazione, ma su quella di deterrenza e dominio. Ogni intervento deve dimostrare che l’America non chiede permesso. Il Venezuela diventa così il teatro di una dimostrazione di potenza, più che l’obiettivo finale.
Ciò che resta, al di là delle narrazioni ufficiali, è una domanda aperta sul futuro dell’ordine internazionale. L’azione contro Maduro non riguarda solo il Venezuela, ma il precedente che crea. Quando la forza sostituisce il diritto e l’arresto diventa strumento di politica estera, la linea che separa sicurezza e arbitrio si assottiglia pericolosamente. Ed è su questa linea che oggi si gioca una parte decisiva del destino globale.
Di Yuleisy Cruz Lezcano