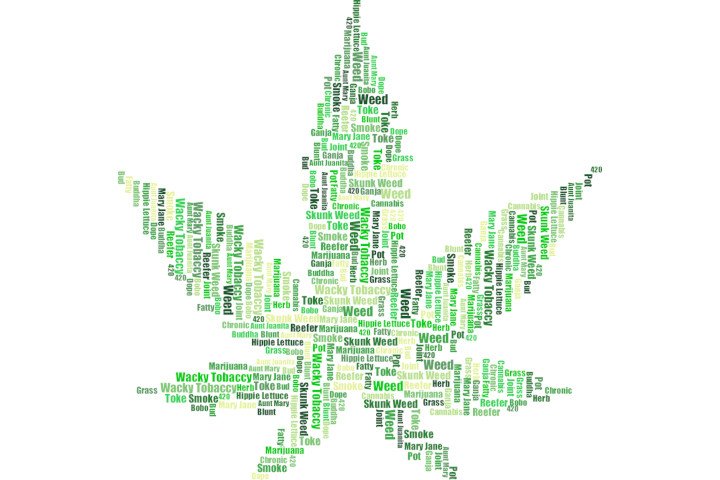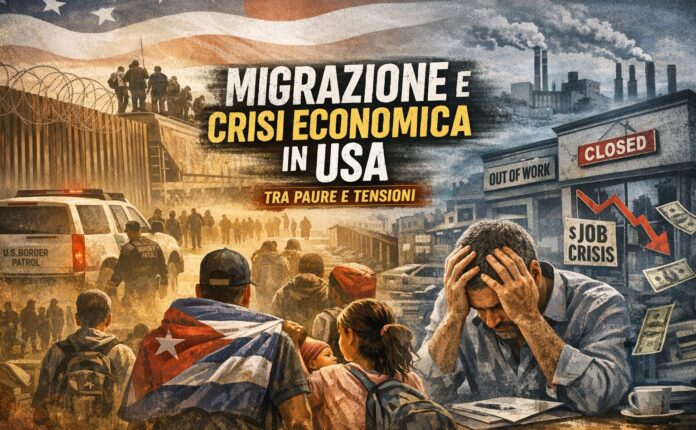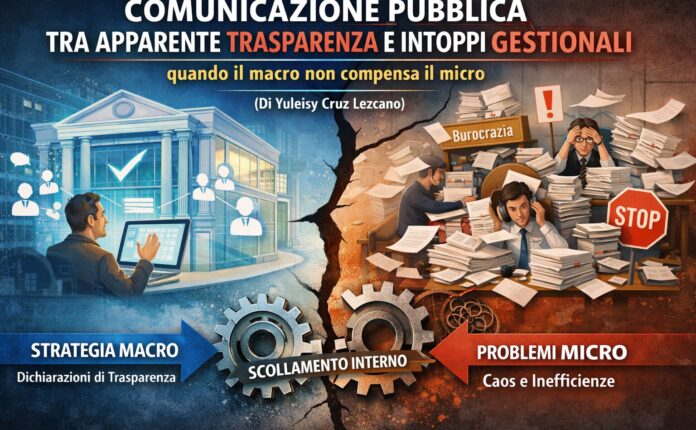La narrazione della violenza di genere richiede un approccio coscienzioso e un linguaggio preciso per evitare di rafforzare stereotipi dannosi. Un racconto superficiale può, infatti, arrecare ulteriore danno a chi subisce violenza e distorcere la percezione pubblica del fenomeno, che è strutturale e non episodico. Per questi motivi, è fondamentale scegliere le parole con attenzione, esprimere i concetti in modo chiaro e abbandonare metafore e inutili giri di parole che possono creare ambiguità.
Indice dei contenuti
- Cosa evitare per una corretta narrazione della violenza di genere
- Le regole per un’informazione rispettosa: il Manifesto di Venezia
- Cosa comporta una scorretta narrazione mediatica
- Il peso delle parole: dalla diffusione non consensuale di immagini al catcalling
- La narrazione tossica in pratica: il caso del gruppo “Mia Moglie”
Cosa evitare per una corretta narrazione della violenza di genere
Una narrazione corretta della violenza di genere deve superare la rappresentazione episodica, che descrive l’accaduto come un fatto isolato e individuale. Questo approccio è profondamente errato, perché la violenza contro le donne è un fenomeno sistemico e strutturale. Una conseguenza diretta di questa visione distorta è la de-responsabilizzazione dell’aggressore (l’abuser) e la colpevolizzazione secondaria di chi subisce violenza, un meccanismo noto come victim blaming. Le testate giornalistiche, purtroppo, tendono spesso ad attribuire alla donna atteggiamenti che l’avrebbero resa “responsabile” dell’aggressione: quante volte leggiamo che era ubriaca, che l’abuso è avvenuto di notte o in discoteca, o troviamo descrizioni dettagliate del suo abbigliamento. Questo si chiama slut shaming, lo “stigma della puttana”, e ha radici profonde nel sistema patriarcale. Se una donna beve, esce di notte o indossa una gonna, sta apparentemente trasgredendo a codici non scritti e, di conseguenza, permette agli altri di spersonalizzarla: da persona, diventa “carne”.
Da qui si passa facilmente alla de-colpevolizzazione dell’autore della violenza, perché “la carne attira il lupo”. Gli abusanti vengono spesso rappresentati come bestie o malati, individui mossi da un raptus incontrollabile. Si tratta di una de-personalizzazione pericolosa. Un esempio recente è la narrazione dello stupro di Palermo del 7 luglio 2023, dove gli autori sono stati definiti “branco” o “animali”. A tal proposito, è illuminante lo striscione della cooperazione NON UNA DI MENO di Palermo, che recitava: «LO STUPRATORE NON È MALATO, È FIGLIO SANO DEL PATRIARCATO». Questa frase riassume un concetto fondamentale: alla base della rape culture (cultura dello stupro) c’è proprio il sistema patriarcale.
Le regole per un’informazione rispettosa: il Manifesto di Venezia
Per contrastare le narrazioni tossiche, il mondo del giornalismo italiano si è dotato di linee guida precise raccolte nel Manifesto di Venezia. Questo documento, promosso da organi come FNSI e l’associazione GiULiA Giornaliste, impegna chi fa informazione a usare un linguaggio corretto e consapevole, riconoscendo la violenza di genere come una violazione dei diritti umani. L’obiettivo è promuovere un cambiamento culturale partendo dalle parole.
| Pratica da evitare | Approccio corretto secondo il manifesto |
|---|---|
| Uso di termini come “raptus”, “gelosia”, “delitto passionale”. | Descrivere i fatti per ciò che sono: crimini basati su possesso e controllo, usando il termine specifico “femminicidio”. |
| Fornire attenuanti o giustificazioni all’omicida (“era depresso”, “aveva perso il lavoro”). | Focalizzarsi sulla responsabilità dell’autore senza introdurre elementi che ne alleggeriscano il gesto. |
| Pubblicare foto della donna sorridente insieme al suo assassino. | Rispettare la memoria della persona, evitando immagini che creino una falsa narrazione di amore e felicità. |
| Rendere la donna anonima o definirla solo in relazione all’uomo (“la moglie di”, “la fidanzata di”). | Dare sempre nome e cognome alla donna, riconoscendola come individuo con una propria identità. |
Cosa comporta una scorretta narrazione mediatica
L’inopportuna narrazione della violenza da parte dei media alimenta la percezione che gli abusi più gravi, come stupri e femminicidi, siano commessi da estranei. Si rafforza così l’immagine dell’ “uomo nero” che spunta da una siepe, una figura che non appartiene alla vita della donna. Eppure, i dati ufficiali raccontano una realtà diversa, ma di questi numeri c’è raramente traccia negli articoli di cronaca. Secondo l’indagine più completa disponibile, fornita dall’ISTAT nel 2014 (in attesa dei nuovi dati previsti per novembre 2025), il 13,6% delle donne ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner. Gli stupri, in particolare, sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner. Questi dati mostrano quanto sia inverosimile continuare a raccontare la favola del mostro sconosciuto.
Un altro grande problema riguarda la dimensione razziale. Quando sono coinvolte persone di altre nazionalità, si tende ad attribuire la colpa alla loro religione o cultura. Se si racconta che un uomo ha ucciso la moglie perché non rispettava i principi della cultura islamica, il messaggio implicito è che l’omicidio sia frutto dell’Islam, non di una mentalità patriarcale. Questa narrazione, oltre a essere razzista, è profondamente ipocrita: se l’aggressore è straniero, la colpa è della sua cultura; se è italiano, allora è un “animale” o un “malato”, perché “i veri uomini” queste cose non le fanno. In entrambi i casi, si evita di affrontare la radice comune del problema: il patriarcato.
Il peso delle parole: dalla diffusione non consensuale di immagini al catcalling
È fondamentale che le testate giornalistiche smettano di usare l’espressione revenge porn per indicare la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Questo termine è fuorviante: la parola “revenge” (vendetta) implica che la vittima abbia commesso un “torto” per cui “merita” una punizione. Inoltre, il termine “porn” è errato, perché la pornografia presuppone il consenso e la consapevolezza di essere osservati. Il termine giuridicamente corretto in Italia è diffusione non consensuale di materiale intimo. Usare le parole giuste è il primo passo per non accrescere il senso di colpa di chi subisce questa violenza. Anche il termine “vittima” andrebbe usato con cautela per non sfociare nella pornografia del dolore, che dipinge la donna come un soggetto passivo e indifeso. Per questo, si preferisce spesso il termine inglese survivor (sopravvissuta), che ne sottolinea la forza e la capacità di reazione.
Quando si parla di violenza, è importante ricordare che non esistono solo stupro e femminicidio. La piramide della violenza ha una base molto ampia che include atti spesso minimizzati, ma che creano il terreno fertile per le aggressioni più gravi. Tra questi ci sono lo stealthing (rimozione non consensuale del preservativo), l’upskirting (foto scattate sotto le gonne), lo stalking e il catcalling. Quest’ultimo, in particolare, non è un complimento, ma una molestia verbale che contribuisce a un clima di intimidazione nello spazio pubblico.
La narrazione tossica in pratica: il caso del gruppo “Mia Moglie”
Un esempio recente di come la cultura dell’oggettificazione si traduca in violenza digitale di massa è il caso del gruppo Facebook “Mia Moglie”. Emerso con forza nell’estate del 2025, questo spazio virtuale con oltre 32.000 iscritti era dedicato alla condivisione di immagini intime di mogli e partner, pubblicate senza alcun consenso. Questo fenomeno non è un gioco, ma l’espressione di una cultura patriarcale che trasforma la partner in un oggetto da esibire. Come evidenziato nell’analisi del caso, gli uomini che compiono queste azioni manifestano spesso un senso di diritto assoluto sul corpo dell’altro (entitlement). La condivisione di massa e i commenti degli altri utenti normalizzano e amplificano l’abuso, causando danni psicologici devastanti in chi lo subisce, come ansia, depressione e disturbo da stress post-traumatico. Questo caso dimostra come la violenza digitale sia parte di un continuum di violenza che, umiliazione dopo umiliazione, può sfociare in tragedia. Per una corretta narrazione, dunque, ci vuole accortezza, sensibilità e tatto. Non si tratta di essere “politicamente corretti”, ma di essere umani e responsabili.
Articolo aggiornato il: 07/10/2025