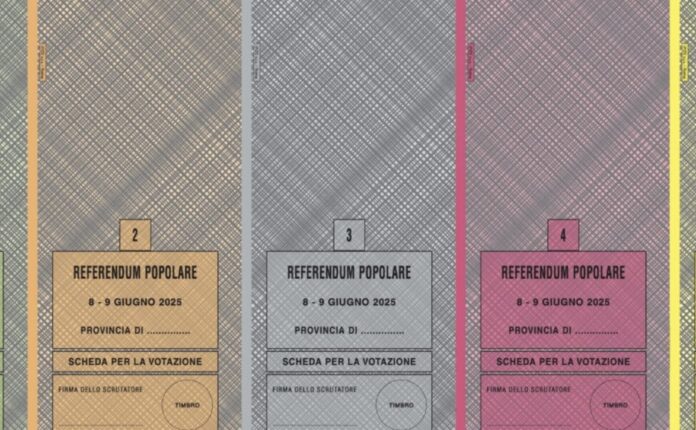La narrazione della violenza di genere, spesso, se non fatta coscienziosamente e con la padronanza del linguaggio corretto, può rafforzare stereotipi già esistenti, arrecare danni alla persona che vive la violenza e stravolgere la percezione del fenomeno da parte dell’opinione pubblica: proprio per questi motivi bisognerebbe, a priori, fare attenzione alle parole da adottare, esprimere i concetti in modo chiaro, senza metafore e giri di parole.
Cosa evitare e cosa no per una corretta narrazione della violenza di genere
Innanzitutto, una delle cose più sbagliate da fare nel caso di narrazione della violenza di genere è fare una rappresentazione episodica, ovvero andare ad esporre l’accaduto come un fatto individuale, un problema limitato solo alla persona che ha subito l’abuso. Non c’è niente di più sbagliato, perché la violenza è sistemica e strutturale. Come conseguenza diretta di questo tipo di rappresentazione, c’è la de-responsabilizzazione dell’abuser e la colpevolizzazione dell’abusata, anglicizzato in victim blaming. Le testate giornalistiche, infatti, tendono ad attribuire alla donna che ha subito un abuso degli atteggiamenti che l’hanno poi portata ad essere la principale responsabile della violenza: quante volte leggiamo che al momento dello stupro la donna era ubriaca, che l’abuso è avvenuto di notte, o in discoteca, o addirittura troviamo intere descrizioni del vestiario della donna; questo si chiama slut shaming, lo “stigma della puttana”, e alla base di tutto ciò c’è, ovviamente, il sistema patriarcale. Perché se tu donna bevi, esci di notte, vai in discoteca o metti una gonna più corta, stai trasgredendo ai codici patriarcali e, di conseguenza, stai permettendo agli altri di spersonalizzarti e da persona, diventi carne.
E da qui passiamo invece alla de-colpevolizzazione dell’autore della violenza, perché la carne attira il lupo. È proprio così che spesso vediamo rappresentati gli abusanti, degli animali, delle bestie attratti dall’odore della carne. Si tratta di de-personalizzazione, e tra gli esempi più recenti ed eclatanti c’è la narrazione della violenza arrecata ai danni della diciannovenne palermitana il 7 luglio 2023. Gli autori dello stupro sono stati definiti dalla stragrande maggioranza delle testate giornalistiche come degli animali, dei malati. Ecco, per rispondere meglio a questo punto è bene citare lo striscione scritto dalla cooperazione NON UNA DI MENO di Palermo girato, il 20 agosto, per le vie della città in cui è avvenuto lo stupro: «LO STUPRATORE NON È MALATO, È FIGLIO SANO DEL PATRIARCATO» – ed è vero, perché alla base di tutto, come primo tassello della rape culture, c’è proprio il sistema patriarcale.
Ma la scorretta narrazione della violenza di genere non si ferma qui. Ci sono casi in cui la donna abusata non viene neanche rappresentata, dando più spazio all’uomo; in altri casi, invece, l’abusata viene classificata come “compagna/moglie/amica/sorella di X”: né un nome né tantomeno un cognome, per renderla ancora più trasparente di quanto non lo sia già. In questi casi anche l’immagine utilizzata all’interno degli articoli diventa fonte di problemi: ad esempio, nel caso di un femminicidio commesso all’interno di una coppia, è sbagliato porre in primo piano una foto della donna e del suo omicida assieme continuando ad inserire la felicità e l’amore in un contesto in cui questi due fattori sono estremamente e completamente assenti, perché no, «l’ha uccisa perché l’amava troppo» non può essere una giustificazione.
Cosa comporta una scorretta narrazione della violenza di genere
Ma l’inopportuna narrazione della violenza di genere da parte dei mass media va anche oltre. Infatti, restando nell’ambito dello stupro e del femminicidio, atti di violenza che si trovano all’apice della piramide della rape culture, si può facilmente notare come queste tipologie di abuso e cancellazione definitiva ai danni della donna vengano spesso attribuite a degli estranei, persone che non si conoscono, esterni alla vita dell’abusata, quasi come se si trattasse dell’uomo nero sbucato fuori dalla siepe. Eppure, i dati dicono il contrario, ma di questi dati, negli articoli di giornale che dovrebbero essere innanzitutto un mezzo di informazione, non ce n’è traccia. Di seguito, quindi, ne riportiamo alcuni. Secondo i dati ISTAT, infatti, il 13,6% delle donne ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner; il 13,2% da estranei, il 13% da persone conosciute: tra quest’ultime, il 6,3% da conoscenti, il 3% da amici, il 2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro. Gli stupri, in particolare, sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici; come si può evincere dai numeri, è abbastanza inverosimile continuare a raccontare la storia dell’uomo nero.
Altro grande problema che riguarda la narrazione della violenza di genere è la tematica razziale. Infatti, nel descrivere casi in cui sono coinvolte persone originarie di determinate aree geografiche, si tende ad attribuire la colpa alla loro religione, alla loro cultura o al loro status sociale. Questo, soprattutto in Italia, accade perché ci troviamo all’interno di Paese che ha paura dello straniero e che, di conseguenza, lo condanna perché tale: se, infatti, si racconta di un uomo che ha ucciso sua moglie perché non rispettava a pieno i principi della cultura islamica, il messaggio che sta trapelando è che quell’uomo ha commesso un omicidio non perché il suo comportamento è frutto di uno stato patriarcale, ma perché aderente ai principi dell’Islam e, di conseguenza, si sfocia in una tipologia di narrazione estremamente razzista. Tuttavia, la colpa è anche dei lettori, che emettono il loro giudizio appena viene menzionata l’etnia dell’abuser.
Quindi, piccola ricapitolazione, secondo l’attuale narrazione della violenza di genere: se hai commesso un abuso e sei di un altro paese, soprattutto orientale, la colpa è della tua religione, non del tuo comportamento misogino e violento se, invece, hai commesso un abuso MA sei italiano, allora sei un animale, perché gli uomini queste cose non le fanno. Capirete che è una tipologia di narrazione abbastanza ipocrita.
Il peso delle molestie: dal revenge porn al catcalling
Passando oltre, sarebbe bene che le testate giornalistiche per la narrazione della violenza di genere smettessero di utilizzare il termine revenge porn per indicare la condivisione non consensuale di immagini sessualmente esplicite. Questo perché subire revenge porn implica una colpa, una responsabilità: io ho fatto questa cosa e per questo x persona si è vendicata; inoltre, anche il termine porn non è corretto, in quanto il porno, quello mainstream, è creato secondo un determinato principio: la consapevolezza che qualcuno guarderà quel filmato o quella foto; nella condivisione non consensuale di materiale intimo questa consapevolezza non esiste, alla base c’è la fiducia che quel momento di intimità resti tra le due parti interessante e non venga divulgato altrove. Questa tipologia di narrazione non fa altro che accrescere il senso di colpa che nasce nella mente dell’abusata, che la fa sentire più sporca e più sbagliata. Anche per il termine “vittima” andrebbe fatta un po’ di chiarezza perché si potrebbe sfociare nella pornografia del dolore, un’eccessiva strumentalizzazione del dolore che dipinge l’abusata come una ragazzina indifesa, ingenua, passiva ma questa non è un’immagine che può essere definita collettiva; oggigiorno, infatti, sarebbe preferibile utilizzare il termine inglese survivor, sopravvissuta, ma anche qui ci vuole accortezza. Altra cosa che andrebbe fatta per aiutare la donna che ha vissuto un certo tipo di violenza è smetterla di far girare per il web screenshot di chat o video semplicemente per dare più rilievo al discorso perché una donna che sta subendo fisicamente e psicologicamente le conseguenze di un’aggressione, costretta a rivedere ogni giorno foto, nomi, chat e video che la riguardano in prima persona è costretta, di conseguenza, a rivivere quel momento incessantemente e anche questa è una forma di violenza vera e propria.
Inoltre, quando si parla di narrazione di violenza di genere è importante che la mente non vada subito allo stupro o al femminicidio, bisogna ricordare sempre che esistono diversi tipi di violenza c’è, ad esempio, lo stealthing, violenza sessuale in cui il preservativo viene rimosso di nascosto durante l’atto; l’upskirt, foto scattate senza consenso sotto le gonne, per strada o anche nei camerini dei negozi, spesso condivise nelle chat Telegram; lo stalking, atto persecutorio in cui la vittima diventa destinataria di minacce e molestie; il mail-bombing, continue telefonate, messaggi, regali, scritte sui muri e danneggiamenti dei beni personali, tutto mirato al desiderio di controllo; e, infine, c’è quel tipo di violenza che nessuno mai vuole riconoscere come tale, il catcalling, una molestia verbale, non una manifestazione di apprezzamento fisico.
Di conseguenza, come detto all’inizio, per una corretta narrazione della violenza di genere ci vuole molta accortezza, sensibilità e tatto. Dev’esserci distacco, ma non tanto da far sembrare l’accaduto roba da quattro spicci; la narrazione deve essere efficace, non metaforica, deve arrivare alla mente del lettore in modo chiaro e completo. Non si tratta di essere politicamente corretti o meno, si tratta di essere umani e responsabili.
Fonte immagine in evidenza: Pixabay