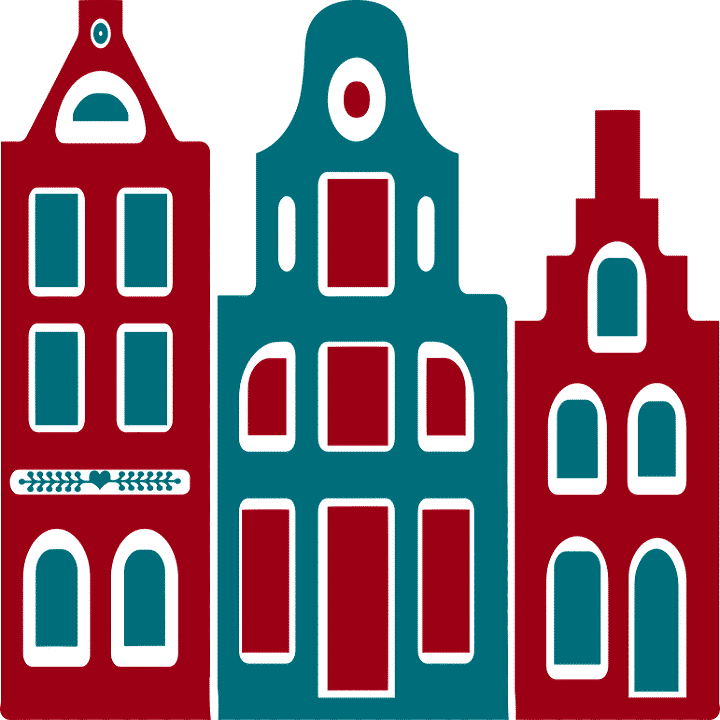Che cos’è la sindrome di Stoccolma? C’è chi l’ha conosciuta guardando un film, chi ne ha sentito di sfuggita il nome al telegiornale e chi l’ha cantata a squarciagola nel brano del suo artista preferito, eppure quasi tutti ne ignorano le origini e la vera natura. Si tratta di un meccanismo di sopravvivenza psicologico che emerge in alcune vittime di situazioni estreme come rapimenti o sequestri prolungati e comporta lo sviluppo di sentimenti positivi nei confronti del proprio aguzzino. Per la sua natura complessa ed enigmatica, questo legame insolito e paradossale ha attirato particolare attenzione nei media.
Indice dei contenuti
Sindrome di Stoccolma: l’origine del nome
La sindrome di Stoccolma deve il suo nome allo psichiatra e criminologo svedese Nils Bejerot, che lo coniò a seguito di un avvenimento storico accaduto nel 1973 proprio a Stoccolma. Per 131 ore consecutive, dal 23 al 28 agosto, due rapinatori mantennero sotto sequestro quattro impiegati della Sveriges Kreditbanken all’interno della camera di sicurezza. La cosa curiosa è che, durante il sequestro, le vittime svilupparono un legame emotivo nei confronti dei propri sequestratori, che li spinse in seguito a rifiutarsi di testimoniare contro di loro e, in alcuni casi, a schierarsi apertamente a loro favore. Nonostante la loro vita fosse stata messa a repentaglio per quasi 6 giorni, a seguito delle interviste psicologiche si scoprì che gli ostaggi avessero temuto più la polizia dei rapitori stessi.
Le cause e le caratteristiche principali
Sebbene non sia un fenomeno comune, con un’incidenza stimata intorno all’8% tra le vittime di sequestri secondo un’analisi dell’FBI, la sindrome di Stoccolma è una risposta a un trauma intenso. Si manifesta quando si verificano determinate condizioni e presenta caratteristiche psicologiche ricorrenti.
| Condizioni scatenanti | Manifestazioni psicologiche nella vittima |
|---|---|
| Percezione di una minaccia grave alla propria sopravvivenza | Sviluppo di sentimenti positivi verso il carceriere (simpatia, fiducia, affetto) |
| Isolamento da prospettive esterne e contatto prolungato con l’aguzzino | Sviluppo di ostilità e sfiducia verso le forze dell’ordine o i soccorritori |
| Percezione di piccoli gesti di gentilezza da parte del rapitore | Identificazione con le ragioni e i sentimenti del proprio sequestratore |
| Incapacità di fuggire o di alterare la situazione | Rifiuto di collaborare con le autorità durante e dopo la prigionia |
È fondamentale sottolineare che l’assenza di una conoscenza pregressa tra sequestratore e vittima è una condizione necessaria: la relazione si sviluppa esclusivamente nel contesto traumatico come un legame paradossale.
Le criticità: perché non è una diagnosi ufficiale
In assenza di un riconoscimento ufficiale della sindrome di Stoccolma all’interno del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM-5 o in altri manuali di psicopatologia, molti esperti ritengono che il termine “sindrome” sia improprio. Come evidenziato anche in fonti mediche autorevoli come il Manuale MSD, queste reazioni sono spesso inquadrate all’interno del più ampio spettro dei disturbi da stress post-traumatico (PTSD). Le principali motivazioni per la sua mancata classificazione sono:
- È difficile stabilire criteri diagnostici univoci e standardizzati;
- Non esistono studi scientifici sufficientemente solidi per definirla come una patologia a sé stante;
- È considerata più una reazione di adattamento a un trauma estremo che una vera e propria sindrome clinica.
I casi celebri
Oltre all’episodio di Stoccolma che le ha donato il nome, esistono una serie di altri casi divenuti celebri. Tra le vittime a cui è stata associata la sindrome, ricordiamo Patricia Hearst, erede di una ricca famiglia americana, che fu rapita nel 1974 dall’Esercito di Liberazione Simbionese (SLA). Dopo settimane di prigionia, si unì ai suoi sequestratori e partecipò attivamente a una rapina in banca con loro. Un altro caso noto è quello di Natascha Kampusch, rapita a 10 anni dall’austriaco Wolfgang Přiklopil e tenuta prigioniera per otto anni. Dopo essere riuscita a fuggire, mostrò complessi sentimenti di compassione verso il suo rapitore, il quale si suicidò poco dopo la sua fuga. Più recente e dibattuto in Italia è quanto avvenuto in Kenya a Silvia Romano, la cooperante italiana rapita da Al-Shabaab e liberata dopo 18 mesi. Al suo ritorno in Italia, l’atteggiamento sereno e la conversione all’islam hanno suscitato dibattiti sulla possibile presenza della sindrome. La sua conversione, tuttavia, potrebbe essere stata una complessa strategia di sopravvivenza più che un vero attaccamento psicologico.
Fonte immagine in evidenza: Depositphotos
Articolo aggiornato il: 23/09/2025