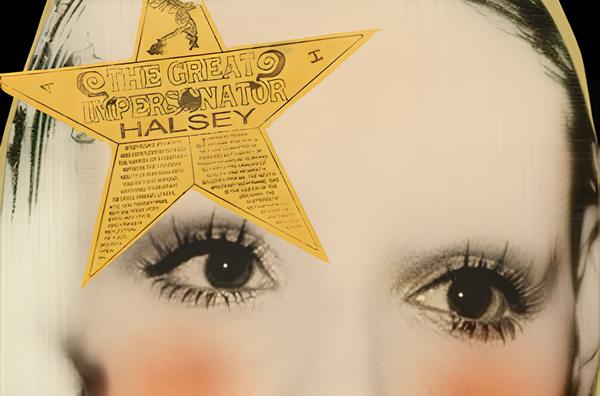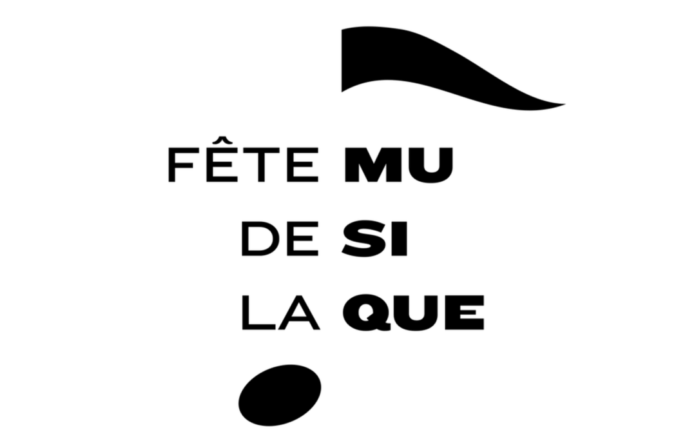Il termine k-pop indica la musica popolare della Corea del Sud. Originalmente risale al 1800, quando alcune popolari canzoni occidentali vengono riscritte in coreano. Il k-pop viene fortemente condizionato dai contatti con gli americani e il movimento hippy, portando alla produzione di trot e ballad. All’inizio degli anni Novanta, le sperimentazioni dei Seo Taiji and Boys, con diversi stili, generi e l’integrazione di coreografie ed elementi musicali provenienti dall’estero come il rap, aiutarono a ridare forma e ringiovanire la scena musicale. Con il debutto degli HOT si affiancò la figura degli idol, con gruppi k-pop misti e non, e da lì il k-pop divenne una subcultura in grado di riunire grandi fandom di adolescenti e adulti.
Il k-pop è noto per molti elementi come, ad esempio, le produzioni di alta qualità. I videoclip sono visivamente sbalorditivi con coreografie complesse, costumi elaborati e scenografie mozzafiato; La coreografia è parte integrante del k-pop. Gli idol sono spesso formati da anni di ballo, canto, recitazione e lingue tanto è vero che sono molto sincronizzati e precisi nei movimenti; Negli ultimi anni ormai ha conquistato il mondo, infatti si parla di Hallyu, onda coreana che include k-drama, film, moda e cibo.
Non possono mancare di certo i gruppi k-pop, solitamente maschili oppure femminili, ma esistono anche i gruppi k-pop misti, con un numero variabile di membri di diverse etnie o origini, con un ruolo specifico nel gruppo. Nella storia della musica coreana ci sono stati pochi gruppi k-pop misti poiché piacciono di meno e quindi tendono ad avere meno successo rispetto agli altri gruppi puramente maschili o puramente femminili. Negli ultimi anni sono due i gruppi k-pop misti che sono ancora in carriera, altri invece hanno avuto un impatto minimo quindi si sono dovuti sciogliere.
I gruppi k-pop misti più popolari
KARD e ALLDAY PROJECT

KARD: sono un gruppo musicale formatosi sotto l’agenzia DSP Media Entertaiment nel 19 giugno del 2017. Il gruppo è composto da 2 membri femminili e 2 maschili: BM, J.SEPH, So-min, Ji-woo. Se-min e Ji-woo si occupano della posizione di vocalist mentre BM e J.Seph hanno la posizione dei rapper. Prima del loro debutto, il gruppo ha pubblicato tre singoli pre-debutto: Oh NaNa il 13 dicembre 2016. Seguito da Don’t Recall il 16 febbraio 2017 e Rumor il 24 aprile 2017. Il nome del gruppo riassume il concetto delle carte da gioco, in cui ogni elemento è rappresentato da un seme e/o da una figura.

ALLDAY PROJECT: sono un gruppo musicale formatosi sotto l’agenzia The Black Label nel 23 giugno del 2025. Il gruppo k-pop misto è composto da 3 membri femminili e 2 maschili: Annie, Tarzzan, Bailey, Woochan e Youngseo. A differenza dei KARD tutti i membri sono dei rapper tranne Youngseo che è vocalist. Il 6 giugno 2025, è stato riferito che The Black Label si stava preparando a far debuttare un gruppo misto. Ore dopo un rappresentante dell’agenzia ha aggiunto dettagli rivelando che Youngseo, ex membro pre-debutto delle ILLIT, e Woochan, ex membro pre-debutto OG SCHOOL PROJECT, avrebbero debuttato nel gruppo k-pop misto. Hanno poi debuttato con il singolo Famous il 23 giugno.
Fonte immagine in evidenza: Wikimedia Commons- Korea.net/ Korean Culture and Information Service https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=k-pop&title=Special%3AMediaSearch&type=image