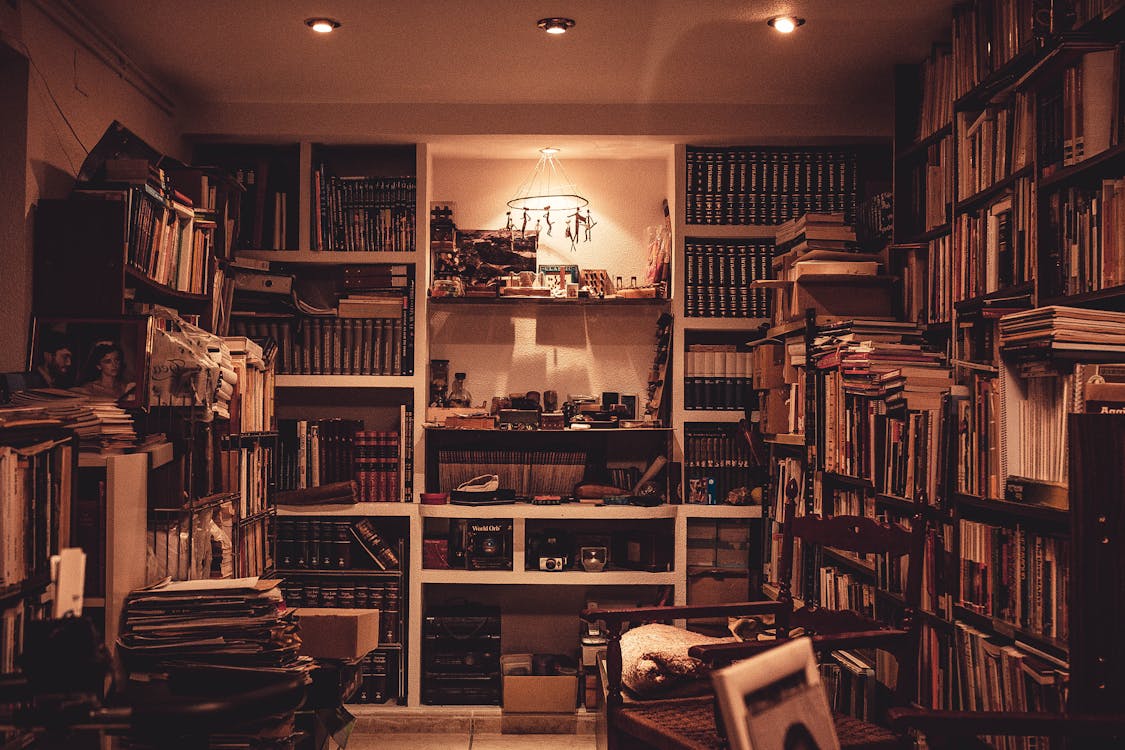Tre mesi dopo l’inizio del processo a Gerusalemme contro Adolf Eichmann, membro delle SS condannato per genocidio, lo psicologo Stanley Milgram avviò uno degli studi più significativi del XX secolo: l’Esperimento di Milgram.
Indice dei contenuti
L’obiettivo: perché obbediamo agli ordini?
L’esperimento di Milgram, iniziato nel 1961, aveva lo scopo di analizzare il comportamento degli individui di fronte a ordini imposti da un’autorità, quando questi entrano in conflitto con i propri valori morali. Partendo dall’ideologia nazista, lo psicologo statunitense voleva comprendere come un’intera nazione avesse potuto asservirsi a un singolo uomo e perpetrare lo sterminio di milioni di persone. Come era possibile che Eichmann e le altre SS affermassero di “stare solo eseguendo degli ordini”?
Come si è svolto l’esperimento
Per l’esperimento furono reclutati 40 uomini tra i 20 e i 50 anni, con il pretesto di uno studio sulla memoria. Milgram costruì un finto generatore di corrente elettrica con 30 interruttori, da 15 a 450 volt. I partecipanti venivano assegnati al ruolo di “insegnante”, mentre un collaboratore di Milgram recitava il ruolo di “allievo”. I due venivano posti in stanze separate.
I compiti dell’insegnante (il soggetto ignaro) erano:
- Leggere coppie di parole all’allievo.
- Verificare l’apprendimento dell’allievo con un test a scelta multipla.
- In caso di errore, infliggere una scossa elettrica, aumentando il voltaggio a ogni sbaglio.
L’allievo (il complice) simulava reazioni di dolore crescente, fino al silenzio totale ai voltaggi più alti, facendo credere di essere svenuto. Se l’insegnante esitava, uno sperimentatore in camice bianco lo incitava a continuare con frasi standardizzate come “L’esperimento richiede che lei proceda”. Al termine, veniva rivelato che le scosse non erano reali.
Risultati e variazioni dell’esperimento
Prima dell’esperimento, Milgram chiese a degli psicologi di prevedere i risultati: stimarono che solo l’1,2% dei partecipanti sarebbe arrivato a 450 volt. I dati reali furono sconvolgenti: il 65% dei soggetti (26 su 40) obbedì fino all’ultima scossa. Molti mostrarono segni di forte stress, come sudorazione, tremori e risa nervose. Milgram testò anche diverse varianti per capire quali fattori influenzassero l’obbedienza.
| Condizione sperimentale (vicinanza alla vittima) | Percentuale di obbedienza totale (450 volt) |
|---|---|
| La vittima non si vede né si sente (colpisce un muro) | 65% |
| La vittima si sente ma non si vede | 62.5% |
| La vittima si vede e si sente nella stessa stanza | 40% |
| L’insegnante deve forzare la mano della vittima su una piastra | 30% |
Conclusioni: lo stato eteronomico e lo stato d’agente
Come spiegare un tale grado di obbedienza? Milgram teorizzò che l’autorità induce uno stato eteronomico, in cui l’individuo non si considera più autonomo, ma un “agente” di una volontà esterna. In questo “stato d’agente”, la responsabilità morale viene trasferita all’autorità. Ciò è possibile per tre fattori: la percezione di legittimità dell’autorità, l’adesione al suo sistema (ci viene insegnato a obbedire) e le pressioni sociali.
Secondo Milgram, l’obbedienza dipende anche dalla situazione. Ridefinire il contesto può alterare la percezione di sé, portando il soggetto a non sentirsi responsabile delle proprie azioni. Nell’esperimento, l’autorità dello scienziato rende la norma dell’obbedienza più pertinente di quella che condanna la violenza, portando l’insegnante a considerare la punizione come logica e necessaria. Questi studi, raccolti nel suo celebre libro “Obbedienza all’autorità”, sono stati fondamentali per analizzare gli orrori perpetrati dai nazisti e le dinamiche del potere.
Immagine di copertina: Pixabay
Articolo aggiornato il: 09/09/2025