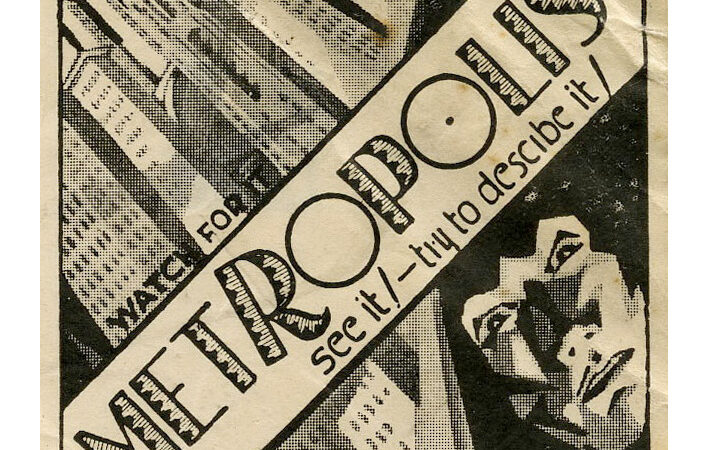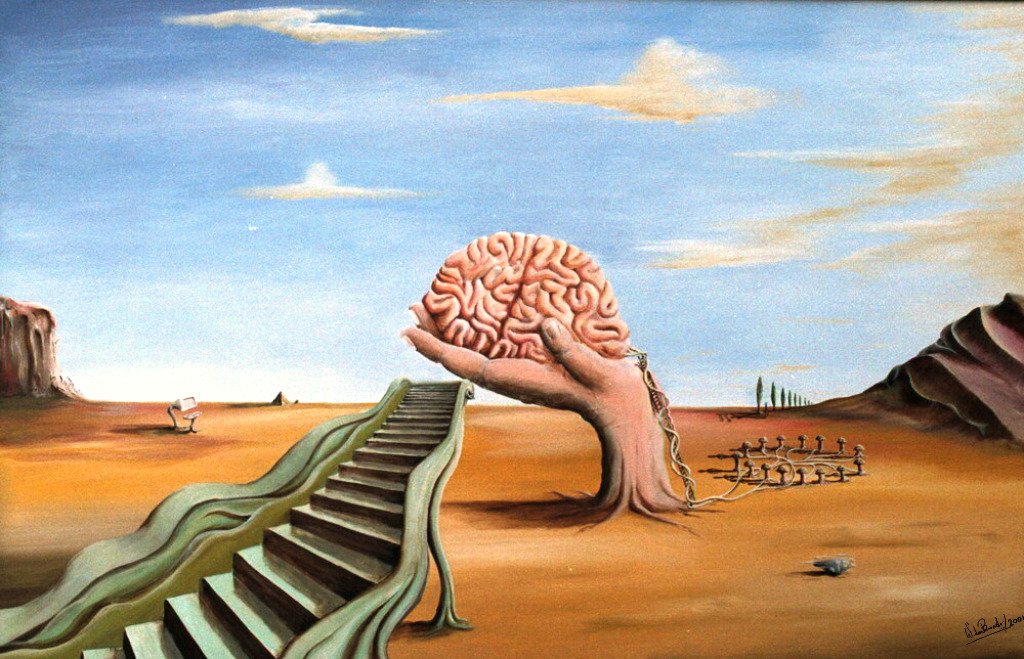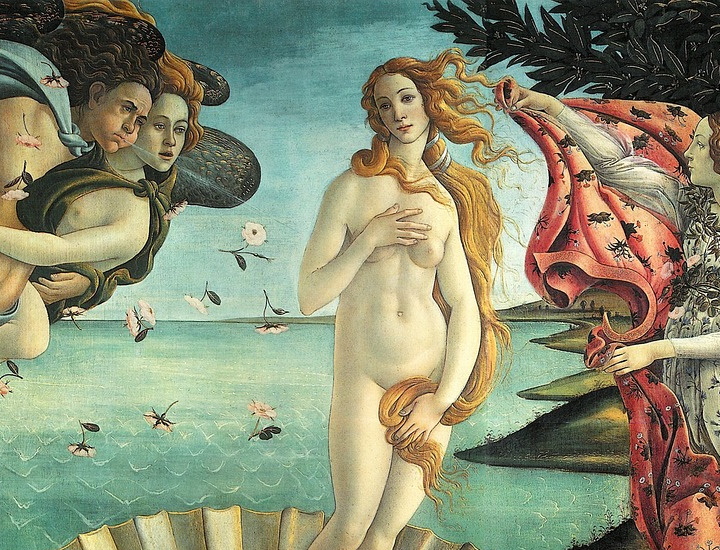L’espressionismo tedesco è stato un movimento d’avanguardia che ha sconvolto la cultura europea nei primi decenni del Novecento. Nato come reazione all’alienazione della modernità, all’industrializzazione selvaggia e all’angoscia esistenziale che precedette la Prima Guerra Mondiale, questo movimento ha dato voce a un “urlo” interiore, privilegiando la visione soggettiva e la distorsione emotiva della realtà. Dalle tele dei pittori alle pagine dei poeti fino ai set cinematografici, l’espressionismo ha lasciato un’impronta indelebile, raccontando il crepuscolo di un’umanità in crisi.
Indice dei contenuti
L’espressionismo tedesco nelle tre arti
| Forma d’arte | Caratteristiche e temi |
|---|---|
| Pittura (es. Die Brücke) | Uso di colori violenti e anti-naturalistici, forme spigolose e deformate, contorni marcati. Temi di angoscia, solitudine e critica sociale. |
| Poesia (es. Georg Heym) | Rifiuto della metrica tradizionale a favore del verso libero. La città come mostro alienante, senso di fine imminente (Weltende), immagini grottesche e violente. |
| Cinema (es. Fritz Lang) | Scenografie distorte e anti-realistiche, uso esasperato del chiaroscuro, recitazione enfatica. Temi di follia, doppio, potere e ribellione. |
La poesia: il crepuscolo dell’umanità
Il manifesto letterario dell’espressionismo tedesco è l’antologia del 1919 Menschheitsdämmerung (“Crepuscolo dell’umanità”). Quest’opera raccoglie le voci di una generazione di poeti che, come Georg Heym, Gottfried Benn e Jakob van Hoddis, distruggono le forme tradizionali per rappresentare la crisi del loro tempo. Il tema centrale è la metropoli, in particolare Berlino. La città non è un luogo di progresso, ma un’entità crudele e labirintica che divora l’individuo. Nella poesia “Die Stadt” (“La città”) di Georg Heym, le strade sono un “sistema venoso” che trascina uomini in un’esistenza spenta.
Questo senso della fine è incarnato dalla lirica “Weltende” (“La fine del mondo”) di Jakob van Hoddis, che apre l’antologia con una serie di immagini apocalittiche e grottesche:
Al borghese dalla testa aguzza vola via il cappello,
tutt’intorno risuonano come delle grida.
Le tegole cadono dai tetti e vanno in frantumi
e sulle coste – si legge – sale la marea. […]
Le ferrovie cadono giù dai ponti.
Questi versi, simili a un montaggio cinematografico, mostrano la forte influenza delle arti figurative, in particolare delle opere del gruppo di pittori Die Brücke (“Il Ponte”).
L’espressionismo tedesco e il cinema
Negli anni ’20, durante la turbolenta Repubblica di Weimar, furono i registi a rendere l’estetica espressionista un fenomeno di massa. Il film manifesto è Il gabinetto del dottor Caligari (1920) di Robert Wiene, dove le scenografie dipinte con forme oblique e innaturali non rappresentano il mondo, ma la percezione distorta di un folle. Pochi anni dopo, Fritz Lang porta questa visione a un livello colossale con Metropolis (1927). Questo capolavoro distopico deve molto alle visioni dei poeti espressionisti: la città estraniante, il fallimento del progresso e lo sfruttamento della classe operaia sono al centro della sua opera. La metropoli è divisa verticalmente: i ricchi vivono nei grattacieli, mentre i poveri sono relegati nel sottosuolo. Questa città-mostro ricorda il “dio Baal” descritto da Georg Heym nella lirica “Der Gott der Stadt” (“Il Dio della città”):
Rosseggia il ventre di Baal nella sera,
grandi città s’inginocchiano intorno. […]
come un azzurro incenso a lui si innalzano
fuliggine e fumo di ciminiere.
Il cinema espressionista tedesco, con i suoi incubi visivi, non solo ha raccontato le paure di un’epoca, ma ha anche profondamente influenzato il linguaggio cinematografico, in particolare generi come l’horror e il noir.
Articolo aggiornato il: 13/10/2025