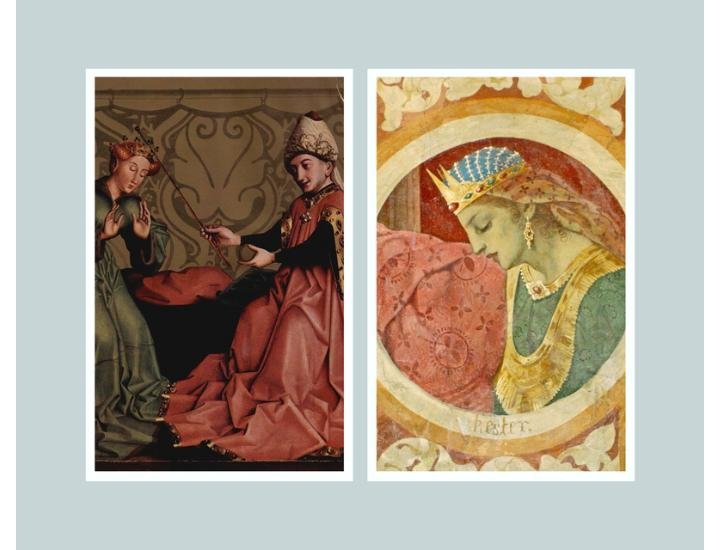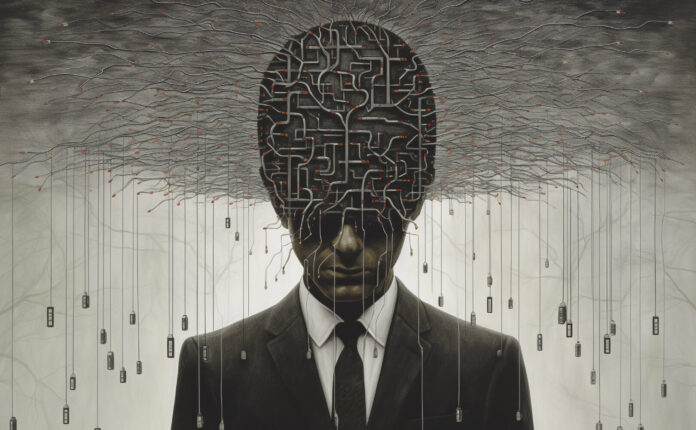«Con l’aiuto di Dio, prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge scout». Così recita la promessa degli scout, un impegno che ogni membro si prefigge di rispettare e seguire con o senza uniforme. Spesso ci capita di incontrarli per strada a eventi religiosi, culturali o a prender parte a manifestazioni finalizzate a promuovere la legalità ambientale o contro la criminalità organizzata.
Indice dei contenuti
Chi sono gli scout e perché non si chiamano “boy scout”?
Ma chi sono e cosa fanno gli scout? Innanzitutto, è importante chiamarli nel modo giusto. Si è soliti attribuire loro l’appellativo «boy scout» ed è cosa certa che a loro non piace essere chiamati in questo modo. Ma allora per quale motivo li conosciamo in questo modo?
La risposta risiede nelle origini del movimento. Fondato nel 1907 da Robert Baden-Powell, lo scoutismo era inizialmente rivolto esclusivamente ai giovani ragazzi con lo scopo di fornire una formazione fisica, morale e spirituale. Successivamente, grazie alla determinazione delle giovani ragazze, coordinate dalla sorella del fondatore, Agnes, venne inserito anche il Guidismo, movimento parallelo allo scoutismo prettamente femminile. Con l’intervento di Lady Olave, moglie di Baden-Powell, la proposta si estese a livello mondiale. Per questo quando incontrate gli scout per strada, fate attenzione a come li chiamate, il termine esatto e inclusivo è scout.
La promessa e la legge scout: i pilastri del movimento
La promessa è il momento solenne con cui si entra a far parte della grande fraternità mondiale scout. A essa si affianca la legge scout, un decalogo di valori positivi che guida il comportamento di ogni membro. Se la promessa è l’impegno, la legge ne delinea l’applicazione pratica. Secondo la formulazione dell’AGESCI (Associazione guide e scouts cattolici italiani), la più grande associazione scout in Italia, la legge recita:
- La guida e lo scout pongono il loro onore nel meritare fiducia.
- La guida e lo scout sono leali.
- La guida e lo scout si rendono utili e aiutano gli altri.
- La guida e lo scout sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout.
- La guida e lo scout sono cortesi.
- La guida e lo scout amano e rispettano la natura.
- La guida e lo scout sanno obbedire.
- La guida e lo scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà.
- La guida e lo scout sono laboriosi ed economi.
- La guida e lo scout sono puri di pensieri, parole e opere.
Uno stile di vita basato su valori concreti
Se si domanda ad uno scout come si fa ad esserlo, la sua risposta tempestiva è: «Lo si è, non lo si fa». Basato su valori ben definiti, lo scout sceglie questo movimento, ad oggi internazionale, come stile di vita sperimentando il contatto diretto con la natura, aggiungendo una buona dose di avventura e abilità manuale; riconoscendo il valore dell’essenzialità; garantire il proprio servizio al prossimo; comunicando l’amore per il creato, la fraternità e il principio di autoeducazione.
Le branche: un percorso di crescita per ogni età
Il concetto di fratellanza non esclude un percorso educativo strutturato, che può essere immaginato come una piramide formativa. All’interno dei gruppi scout si evincono delle precise categorie differenziate per età ed esperienza, chiamate “branche”. La crescita formativa cammina parallelamente alla crescita personale e anagrafica, con un metodo adatto a ogni fase dello sviluppo.
| Le branche dello scoutismo: un percorso per ogni età | |
|---|---|
| Branca (fascia d’età) | Motto e focus principale |
| Lupetti e coccinelle (8-11/12 anni) | Motto: “Del nostro meglio”. Focus: il gioco, la fantasia (“giungla” o “bosco”), la scoperta delle regole della comunità. |
| Esploratori e guide (11/12-16 anni) | Motto: “Estote parati” (siate pronti). Focus: l’avventura, la competenza tecnica, la vita in piccoli gruppi (squadriglia), la responsabilità. |
| Rover e scolte (16-20/21 anni) | Motto: “Servire”. Focus: il servizio al prossimo, la strada come metafora di vita, la scelta politica e la fede. |
Senza scopi di prevaricazione, i fratelli più piccoli prendono come riferimento e modello i fratelli maggiori e i loro capi.
Il ruolo dei capi: educatori e punti di riferimento
I “capi” e le “capo” scout sono adulti volontari che, attraverso un preciso iter formativo, basano tutte le attività sul metodo scout, contribuendo alla crescita sul campo e spirituale dei più giovani. «Con la tua grazia, Signore, fa che io sia sempre loro di esempio e mai d’inciampo che essi in me vedano te». Così recitano i capi, nella loro preghiera. È chiaro che, dovendo indirizzare dei giovani ed essere per loro un punto di riferimento, un capo deve avere una preparazione solida, una spiccata empatia e senso di responsabilità. Per questo sono in costante aggiornamento, impegnati in campi ed esperienze di formazione continua per garantire la qualità della proposta educativa.

Oltre gli stereotipi: l’impegno sociale
Una scelta educativa come questa, soprattutto in età puerile, consente di progettarsi sin da bambini e a relazionarsi con il prossimo. Il tutto avviene attraverso eventi e uscite che consentono di forgiare il carattere, di apprendere nuove competenze e di impegnarsi concretamente sul territorio, seguendo la responsabilità politica e sociale che propone lo scoutismo. «Vi terrete sempre pronti in spirito per compiere il vostro dovere» (B.P.).
Lo scoutismo troppo spesso viene banalizzato, riducendo il tutto a un gruppetto di «venditori di biscotti con calzoncini e calzettoni, anche d’inverno»; va sottolineato e rimarcato il loro impegno sociale di organizzazione no profit volto a sensibilizzare e migliorare il senso civico ed egualitario, di genere o etnia. Senza dimenticare che ovviamente il tutto viene accompagnato da una buona e sana dose di divertimento.
Pertanto, se doveste imbattervi in uno scout, rivolgetegli un sorriso e augurategli «buona strada!», poiché la loro è in costante salita.
Immagine in evidenza: sasint by pixabay.com
Articolo aggiornato il: 15/09/2025