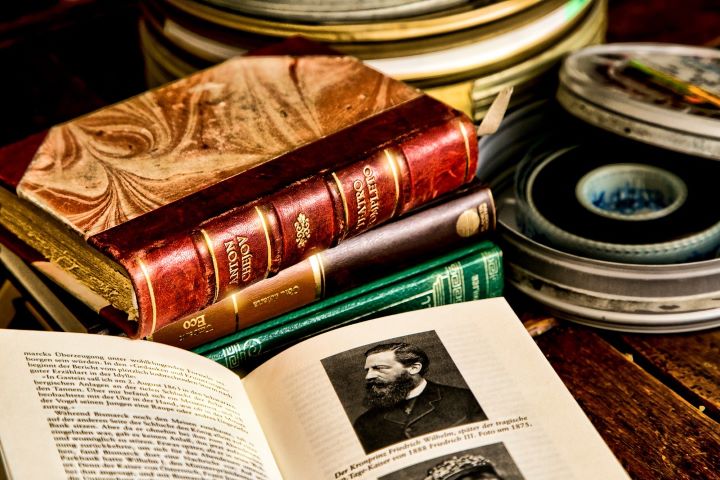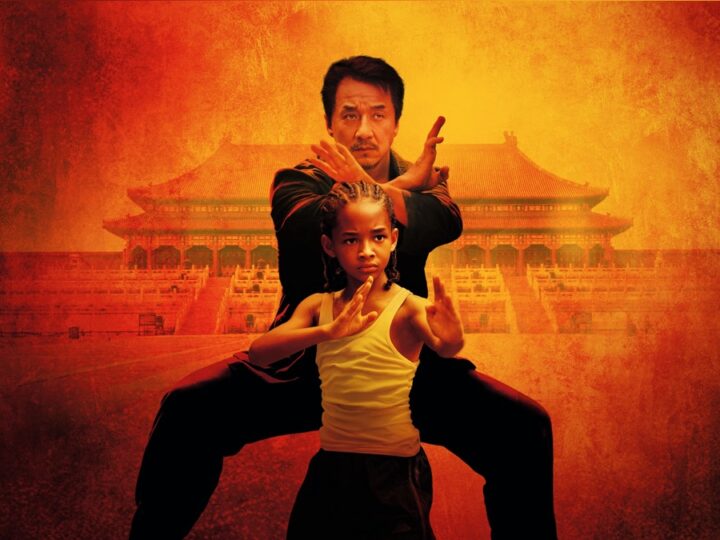Personaggio affascinante e ambiguo, Clark Olofsson è stato uno dei criminali più celebri della Svezia e del mondo intero. Il suo nome è legato indissolubilmente alla nascita di un concetto che è ormai entrato nel linguaggio comune: la sindrome di Stoccolma. La vita di Clark Olofsson è stata segnata da rapine, truffe, fughe continue; Netflix ha così deciso di dedicargli nel 2022 una miniserie intitolata Clark, che trasforma la sua biografia in un racconto allo stesso tempo ironico, surreale e drammatico, restituendo tutta la potenza di un personaggio che ancora oggi divide l’opinione pubblica.
Chi era Clark Olofsson: una vita al limite
Nato nel 1947 a Trollhättan, nella Svezia industriale, Olofsson ebbe un’infanzia piuttosto difficile. Il padre alcolizzato abbandonò la famiglia, la madre non riuscì a gestire la situazione e Clark finì presto in istituti per ragazzi problematici. Appena diciannovenne, partecipò a una rapina in cui perse la vita un poliziotto. Lui riuscì a scappare, ma da quel momento il suo nome cominciò a circolare nei giornali svedesi.
Divenne noto negli anni ’60 e ’70 per una serie di rapine spettacolari e per le sue continue evasioni dal carcere. In un’occasione fuggì dalla prigione di Kumla nascondendosi in un container per la spazzatura; un’altra volta riuscì ad arrampicarsi sui tetti durante l’ora d’aria, dileguandosi sotto il naso delle guardie. Ogni fuga alimentava la leggenda. La stampa lo definiva “il bandito impossibile da fermare” e il pubblico ne rimaneva profondamente affascinato. Al di là della figura del criminale, infatti, Olofsson è stato anche un uomo capace di calamitare l’attenzione dei media su di sé per il suo carisma, la sua bellezza, il suo essere sfuggente. Ha finito quindi per incarnare il mito del bandito romantico che sfida lo Stato, cosa che nel corso del tempo gli ha garantito ance risonanza internazionale.
La fama mondiale: la rapina alla Kreditbaken di Stoccolma
La sua fama esplose definitivamente nel 1973, durante la rapina alla Kreditbanken di Stoccolma. ll rapinatore Jan-Erik Olsson, il 23 agosto, prese in ostaggio quattro dipendenti e chiese che venisse liberato proprio Clark Olofsson, che all’epoca era in carcere. La polizia, nel tentativo di calmare Olsson, acconsentì. Olofsson venne così portato in banca come “mediatore”. In realtà, invece di disinnescare la situazione, contribuì a trasformarla in un caso mondiale. Gli ostaggi, contro ogni aspettativa, cominciarono a mostrare empatia e solidarietà verso i rapinatori nei sei giorni di sequestro. Da qui nacque l’espressione “sindrome di Stoccolma”, oggi usato in psicologia per descrivere il legame paradossale che si instaura tra vittime e carnefici.

Kristin Enmark, una degli ostaggi, dichiarò alla stampa che non temeva i rapinatori, ma piuttosto la polizia, accusata di mettere a rischio le loro vite con le irruzioni. Altri ostaggi si rifiutarono di testimoniare contro Clark Olofsson e Jan-Erik Olsson. Alcuni di essi andarono perfino a visitarli in carcere. Il termine “sindrome di Stoccolma” venne coniato dallo psichiatra svedese Nils Bejerot, consulente della polizia durante l’assedio alla Kreditbanken. Non è stato mai incluso nei manuali diagnostici ufficiali, come il DSM, ma casi simili sono stati registrati in tutto il mondo: basti pensare all’ereditiera americana Patty Hearst, che finì per unirsi al gruppo armato che l’aveva rapita.
Secondo gli psicologi, la sindrome di Stoccolma non è una malattia in senso clinico, ma una strategia di sopravvivenza inconscia. Quando una vittima si trova totalmente in balia del suo carnefice, ogni minimo gesto di clemenza (che sia anche semplicemente non colpire, non uccidere o offrire un bicchiere d’acqua) viene percepito come un atto di bontà, un segno di possibile alleanza. Trovandosi in un contesto di ansia estrema, il cervello riduce il conflitto trasformando il sequestratore da nemico assoluto a figura quasi protettiva. Questo è esattamente quello che successe agli ostaggi della rapina di Stoccolma del 23 agosto 1973.
La serie Netflix Clark
Diretta da Jonas Åkerlund, già regista di Lords of Chaos e di videoclip per artisti come Madonna, Rammstein e Beyoncé, Clark non solo racconta la vita del criminale svedese, ma si spinge anche oltre, soprattutto per il modo in cui lo fa. Si tratta di un vero e proprio viaggio dentro l’anima eccessiva e contraddittoria di Clark Olofsson, trasformata in puro spettacolo visivo.
A vestire i panni del protagonista è Bill Skarsgård, attore noto per It e Castle Rock, qui in una delle sue interpretazioni più magnetiche. Il suo Clark, con i suoi sguardi seducenti e i suoi sorrisi disarmanti, è affascinante e inquietante allo stesso tempo. Dietro lo charme, si nasconde costantemente il pericolo. La serie sceglie un linguaggio visivo volutamente estremo, utilizzando colori molto saturi, montaggi frenetici, improvvisi inserti cartoon, momenti grotteschi che si alternano a scene di cupa intensità drammatica. La serie ha un’estetica pop che riflette perfettamente il carattere del suo protagonista, sempre in bilico tra realtà e leggenda.

Gli episodi ripercorrono i passaggi cruciali della sua esistenza: l’infanzia difficile, segnata da abusi e violenza familiare; le prime rapine e i colpi spettacolari che lo resero un nome noto in tutta la Svezia; i rapporti burrascosi con le donne, tra seduzione e manipolazione; la rapina di Norrmalmstorg e la nascita della sindrome di Stoccolma; gli anni successivi, scanditi da processi, condanne, evasioni e un’attenzione mediatica costante.
Il merito di Clark sta proprio nel suo non presentarsi né come un documentario né come un dramma realistico, ma come un ritratto complesso che prende la figura di Olofsson e la trasforma in un’icona pop, quasi fumettistica. La storia di un uomo che è stato capace di passare dalla cronaca nera alla mitologia contemporanea, diventando il simbolo di quel fascino ambiguo che il male esercita da sempre sul pubblico.

Criminalità, cultura pop e ironia: l’esempio di Clark Olofsson
Il vero colpo di scena di Clark, quello che forse colpisce più di tutto, non sta tanto nelle rapine o nelle evasioni spettacolari, ma nello sguardo ironico con cui Åkerlund rilegge la vita del protagonista. Una scelta narrativa e stilistica che pare quasi azzardata, non consona alla materia; un tono che pare addirittura stonare. L’umorismo dissacrante, unito alle continue rotture di registro e l’elemento grottesco, però è tutt’altro che casuale. L’unione di questi elementi trasforma la violenza in spettacolo, rendendo Clark Olofsson una sorta di antieroe pop, più vicino a un personaggio di fumetto che a un criminale in carne e ossa.
Questa scelta narrativa mostra come i media e la cultura pop siano capaci di trasformare figure criminali in miti collettivi, dove l’ironia diventa lo strumento che permette di guardare al male senza esserne travolti. Clark è quindi meno un racconto giudiziario e più un riflesso del nostro immaginario contemporaneo, quello in cui la realtà si mescola alla leggenda e persino il crimine può diventare intrattenimento.
Fonte immagine in evidenza: Netflix