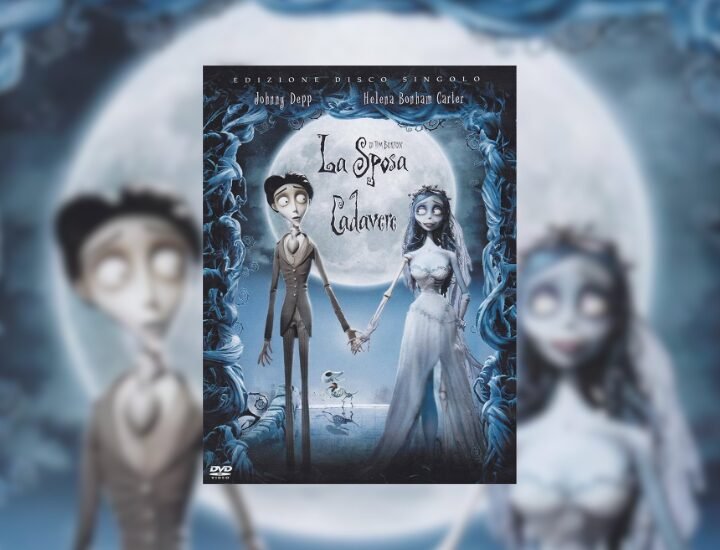L’espressionismo è stato un importante movimento artistico nato intorno al 1908 che si sviluppò soprattutto nel campo della pittura, del teatro e del cinema. In quest’ultimo ambito, l’espressionismo tedesco diede vita a un vero e proprio genere, che influenzò profondamente la storia del cinema durante gli anni Dieci e Venti del Novecento. Come molte altre avanguardie artistiche contemporanee, l’Espressionismo fu inizialmente una reazione al realismo che aveva dominato l’arte figurativa fino all’avvento dell’Impressionismo e fu il primo a esplorare una nuova strada per l’arte, un’estetica essenzialmente legata alla realtà interiore.
Indice dei contenuti
Nascita e caratteristiche dell’espressionismo tedesco nell’arte
L’Espressionismo tedesco nacque a Dresda da quattro studenti di architettura e si sviluppò nelle difficili condizioni socio-economiche che seguirono le sanzioni imposte alla Germania dopo la fine della Prima Guerra Mondiale.
Die Brücke: il ponte verso una nuova estetica
L’Espressionismo tedesco deriva principalmente dalla fondazione di un movimento chiamato Die Brücke (“Il Ponte”), il cui obiettivo dei fondatori era quello di ‘’gettare un ponte’’ tra la pittura classica neoromantica e il nuovo stile che sarebbe poi stato chiamato “Espressionismo”. Guardando alla filosofia tedesca, in particolare a Nietzsche, gettano le basi di questo nuovo movimento artistico con l’intento di rinnovare completamente un linguaggio artistico che affronti non solo la bellezza del mondo contemporaneo, ma soprattutto il dramma dell’uomo moderno.
La ricerca della soggettività e la critica sociale
Nell’arte, l’Espressionismo tedesco è un movimento che si caratterizza dalla ricerca della soggettività nella realtà circostante. L’arte, con le sue innovazioni, diventa per l’uomo un mezzo indispensabile per superare gli ostacoli. Gli espressionisti tedeschi prestarono particolare attenzione all’espressione di Van Gogh, ai contrasti cromatici dei Fauve, al dramma e alla critica sociale di Munch e all’espressione figurativa di forte impatto che trasmetteva una dura critica ai valori della cultura borghese. Gli elementi della metropoli, della vita di strada e del circo stimolano riflessioni sulla solitudine umana e sull’alienazione, rappresentate da segni netti e colori acidi.
L’espressionismo tedesco nel cinema: un nuovo linguaggio visivo
Con la fine della Prima Guerra mondiale, lo Stato tedesco promosse la rinascita del cinema, considerandolo un potenziale veicolo di sviluppo e propaganda. Fu istituito un unico organismo statale, l’U.F.A. (Universum Film AG), con il compito di supervisionare la produzione e il mercato cinematografico, con finanziamenti forniti dalla Deutsche Bank. In questo periodo, i produttori divennero figure centrali. Uno dei più importanti fu Erich Pommer, che insistette sull’alta qualità dei film per mantenere la competitività internazionale.
Le caratteristiche stilistiche del cinema espressionista
Per tradurre nel cinema la distorsione dell'”espressionismo”, che sostituisce la rappresentazione oggettiva della realtà con la percezione soggettiva, fu necessario recuperare i trucchi del cinema delle origini per ricreare mondi illusori e surreali. Ecco alcune delle principali caratteristiche stilistiche:
- Distorsione dello spazio: scenografie con linee oblique, forme aguzze e prospettive alterate per esternare gli stati interiori dei personaggi.
- Uso simbolico della luce: il forte contrasto tra luce e ombra (chiaroscuro) diventa un elemento narrativo, spesso per rappresentare la lotta tra bene e male.
- Recitazione stilizzata: la gestualità degli attori era esagerata, quasi coreografica, con movimenti a scatti e antinaturali per esprimere le emozioni in modo viscerale.
- Trucco pesante ed espressivo: i volti erano pesantemente truccati per accentuare le espressioni e creare maschere grottesche.
- Tematiche gotiche e soprannaturali: le storie attingevano al regno delle ombre, con temi come la follia, il doppio (doppelgänger), l’incubo e il conflitto interiore.
- Soggettività della narrazione: la realtà rappresentata non era oggettiva, ma filtrata attraverso la mente disturbata dei protagonisti.
I capolavori del cinema espressionista tedesco
I temi della possessione, dello sdoppiamento e della malattia dominano il cinema espressionista. I personaggi si confrontano con qualcosa di diverso da sé, sono in conflitto e costretti a sdoppiarsi.
| Capolavori e loro innovazioni principali | Tema o innovazione chiave |
|---|---|
| Lo studente di Praga (1913) – S. Rye | Considerato il precursore, introduce il tema del doppelgänger (il doppio). |
| Il gabinetto del Dott. Caligari (1920) – R. Wiene | Il manifesto del movimento: la scenografia distorta riflette la psiche del narratore. |
| Nosferatu il vampiro (1922) – F. W. Murnau | Porta l’orrore e le ombre espressioniste in ambienti reali, non solo in studio. |
| Metropolis (1927) – F. Lang | Applica lo stile a una scala monumentale per creare una distopia fantascientifica. |
Lo studente di Praga (1913): il primo film d’autore
Lo studente di Praga è un film muto di Stellan Rye ed è considerato il primo esempio al mondo di cinema d’autore. La trama racconta di uno studente, Baldovino, che si innamora di una contessa. Per conquistarla, accetta la proposta di un personaggio simile a Mefistofele, il dottor Scapinelli, che compra il suo riflesso allo specchio in cambio di denaro. Il film è un manifesto programmatico per l’intera corrente per i suoi temi: il doppelganger, la sensibilità per il soprannaturale e l’operare di forze maligne che limitano il libero arbitrio umano.
Il gabinetto del dottor Caligari (1920): il manifesto dell’espressionismo
Il gabinetto del dottor Caligari, conservato anche presso il MoMA di New York, è stato il film di riferimento, in cui si ritrovano tutte le caratteristiche fondamentali del movimento. La storia ha per protagonista Franz, un giovane che racconta eventi misteriosi accaduti nel suo villaggio dopo l’arrivo del Dottor Caligari e del suo sonnambulo. Ciò che sconvolge lo spettatore sono le inquadrature su set allucinanti dalla geometria impossibile, con spigoli vivi, ombre minacciose e percorsi tortuosi che rappresentano il mondo interiore del narratore. Il colpo di scena finale rivela che Franz è un paziente di un manicomio e che la storia è un prodotto della sua mente malata.
Metropolis (1927): il capolavoro di Fritz Lang
Metropolis è il precursore di tutti i principali film di fantascienza. Fritz Lang ambientò il film in un futuro distopico (2026), in cui le divisioni di classe sono estreme. Ha influenzato film come Blade Runner e Guerre stellari. La città di Metropolis è divisa in due: la città alta dei ricchi e la città bassa degli operai-schiavi. L’espressionismo in Metropolis sta nella sua geometria estrema dello spazio e dell’architettura, che dà l’idea che gli esseri umani vivano sotto stretto controllo in gabbie. Il set è stato creato utilizzando l’innovativo “effetto Schüfftan“, che combinava scenografie reali e miniature riflesse da specchi.
Altri film importanti dell’espressionismo tedesco
Oltre ai film citati, meritano una menzione anche Nosferatu il vampiro (1922) di Friedrich Wilhelm Murnau, L’uomo di cera (1924) di Paul Leni e Destino (1921) di Fritz Lang, altri capolavori del cinema espressionista tedesco.
L’eredità dell’espressionismo tedesco nel cinema
Il mondo rappresentato dallo sguardo espressionista è caratterizzato da caos, stranezza e anomalie. Il cinema espressionista parla di un mondo interiore, collegando la realtà con i sogni e gli incubi. Al di là della percezione dello sguardo, il cinema espressionista scava strati più profondi della realtà, fatti di incubi, ossessioni e illusioni. L’espressionismo tedesco ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, influenzando generazioni di registi e contribuendo alla nascita di generi come il film noir e l’horror. La sua eredità è ancora oggi visibile in molte opere cinematografiche contemporanee.
Fonte immagine in evidenza per l’articolo sull’espressionismo tedesco: dal film Il gabinetto del dottor Caligari (Wikipedia)
Articolo aggiornato il: 11/09/2025