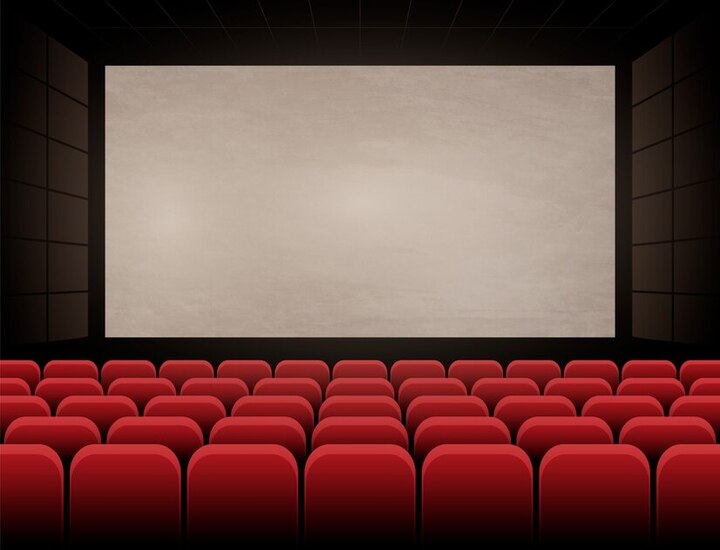A partire dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso si iniziò a parlare in ambito filosofico di postmodernismo. Il termine compare per la prima volta nel saggio La condizione postmoderna, scritto da Jean-Francois Lyotard nel 1979. Secondo il filosofo francese le grandi ideologie figlie dell’illuminismo (esaltazione del progresso tramite lo sviluppo economico e tecnico, le ideologie guidate dall’uguaglianza sociale, l’esaltazione della scienza come liberatrice dalle catene oppressive della religione, l’idea di una giustizia universale) e definite “grandi narrazioni”, giunte nell’età contemporanea iniziano a venire meno.
I motivi principali di questa crisi di ideali sono due: il primo è il susseguirsi lungo il ‘900 di eventi storici il cui impatto è stato talmente drammatico che non è possibile appellarsi alla sicurezza di cui quelle idee erano costituite per spiegarli (in che modo si possono interpretare le atrocità di Auschwitz o dei gulag sovietici in termini puramente razionali?). Il secondo è invece la diffusione, a partire dagli anni ’60 e ’70, di nuovi mezzi audiovisivi quali la televisione e la pubblicità che, assieme al cinema e alla letteratura, offrono nuove chiavi di lettura all’interno di una società industrializzata e globalizzata.
La conseguenza è di grande portata: il sapere non è più un valore assoluto, ma esistono tante realtà con tante diverse caratteristiche (i telegiornali si diversificano per offrire versioni diverse di una stessa notizia, la pubblicità induce a comprare prodotti di cui non si ha veramente bisogno e che tuttavia possono servire per acquisire uno status sociale, etc.). Il postmodernismo è quindi riassumibile con il concetto di “superamento della modernità” o di tutte quelle idee che fino al XX secolo avevano portato avanti la società umana e che davanti ad una realtà multiforme finiscono per esaurire la propria spinta propulsoria. La fiducia nel progresso e nella scienza sembrano spegnersi, accanto a tutte le idee che hanno contraddistinto il modernismo.
Il postmodernismo non è ovviamente sola prerogativa delle menti pensanti della filosofia, ma si diffonde anche presso quelle creative dell’arte. Lo si vede in movimenti artistici come la Pop Art (l’idea di oggetto comune elevata a opera d’arte) o nella letteratura con espedienti quali il dialogo metaletterario con il lettore (Se una notte di inverno un viaggiatore di Italo Calvino), l’inizio della vicenda dalla sua fine (La freccia del tempo di Martin Amis), il citazionismo che si traduce nell’imitazione di tecniche come quella del manoscritto ritrovato (Il nome della rosa di Umberto Eco) e molti altri ancora.
Il Postmodernismo cinematografico
La verità messa in discussione. Metacinema e mockumentary
In tutto questo contesto il cinema come si evolve? Essendo l’arte che fa dell’immagine una delle sue prerogative, non ci mette molto a interrogarsi sulla molteplicità delle immagini che la società dei consumi impone.
Il cinema del postmodernismo si interroga innanzitutto sulla sua funzione di spettacolo fittizio, di storia costruita da un insieme di immagini e di prodotto concepito in un ambiente come quello cinematografico. Il cinema di Jean Luc-Godard, uno dei padri fondatori della Nouvelle Vague francese, è pieno di espedienti metacinematografici volti a mostrare l’ascetico ordine con cui il cinema costruisce le sue storie. La sequenza iniziale di Fino all’ultimo respiro (1960) mostra Jean-Paul Belmondo girare il proprio sguardo verso la macchina da presa interpellando direttamente lo spettatore, infrangendo uno dei comandamenti cardine che l’attore deve seguire: quello di non guardare mai verso l’obiettivo, pena l’interruzione della fictio cinematografica. Invece i titoli di testa de Il disprezzo (1963), tratto dal romanzo di Alberto Moravia, mettono a nudo la natura artificiale del film mostrando il regista che compie una ripresa in carrellata e nel frattempo una voce fuoricampo illustra le personalità che lo costituiscono (attori, fotografia, montaggio, colonna sonora, etc.).
Altro esempio di metacinema è 8 ½ (1963), diretto da Federico Fellini. Tutta la vicenda del film ruota attorno al nuovo film che il regista Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) è in procinto di girare, salvo poi rimandare le riprese subendo le pressioni di colleghi e amici. In questo caso però il piano del reale, rappresentato dalla vita e dai ricordi personali di Guido, finisce per confondersi con quello della finzione in pellicola che culmina nella sequenza finale, con tutti i personaggi del film che si esibiscono in una vera e propria passerella sul set del film.
Ma nel postmodernismo il cinema non si limita soltanto a smascherare la “falsità” della storia narrata, ma indaga anche sui meccanismi a tratti malati su cui il sistema “cinema” si basa e su come decomponga le immagini e i volti degli attori. David Lynch lo mostra nel criptico Mulholland Drive (2001), dove l’immagine di Hollywood come terra dei sogni scompare e lascia il posto ad una terra inquietante e tetra, descritta nei suoi processi produttivi filtrati dall’incubo e dall’onirismo.
https://youtu.be/7MLMLvSqT6g
I confini tra vero e falso vengono poi esplicitati da un particolare sottogenere di film, il mockumentary. La traduzione in “falso” (mock-) “documentario” (-umentary) suggerisce la natura di questo prodotto, che ha come base l’intenzione di far passare per reali eventi che non lo sono. Prendi i soldi e scappa (1969) di Woody Allen è impostato come un documentario sulla vita del ladro Virgil Starkwell, interpretato da Allen stesso, in cui la vicenda del protagonista si alterna a scene di archivio, come le interviste ai genitori e a persone vicine a lui.
A sfruttare ampiamente il mockumentary è il genere horror, tramite l’espediente del video ritrovato (found footage) come in The Blair Witch Project (1999) di Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez. Grazie anche ad una massiccia campagna pubblicitaria in cui la vicenda narrata veniva spacciata come vera, ovvero quella di un gruppo di giovani videomaker che scompaiono nel bosco durante le ricerche di una strega, il film ha riscosso un grande successo proprio perché il pubblico si è “bevuto la storia” e in un’epoca in cui internet ancora non era un crocevia incessante di informazioni come oggi.
I cardini del cinema del postmodernismo: antinarratività e citazionismo
Se il postmoderno è l’epoca della frammentarietà della realtà che non è più un certezza assoluta, il cinema vi si adegua mettendo in pratica quello che già stava facendo la letteratura: la rinuncia alla linearità del racconto, frammentando le unità aristoteliche di tempo e spazio per conferire al racconto una diversa linea di sviluppo. Apripista di questa tendenza è C’era una volta in America (1984), ultimo film di Sergio Leone che ricostruisce le vicende di una gang di malavitosi di origine ebrea attraverso la convivenza di tre linee temporali sullo stesso piano della narrazione (giovinezza, età adulta, vecchiaia). Lo spettatore viene poi chiamato a capire se tutto quello che ha vissuto il protagonista Noodles (Robert de Niro) è accaduto davvero o se sia stato soltanto un sogno, come simboleggia l’ultimo enigmatico fotogramma della pellicola. Alcune volte invece l’atemporalità e l’antilinearità consistono semplicemente nel far iniziare il film con la sua scena finale per poi sciogliere la vicenda tramite quello che dovrebbe essere il suo inizio, come in Memento (2000) di Christopher Nolan.
Diverso è il caso di Quentin Tarantino, che in Pulp Fiction (1994) mette in scena una vicenda in cui la narrazione viene frantumata in più microstorie che finiscono per intrecciarsi tra di loro tramite i loro protagonisti. Da notare inoltre come il cinema di Tarantino è forse quello che si diverta più di tutti a dilatare il tempo della narrazione, tramite l’espediente dei dialoghi sagaci e brillanti che spesso finiscono per stereotipare elementi tipici di un genere. Restando sempre su Pulp Fiction i due sicari Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) si abbandonano a diatribe sugli hamburger e sui massaggi ai piedi lungo tutto il tragitto che li conduce nell’appartamento di due criminali a recuperare un misteriosa valigetta il cui contenuto non verrà mai mostrato.
La valigetta, che cita la tecnica del MacGuffin di Hitchcock (una qualcosa che non serve a nulla per le funzioni della trama), introduce a quella che è la cifra stilistica del cinema di Tarantino: il citazionismo. L’immensa cultura cinematografica del regista, che va dalla Nouvelle Vague al cinema asiatico passando per il grande cinema americano e quello di genere italiano, si può inserisce bene nella tendenza del postmodernismo di rinunciare non soltanto a raccontare qualcosa, ma anche di essere “innovativo”. In pratica il cinema non può che attingere al suo stesso patrimonio che qui viene spesso rielaborato in maniera ironica ed esasperato tramite l’uso della violenza massiccia. Dai tributi al cinema d’arti marziali orientale nel dittico di Kill Bill (2003 e 2004) a quello blaxploitation di A prova di morte (2007), fino al malinconico omaggio al cinema americano degli anni ’70 in C’era una volta a Hollywood (2019), non c’è film di Tarantino che non sia imbevuto di citazioni cinematografiche.
Anche Brian de Palma fa ampio uso del citazionismo, spesso riprendendo a scene iconiche della storia della cinema e privandole del loro significato originario. Ne Gli Intoccabili (1987) rielabora la celebre scena della scalinata di Odessa de La corazzata Potemkin (1927) di Sergej Ejzenstein.
Nel film di de Palma la scena viene ambientata all’interno di una stazione della metropolitana nella Chicago degli anni ’30. Ma oltre a cambiare l’ambientazione e il contesto temporale, qui cambia anche il suo significato. Se nella Corazzata la carrozzina che scorreva giù per la scalinata rappresentava il culmine raggiunto dall’animo dello spettatore in modo da spingerlo a ribellarsi all’oppressione del potere zarista, ne Gli Intoccabili si riduce a una sparatoria tra poliziotti e malavitosi. Il maggior richiamo al film sovietico è l’assenza delle voci nella scena (richiamo/omaggio al cinema muto), sostituite dagli spari delle pistole e da una musica drammatica.
De Palma omaggia anche il cinema classico americano. In Vestito per uccidere (1980) si richiama a Vertigo (1950) di Alfred Hitchcock girando una scena all’interno di un museo, che anche qui diventa luogo dell’infatuamento amoroso. Scarface (1983) è un vero e proprio remake che omaggia l’omonimo film di Howard Hawks (1927), seppur con due differenze fondamentali: la diversa epoca in cui la vicenda è ambientata (dalla Chicago degli anni ’30 in pieno regime proibizionista alla Miami degli anni ’80 fatta di luci al neon e musica disco) e la presenza di una violenza più esplicita che nel film di Hawks era, seppur presente, molto limitata.
I generi: riletture, parodie, contaminazioni
Nel cinema del postmodernismo nemmeno i generi restano uguali a prima. Essi vengono riletti e rielaborati, come accadeva a Hollywood negli anni ’70 e da noi in Italia con lo spaghetti western e l’horror. Ma vengono anche degenerati attraverso la commedia che è sicuramente uno dei generi postmoderni per eccellenza, in quanto risponde alle esigenze di rilettura della realtà, dialogo continuo con il passato e presa in giro nei confronti dei cliché del genere.
La filmografia di Mel Brooks risponde a queste esigenze. I suoi film sono parodie tanto di generi ben codificati quanto di franchise di successo, grazie anche all’arricchimento di citazioni cinefile. Frankenstein Junior (1974) è una divertente rilettura dei classici dell’horror Frankenstein (1931) e La moglie di Frankenstein (1935), entrambi diretti da James Whale e dai quali Brooks prende le attrezzature originali, come i macchinari che servono a Victor von Frankenstein (Gene Wilder) per dare la vita alla sua creatura. Le atmosfere sono quelle del cinema horror degli anni ’30 (uso del bianco e nero e transizioni da una scena all’altra che si richiamano a quello stile) arricchite ovviamente da un umorismo sfrenato che ironizza sugli stereotipi. Invece Balle Spaziali (1987) rilegge in chiave comica il cinema di fantascienza, in particoalr modo la saga di Guerre Stellari e il relativo impatto che ha avuto tramite anche il suo merchandising avvalendosi anche di giochi metacinematografici, che mettono in crisi la fictio del film.
Un altro modo per fare parodia è la contaminazione di generi e forme, con risultati davvero sorprendenti. Robert Zemeckis lo dimostra con Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988) un film a tecnica mista che fa interagire gli attori in carne ed ossa con quelli disegnati a mano. Ma il suo essere “postmoderno” risale proprio al suo essere una contaminazione di genere che nasce da un contrasto. L’atmosfera oscura e brutale tipica del cinema noir incontra il mondo colorato e bizzarro dei cartoni per mezzo di una trama incentrata su un omicidio avvenuto proprio in quel mondo che spesso viene identificato con la dimensione dell’immaginario e dei più piccoli. Zemeckis fa quindi dialogare personaggi della cultura di massa come Paperino e Duffy Duck in un mondo “adulto”, che ha come rappresentante animato la prorompente Jessica Rabbit (altro evidente contrasto tra innocenza e trasgressione).
Carica di ironia rielaborista è anche l’epopea dei mafiosi italoamericani che in Quei Bravi Ragazzi (1990) di Martin Scorsese viene filtrata dalla lente del documentario Accanto alla violenza tipica del gangster movie si aggiunge una componente intima e a tratti ironica tramite la quale vediamo la “vita quotidiana” degli appartenenti all’ambiente malavitoso tra feste in famiglia, credenze popolari e quanto altro.
Interessante è invece il caso di Baz Lurhmann. Il cinema di questo regista australiano è caratterizzato dalla commistione sullo stesso piano di cultura alta e di cultura pop, che ben si esplicita in Romeo + Juliet (1996) e Moulin Rouge! (2001). Nel primo film Lurhmann rilegge la celebre tragedia elisabettiana di William Shakespeare trasformando le famiglie nobiliari dei Montecchi e dei Capuleti in gang rivali che si fanno la guerra lungo le strade di Verona Beach, a sua volta trasfigurazione della Verona rinascimentale del testo di partenza, con la classica storia d’amore tra i due giovani rielaborata in piene atmosfere anni ’90. Diverso è invece il caso della seconda pellicola: la collocazione temporale, la Parigi di inizio ‘900, resta inalterata ma viene arricchita da musica e canzoni che vanno dalla dance al rock. Modello che viene seguito anche ne The Great Gatsby (2013).
Cinema, televisione e web
L’ultima parte di questo lunghissimo excursus sul cinema del postmodernismo è dedicato al dialogo/scontro che il cinema ha nei confronti dei nuovi media, in linea con il concetto di “pluralità di immagini e plurarlità di realtà”.
Il principale incontro/scontro del cinema del postmodernismo è quello con il media televisivo, la cui industria crea e plasma una cultura omogenea fruibile per ogni classe e per ogni strato sociale anche al costo di cancellarne la storia e le tradizioni (uno dei motivi per cui Pasolini si scagliò contro di esso).
Il cinema del postmodernismo ovviamente si interroga sul potere che la televisione suscita nei confronti dello spettatore, creando per lui mondi alternativi e, in un certo, “consolatori”. Peter Weir in The Truman Show (1998) gioca con questo concetto mettendo al centro la storia di un uomo, Truman Burbank (Jim Carrey), che fin dalla nascita vive in una sorta di reality show dove tutto è programmato (gli studi, le amicizie, gli amori, la famiglia, il lavoro..) dal suo regista Christoff (Ed Harris), un uomo che si comporta come una divinità (il suo nome, non a caso, richiama a Cristo, figlio e profeta di Dio). Il potere esercitato dal mezzo televisivo è qui simboleggiato dall’uso massivo della pubblicità di cui si fanno portavoce gli attori della “recita”, dall’obiettivo della macchina televisiva che assume sembianze televisive e soprattutto dal pubblico a casa che si appassiona alla vita di Truman, privato della propria natura umana e divenuto un fantoccio idolatrato. Lo stesso concetto si ritrova in una forma molto più cupa in Assassini Nati (1994) di Oliver Stone, storia di due serial killer che vagano lungo gli USA e le cui gesta vengono registrare e trasmesse dalla stampa, al punto da creare una schiera di accoliti che li idolatra. La differenza con il film di Weir è la pluralità di linguaggi adoperati che variano dalla sit com al cartone animato, usati in chiave satirica per criticare il modo in cui i media alimentano la violenza riempiendo di gloria i criminali
Il cinema del postmodernismo è però anche il cinema che si interroga sul web, creatore di nuove narrazioni volte a sostituire quella della realtà che ha perso oramai valore (si pensi al medium videoludico, capace di essere tanto simulatore di realtà quanto una narrazione che nulla ha da invidare a quella in celluloide). Il film emblema di tutto ciò è ovviamente Matrix (1999), diretto dalle sorelle Wachowski. Partendo da un elemento di base antico, cioè il mito della caverna di Platone, si costruisce la vicenda di Neo (Keanu Reeves) che scopre l’esistenza di una realtà alternativa che a sua volta regola quella in cui viviamo, metafora che anticipa in un certo senso il multiforme mondo d’apparenza dei social network e di internet fatto di immagini precostituite e che nel loro essere idolatrate dagli internauti finiscono per essere integrate nel tessuto della realtà.
Che Matrix sia stato un film profetico per i tempi attuali non è un mistero. Il fatto che ognuno oramai possa girare video immediati tramite webcam e fotocamere integrate nei cellulari di ultima generazione e che subito fanno il giro tramite Facebook, Instagram, You Tube e molti altri siti, ha fatto sì che si edificassero nuove realtà su cui si costruisce un mito da idolatrare e un’aura attorno creata dal pubblico (dagli influencer ai politici, ma anche il cittadino comune). C’è la mania di apparrire, il desiderio e l’illusione di poter divenire famosi grazie all’immediatezza di un selfie o di un paio di stories su Instagram, nuove narrazioni che hanno come lievito madre la propria esistenza. Nuovi divi, nuovi esseri di nervi e sangue che non hanno bisogno di luci e innarivibilità come lo sono stati (e sono ancora) i divi del cinema. Davanti a questo scenario diventano profetiche anche le parole attribuite ad Andy Warhol:«Nel futuro tutti saranno famosi per 15 minuti» .
Ciro Gianluigi Barbato
Fonte immagine copertina: https://www.taxidrivers.it/45183/rubriche/squarci-di-settima-arte-sul-concetto-di-stile-postmoderno-nel-cinema-statunitense.html
Per saperne di più sul rapporto tra cinema e postmodernismo vi consigliamo Il Cinema Postmoderno di Bruno Roberti, accessibile dal sito web della Treccani.