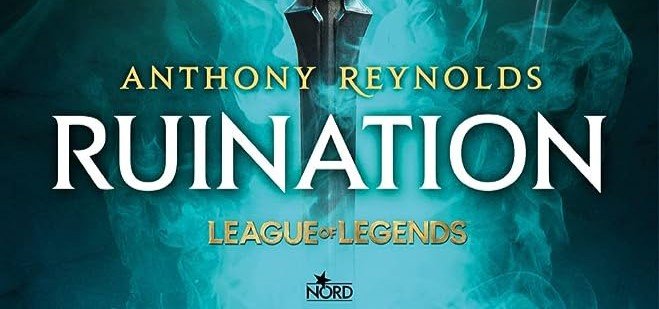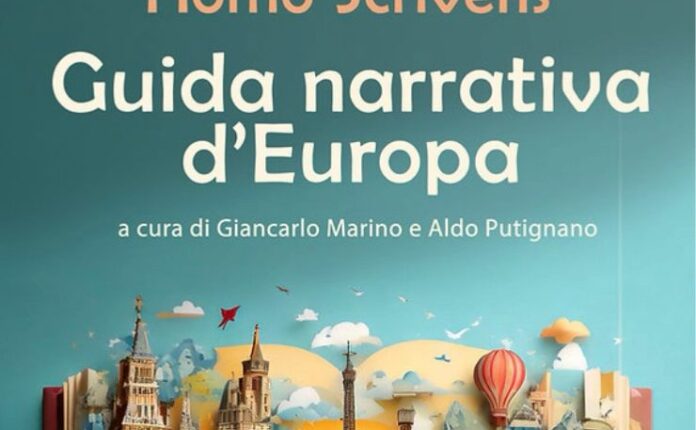Santa Muerte di Ettore Zanca è una fiaba urbana che narra il lato umano, disperato e pietoso della morte.
E se anche la morte diventasse un gioco?
“Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare e dell’oscura morte al passo andare”, cantava Angelo Branduardi nella sua “Ballo in Fa diesis minore“, prospettando l’idea di una morte antropizzata, incoronata e ornata con gioielli e monili scintillanti, che dà il via a un ballo in maschera in cui ognuno è chiamato a volteggiare con la propria croce in un’immaginaria danza giocosa e malinconica.
La morte, insieme all’amore, suo doppio e suo contraltare, è stata la donna più cantata dalla letteratura, dal cinema e dalle arti figurative, più delle donne dello Stilnovo e più delle eroine celebrate dai poeti classici.
La morte non è una donna angelicata e leggiadra, ma ha le guance livide delle donne di Baudelaire e Verlaine, che hanno perso la propria aureola nei meandri della città e delle sue pozzanghere.
La morte ha una sacralità, un odore pungente che ricorda quello dell’incenso e degli altari: la morte ha un crisma di santità.
La morte è santa.
Santa Muerte, come afferma Ettore Zanca nel suo libro edito da Ianieri Edizioni. L’eclettico scrittore palermitano che vive a Roma, dipinge la morte di santità, la rende sacra e la dissacra allo stesso tempo, in una fiaba urbana che ha il sapore delle memorie e dei giochi infantili che toccano le corde più profonde del lettore.
La morte, un malinconico gioco infantile che esplora i meandri più intimi del lettore.
“Facciamo finta che io ero…”
Il libro di Ettore Zanca si apre così, creando un varco diretto e uno squarcio abissale nella memoria, che ci spedisce velocemente in quel mondo ovattato dove non risuonava nulla se non le voci delle nostri madri, il suono di un carillon e i ricordi di corse a perdifiato e giochi colmi di fantasia.
Il “Facciamo finta che io ero” è un canale preferenziale che ci conduce negli interstizi della mente di ogni bambino, affannato a immaginare e tracciare i contorni del proprio mondo ideale. Cosa voglio essere oggi? Un cantante, un attore, un astronauta o un calciatore famoso?
“Facciamo finta che io ero” è la porta girevole tra il mondo degli adulti e quello rarefatto e segreto dei bambini. Anche i grandi sono stati bambini, e farebbero bene a non dimenticarselo mai, a non dimenticare il profumo speziato di quel mondo inesplorato che aveva i suoi codici e i suoi schemi, e che sembra quasi dissolversi nel nulla non appena chiudiamo per sempre il piccolo cancello dell’infanzia.
Ettore Zanca scopre il volto bambino della morte, la rende sacra e, come già detto, la dissacra.
Come lo fa? Rendendola un correlativo oggettivo. Santa Muerte diviene il paradigmatico ed emblematico soprannome di Leonida, killer prezzolato dalla pistola color liquirizia che vaga tra le strade della città immaginaria di Labella: “è uno di quei killer che non fanno troppe domande”, uno di quei killer muti che si nutrono solo di impulso e azione, agiscono e basta.
Leonida impugna la sua pistola che gli ricorda l’alito freddo della morte, e ripensa a tutte le armi che ha impugnato da ragazzino: Super Santos, Super Tele, armi che non sapevano di morte e che avevano l’innocenza e il candore di un tempo cristallizzato e bloccato nella memoria, come un insetto nell’ambra.
Ora non è più tempo di giocare, è tempo di indossare abiti neri, un po’ come un supereroe, e fare il proprio dovere.
Ma non prima di aver accarezzato con lo sguardo la statuetta di Santa Muerte che, oltre ad essere il suo soprannome, indica anche la madonnina messicana adorata da trafficanti e criminali. Leonida la porta sempre con sé, come a ricordarsi che, sebbene la sua vita consista nello sguazzare nello schifo e nel marciume, la morte conserva un disperato alone di dignità. E di santità.
Leonida ha perso davvero tutto. Ha perso Marta, la donna che ama, e la sua unica compagnia è la sua gatta Morgana, che compare anche nella dedica del libro, come custode dell’amore a suon di ringhi e soffi.
“Ma adesso che Marta non c’era più, era ridicolo anche solo pensarci: adesso stringeva e usava quella pistola con più rabbia e adrenalina che mai. Adesso aveva ripreso a sradicare le erbacce dal suo bel giardino di cemento e solitudine. E pagavano bene, ancora”.
Il dolore conferisce nuova linfa alle azioni di Santa Muerte, caricandolo e rendendolo attivo e performante. Ma Santa Muerte non è un killer canonico e “normale” come tutti i sicari, dietro la coltre del suo “chiamami come ti pare, basta che mi paghi“, vi è un killer sui generis.
Leonida lavora per una multinazionale, e il suo incarico è ben preciso: le sue vittime sono consenzienti, desiderano ardentemente la morte e firmano un contratto. Il libro descrive, con enfasi e in modo spietato e crudo, le personalità e i tratti di coloro che bramano la morte e che si affidano alla “santità” di Leonida, incaricato di salvarli dal baratro con un colpo della sua pistola color liquirizia.
Abbiamo Alex, medico che non è riuscito a salvare il suo miglior amico. L’amicizia tra Alex e Giacomo è descritta con termini di struggente liricità e bellezza, i due erano soliti definirsi orfani di tutto, tranne che della propria amicizia.
Alex vuole morire e tornare dal suo amico, lo desidera ardentemente:
«A chi importa cosa mi fa bene? Ai miei pazienti? A loro interessa solo che io li salvi, non amano me, amano il mio talento nel tirarli fuori dal buco del culo della morte. A una donna? Sai quante mi hanno lasciato? Sai quante mi aspettavano nude e desiderose, con culi di marmo e tette da paura? Quante ne ho dovuto rifiutare per urgenze, per sultani in fin di vita? Per magnati che avevano paura di morire peggio dei bambini? Leonida…»
«Dimmi».
«Puoi ridarmi i tempi del Mupi condiviso con Giacomo?»
«Se lo vuoi davvero, sì».
«Sono ancora nei termini? Sono garantito?»
«Ho parlato con chi di dovere, sì».
«Dammi i fogli».
Zanca ci introduce in un Purgatorio di anime dolenti, deluse e disilluse, orfane della vita e desiderose di lasciarla, crisalidi vuote di esseri umani svuotati del soffio vitale. Dopo Alex, vi è Riccardo, musicista distrutto dalla morte del padre:
« E suo padre non era vissuto. Avevano fatto in tempo ad andare a comprare il cd, il padre glielo aveva regalato abbracciandolo forte. I gesti d’affetto non gli erano affatto estranei, per cui Riccardo non si era allarmato più di tanto.
[…] Un gioco di prestigio del cazzo. Un momento sei dotato di tutti gli optional di un figlio normale e il momento dopo sei orfano».
Le descrizioni e la poetica crudezza con cui Ettore Zanca ci introduce nelle menti di questi orfani di amici, amori, padri, madri e di vita, colpisce il lettore come un calcio negli stinchi, consegnandogli un testamento che s’intreccia col sapore della pietà.
E che dire di Giulia, vittima di violenze familiari e abusi e che desidera morire per trasfigurarsi in quella principessa dei videogiochi, quella che uccide l’orco, proprio come nella Playstation?
«Io mi fidavo, mi teneva sulle ginocchia da piccolina, lo chiamavo zio. Ma lo zio non mi ha tenuto sulle ginocchia. Stavolta, per tre volte, ha fatto inginocchiare me. Sarò ancora piccola per certe cose, come dice mio padre, ma credo che anche da grande mi faranno schifo. Poi mi ha detto di non parlare, che era una cosa nostra. Per tante sere è venuto a cena da noi con sua moglie e i suoi figli piccoli. Io mi sentivo scorrere addosso la stessa sensazione appiccicosa della bava vomitata dall’orco al cavaliere per impedirgli di arrivare alla principessa».
Santa Muerte pone fine al dolore, diviene un angelo pietoso della morte, e il suo soprannome acquista un senso, come il costume di Spiderman su Peter Parker.
Sullo sfondo delle storie di umanità dolente e bramosa di morte, vi è un concerto che cambierà per sempre le carte in tavola, vi è la musica (interessantissima e straziante è “La ballata del killer”) come squillo di tromba ironico e dissacrante della morte, vi è l’amore che rimane sempre a volteggiare sullo strato delle cose, e vi è un’umanità densa che ribolle come i soffi di un geyser.
Ettore Zanca ci introduce negli interstizi di Santa Muerte, ci prende per mano e ci fa penetrare il significato di questo nome, soprannome e correlativo oggettivo: la morte è santa e blasfema, è sacra ed è profana, è amica e nemica, è madre e matrigna accidiosa.
O forse Santa Muerte getta la maschera di serial killer e si scopre materno, dotato delle prerogative dell’ultima madre, che accompagna i figli che si rivolgono a voi verso l’ultimo passo, quello del baratro, del nulla e dell’oblio, un po’ come “L’Accabadora” narrata da Michela Murgia.
Santa Muerte è l’ultimo genitore, che compie il bene per i propri figli e realizza i loro remoti ed ultimi desideri, anche se fa male, anche se brucia come sale sulle ferite.
Santa Muerte è l’ultimo padre, e la sua è l’ultima carezza prima della buonanotte.
Prima della notte eterna.