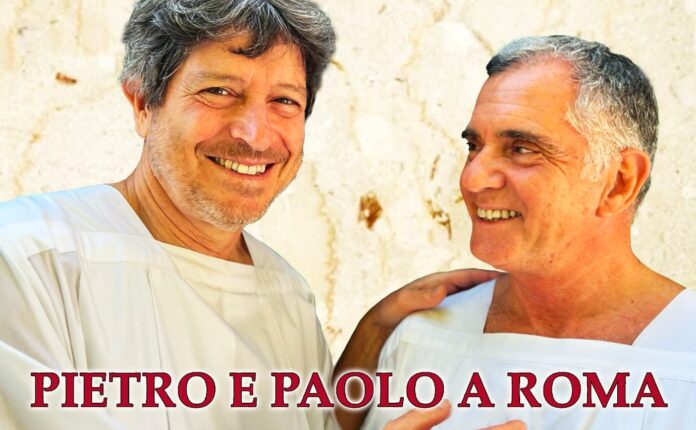“A poco più di quarantotto ore dalla chiusura di ‘Male Fuori’, evento con cui ho voluto portare all’attenzione della società civile e degli addetti ai lavori il fenomeno dell’arruolamento dei minori da parte delle mafie e far partire un grido di ribellione e chiamata alle armi, sento il dovere di ringraziare pubblicamente quanti ancora raccolgono le mie sfide e si fanno promotori di azioni di risveglio della comunità sociale”: con queste parole, il maestro del Kodokan di Napoli Giuseppe Marmo, decano del judo, della didattica dello sport e dell’educazione sportiva, commenta il successo di “Male Fuori”, convegno tenutosi nei giorni scorsi negli spazi del monumentale Real Albergo dei Poveri del capoluogo campano.
“Incontro tutti i giorni giovani e giovanissimi, ragazzi e ragazze, nelle sale del Kodokan, nel lungo corridoio che funge da ideale ‘decumano’ di collegamento tra loro – commenta Marmo – ma anche per strada, nei mezzi pubblici, ovunque ci sia vita. Non riesco a smettere di pensare a ciascuno di loro, di arrovellarmi su cosa potrei fare per rendere la loro esistenza e il nostro mondo un posto migliore. Forse perché sono reduce da un’esperienza di salvataggio, avvenuta sessant’anni fa proprio nel Real Albergo dei Poveri, mastodontico quanto fragile edificio che ha ospitato il nostro convegno”.
Le parole del maestro Marmo celano una riflessione ancor più ampia: “Ho visto molti, troppi ragazzi perdersi, abbandonati al proprio destino. Ho sperimentato che una seconda opportunità, o anche una terza o una quarta, è possibile costruirla, se solo si ha la pazienza e l’operosità per fare rete. Ed è proprio alla rete degli amici che sono intervenuti a ‘Male Fuori’ che voglio rivolgere il mio più sentito ringraziamento, anche facendomi portavoce degli attestati di stima e degli apprezzamenti che ho ricevuto”.
Tante sono state, infatti, le presenze istituzionali e le testimonianze d’autore che hanno arricchito il convegno ‘Male Fuori’, nato con il Patrocinio del Comune di Napoli. “Ringrazio l’Assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu, che ha saputo portare ai presenti la concretezza del male che investe le strade e i quartieri della nostra città e la forza di perseverare nell’ascolto e nella cura degli ultimi. – prosegue Marmo – Un grazie speciale va al professor Giuseppe Tribuzio che, attraverso la metafora dell’ingranaggio che si inceppa ha reso palpabile quello stato di smarrimento che va sotto il nome di ‘disagio’, facendoci presagire che è su quel meccanismo intralciato che bisogna intervenire. Grazie al grande campione olimpico Pino Maddaloni che ha commosso l’uditorio, condividendo la sua storia di sacrificio, impegno e perseveranza che ne ha fatto un campione sul tatami e nella vita. Grazie, ancora, a Mario Del Verme che ha raccontato la bellezza di Scholas Occurentes, progetto nato ad opera di Papa Francesco e oggi storia di rivincita della cultura dell’incontro su quella dell’egoismo e dell’isolamento cui in tanti vorrebbero ci rassegnassimo. Ringrazio Marco Rossi-Doria, lucido interprete del fenomeno raccontato nel nostro convegno, che ha condiviso la necessità di fare cose semplici e concrete per essere d’aiuto alle fasce fragili delle nuove generazioni, assicurando loro punti di riferimento saldi, ascolto e cura, cognitiva ed emotiva. Grazie a Maria De Luzenberger (Procuratrice del Tribunale dei Minori di Napoli) e Roberto Di Bella (Presidente del Tribunale dei Minori di Catania), entrambi in prima linea nel lavoro di tutela dei minori e di costruzione certosina di destini alternativi a quelli tatuati nel loro DNA. Grazie, inoltre, al giornalista e scrittore a Michelangelo Iossa che ha saputo intrecciare le storie dei protagonisti del convegno, esaltandone la potenza”.
Il convegno “Male Fuori” ha offerto una grande occasione di riflessione, ma soprattutto la conferma di un insegnamento del Maestro Jigoro Kano: “La via inizia con il dare e prosegue nello stare insieme per crescere e progredire”.