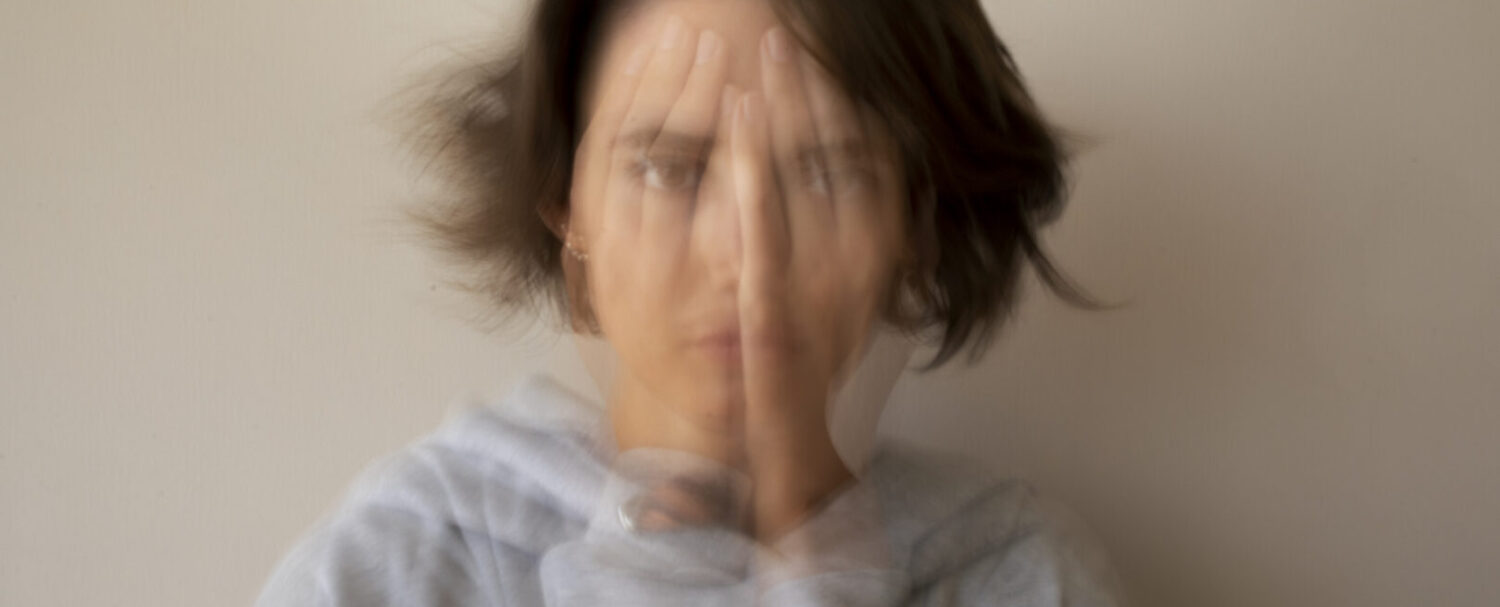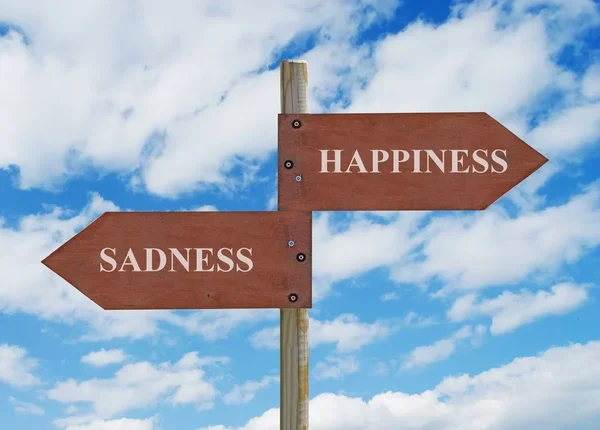I sintomi del DOC (disturbo ossessivo-compulsivo) sono forse una delle manifestazioni meno comprese e più complesse nel campo della salute mentale. Essi, spesso, anche a causa della psicologia pop sui social che banalizza la salute mentale, vengono erroneamente interpretati come semplici abitudini o manie. In realtà parliamo di ossessioni e compulsioni che caratterizzano il disturbo e che possono interferire con la vita quotidiana e in generale con la serenità della persona che ne soffre. Riconoscere e comprendere i sintomi del DOC è fondamentale per assumerne consapevolezza e avvicinarsi a un percorso di cura, magari prendendo spunto anche da alcuni film sulla salute mentale che ne trattano le tematiche.
Per approfondire meglio la questione abbiamo intervistato la psicologa aversana Chiara Rotunno cercando di fare chiarezza su cosa significhi davvero vivere con questo disturbo, come riconoscere i sintomi del DOC e cosa fare. È importante ricordare che per informazioni ufficiali e scientifiche è sempre utile consultare fonti autorevoli come il sito dell’Istituto superiore di sanità.
Indice dei contenuti
Cos’è il disturbo ossessivo compulsivo
Il Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) è un disturbo caratterizzato prevalentemente dalla presenza di ossessioni e compulsioni. Le prime si caratterizzano come pensieri o immagini intrusive e incontrollabili, mentre le seconde sono azioni ripetitive. Un modo per distinguere tra semplici abitudini e il DOC è fare riferimento all’impatto che queste hanno sulla vita della persona e alla sofferenza che ne deriva: un’abitudine può essere preferita, ma non è obbligata. Nel DOC, invece, la persona sente di “non poter fare a meno” del rituale, tutto diventa “eccessivo”. Inoltre, le compulsioni sorgono per controllare e/o contrastare qualcosa di spiacevole e, quindi, spesso hanno l’obiettivo di gestire un disagio emotivo.
Quali sono le tipologie principali di DOC?
| Tipologia | Caratteristiche principali |
|---|---|
| DOC da contaminazione | Timore di germi e lavaggi ripetuti |
| DOC da controllo | Verifiche costanti su gas, luci o serrature |
| DOC da ordine | Intolleranza verso disordine e asimmetria |
| DOC superstizioso | Rituali per prevenire danni a sé o altri |
Principali sintomi e segnali
Il DOC è caratterizzato principalmente da pensieri ricorrenti e indesiderati e da comportamenti ripetitivi messi in atto per ridurre l’ansia. Spesso emerge una sensazione di incertezza o insicurezza (ad esempio: “Le porte sono tutte chiuse?”, “Ho le mani pulite?”). Può essere associato a una paura eccessiva della contaminazione, al bisogno di ordine o simmetria, oppure al dubbio costante, anche su questioni banali, e al bisogno di rassicurazione. Il tutto si accompagna a un forte senso di urgenza.
Differenza tra DOC e altri disturbi d’ansia
Nonostante il DOC sia stato collocato per anni all’interno dei disturbi d’ansia, nel DSM-5 (il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) viene descritto come un disturbo con manifestazioni specifiche e a sé stanti. In altri disturbi d’ansia, come il Disturbo d’ansia generalizzata o gli attacchi di panico, l’ansia è più diffusa o comunque legata a situazioni specifiche e non viene regolata attraverso rituali. Sebbene il DOC condivida alcuni aspetti con l’ansia, quest’ultima è una risposta naturale a situazioni percepite come minacciose, mentre l’ossessione consiste in pensieri ricorrenti, intrusivi e indesiderati che provocano ansia.
 Persona che lava le mani. (Wikipedia Ph. Lars Klintwall Malmqvist)
Persona che lava le mani. (Wikipedia Ph. Lars Klintwall Malmqvist)
Cause e componente genetica
L’eziologia del DOC è complessa e multifattoriale. È impossibile attribuirlo a un’unica causa. Numerosi studi hanno approfondito gli aspetti genetici e neurobiologici: la familiarità è significativa, quindi avere un parente con DOC aumenta la probabilità di svilupparlo. Va considerata anche la componente relativa ai neurotrasmettitori, in particolare la serotonina, ma anche la relazione tra cibo e salute mentale. Sul piano psicologico, invece, stili di pensiero rigidi, senso di responsabilità eccessiva e paura dell’errore sono caratteristiche spesso presenti nel DOC. Infine, eventi stressanti o traumatici possono causare l’eziologia del disturbo o peggiorarlo. Ovviamente, non esiste una causa unica, ma un’interazione tra predisposizione e storia personale.
Diagnosi e impatto sulla vita quotidiana
Per arrivare alla diagnosi, il percorso inizia con un colloquio clinico molto approfondito. Si valuta attentamente la presenza di ossessioni e compulsioni, ma si analizzano anche la sofferenza che la persona prova e l’impatto che questi sintomi hanno sulla sua vita di tutti i giorni. A supporto, vengono utilizzati anche test psicodiagnostici o scale specifiche. È fondamentale fare una distinzione chiara: tutti possiamo avere dei semplici pensieri intrusivi (sono del tutto comuni), ma quelli tipici del disturbo ossessivo compulsivo (DOC) sono diversi. Risultano infatti persistenti, rigidi e impossibili da controllare.
Quando non viene trattato, il DOC può diventare estremamente invalidante. Porta via tantissimo tempo (i rituali possono durare anche ore), riduce la libertà personale (può costringere a evitare certi luoghi, persone o situazioni sociali) e interferisce pesantemente con studio, generando a volte un forte stress da esami, lavoro e relazioni. Spesso, chi ne soffre è consapevole che le sue paure sono irrazionali, eppure non riesce a controllarle. Questa lotta interna può generare un forte senso di colpa e frustrazione. Il DOC però è trattabile! La terapia psicologica, eventualmente integrata con l’ecoterapia, e quando serve quella farmacologica, mostrano infatti ottimi risultati.
Fonte immagine: Freepik