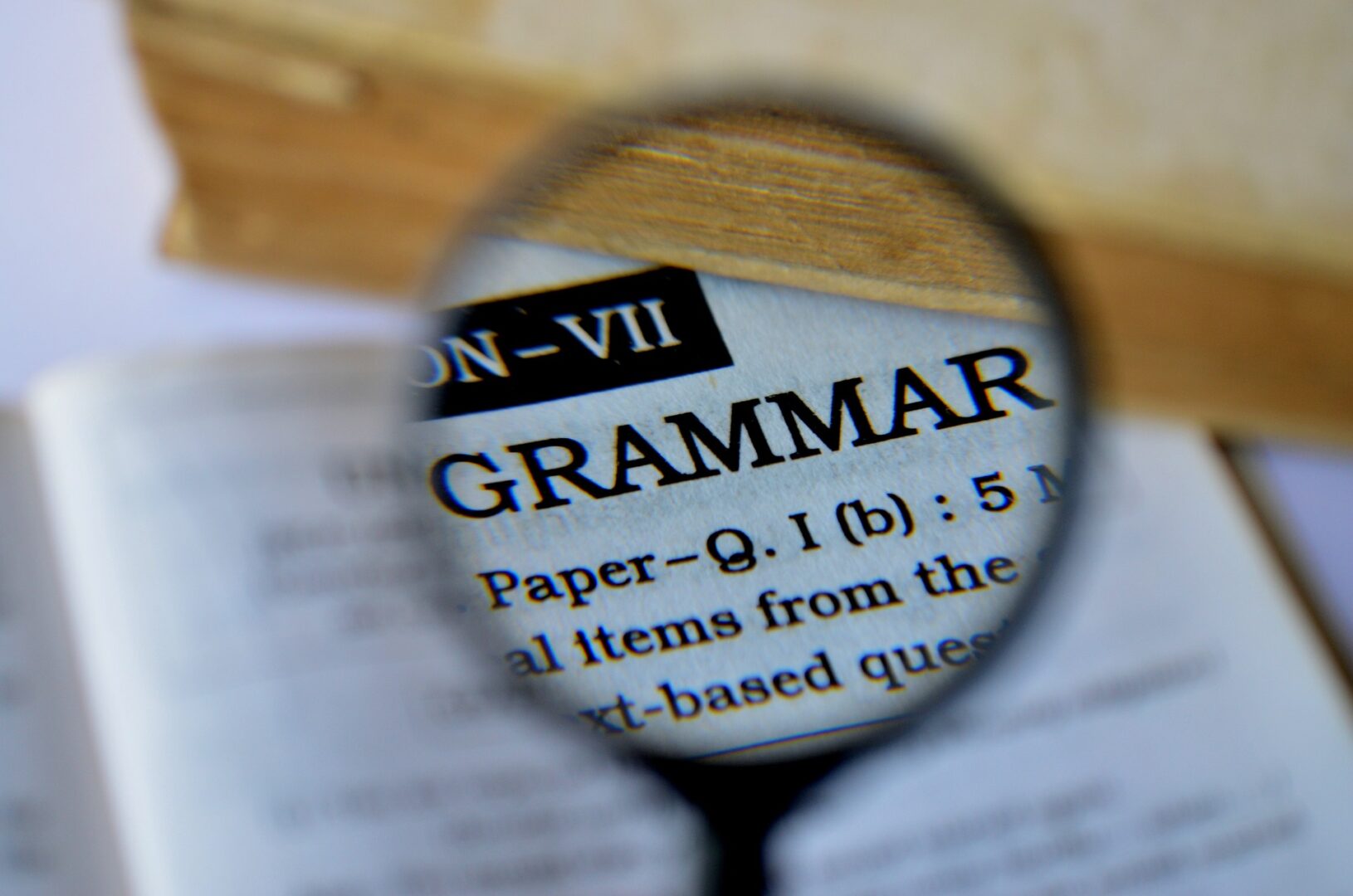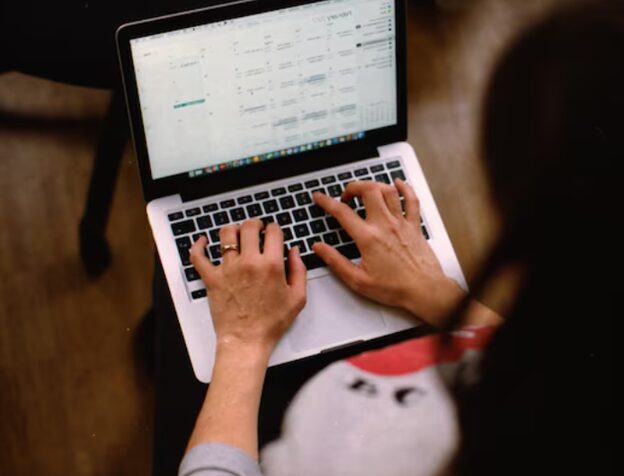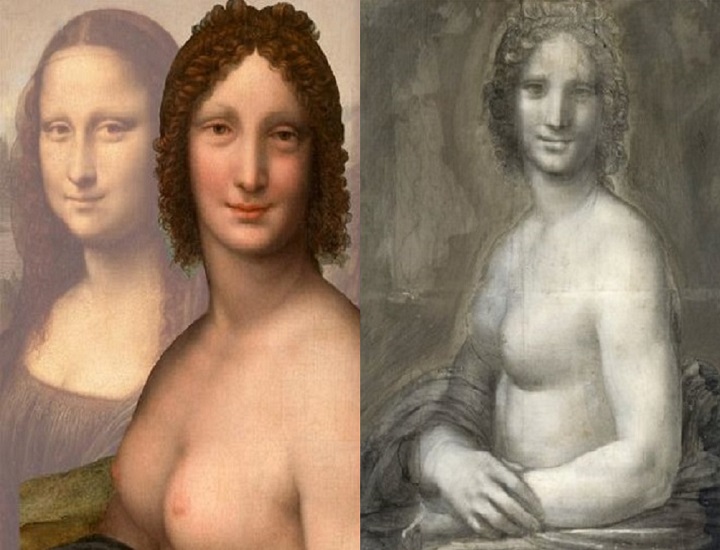Nel corso della storia, confini e nazioni sono cambiati più e più volte, ma alcuni Stati hanno avuto una vita così breve da sembrare oggi delle leggende. Si tratta infatti di Stati esistiti solo pochi giorni, di quei governi lampo nati spesso da rivoluzioni improvvisate, ma anche da accordi falliti o errori diplomatici. Alcuni furono dei semplici atti simbolici, altri invece veri e propri tentativi di autogoverno schiacciati da forze più grandi. In ogni caso, il loro fascino sta proprio nella loro brevità. Sono stati dei lampi di sovranità, tutti destinati a spegnersi rapidamente, ma capaci comunque di lasciare un segno nella Storia e di finire oggi in quest’articolo. Di seguito, alcune delle vicende più curiose, dallo Stato più longevo a quello più breve.
Vediamo quindi assieme quali sono gli Stati che sono esistiti solo pochi giorni nella Storia.
Repubblica di Carnaro (1919) – 15 giorni di “rivoluzione creativa”
L’impresa di Fiume è uno degli episodi più eccentrici e teatrali della storia italiana del primo dopoguerra, radicata piuttosto fermamente nel nostro immaginario, e non può non comparire in questa speciale “classifica” degli Stati più brevi mai esistiti. Nel settembre 1919, il poeta-soldato Gabriele D’Annunzio, già eroe della Grande Guerra e figura di culto per molti reduci, guidò un manipolo di legionari e volontari nell’occupazione della città adriatica di Fiume (oggi Rijeka, in Croazia). L’azione non fu ovviamente autorizzata dal governo italiano ed era motivata dal rifiuto di accettare la decisione della Conferenza di Parigi, che non aveva assegnato Fiume all’Italia nonostante le rivendicazioni nazionaliste.
Per oltre un anno, D’Annunzio governò la città come un capo carismatico, trasformandola in un laboratorio politico e culturale senza precedenti, attirando artisti, anarchici, futuristi, ex militari e avventurieri da tutta Europa. Un esperimento totalmente rivoluzionario per l’epoca. L’apice di questa sperimentazione fu la proclamazione, l’8 settembre 1920, della Reggenza Italiana del Carnaro e della sua costituzione, la Carta del Carnaro (redatta da Alceste De Ambris con ritocchi poetici dello stesso D’Annunzio). La costituzione prevedeva un sistema corporativista, anticipando alcune idee poi riprese dal fascismo, ma inseriva anche elementi utopistici e libertari. L’articolo più famoso sanciva che la musica fosse un «principio fondamentale dello Stato», equiparandola a istituzioni come l’esercito o la scuola. Il testo mescolava estetica futurista, retorica dannunziana e proposte politiche radicali, creando un vero e proprio unicum nella storia delle costituzioni.

La “rivoluzione creativa” però durò pochissimo. Già a settembre, infatti, le pressioni internazionali e la contrarietà del governo italiano isolarono D’Annunzio. Il 26 settembre 1920 la Reggenza fu sostituita da un consiglio cittadino e, a dicembre, l’intervento militare italiano pose fine all’esperienza fiumana (provocando il cosidetto Natale di sangue) . La Repubblica di Carnaro sopravvisse ufficialmente appena quindici giorni, ma il mito dell’impresa di Fiume continuò a influenzare movimenti politici, artisti e intellettuali ben oltre i confini italiani, diventando un esempio di come un’utopia possa vivere intensamente anche se destinata a spegnersi in fretta.
Repubblica di Connacht (1798) – 12 giorni di libertà
La Repubblica di Connacht è un’altro di questi Stati, come visto con quella di Carnaro, esistiti per molto poco tempo. Nacque nel pieno della ribellione irlandese del 1798 e fu il frutto dell’incontro tra il malcontento diffuso nella popolazione irlandese e l’ambizione geopolitica della Francia rivoluzionaria, desiderosa di indebolire l’Inghilterra colpendo il suo “cortile di casa”. A fine agosto di quell’anno, una spedizione navale francese guidata dal generale Jean Joseph Amable Humbert approdò a Killala, nella contea di Mayo, con poco più di mille soldati. L’idea era quella di fomentare una sollevazione popolare che grazie all’appoggio militare potesse liberare l’Irlanda dal dominio britannico.
Pochi giorni dopo lo sbarco, il 31 agosto 1798, Humbert proclamò la nascita della Repubblica di Connacht, designando come presidente John Moore (un esponente locale della nobiltà cattolica simpatizzante per i francesi). La capitale venne fissata simbolicamente a Castlebar, una città appena strappata agli Inglesi in una vittoriosa battaglia nota come Castlebar Races, così chiamata per la sorprendente rapidità con cui le truppe britanniche si ritirarono.

L’assenza di rinforzi dalla Francia e la superiorità numerica dell’esercito britannico resero impossibile consolidare il controllo sul territorio. Fu per questo motivo che il nuovo governo durò appena dodici giorni. Le truppe di Humbert furono sconfitte definitivamente a Ballinamuck l’8 settembre 1798. I soldati francesi furono fatti prigionieri e rimpatriati, mentre i ribelli irlandesi catturati subirono dure repressioni. John Moore venne arrestato e morì poco dopo in prigionia. La Repubblica di Connacht, nonostante la brevità dell’esperimento, è rimasta nella memoria storica come un simbolo di resistenza, oltre che come il primo tentativo, seppur fallito, di instaurare un governo repubblicano in Irlanda sul modello francese.
Repubblica di Crimea (1918) – 10 giorni tra due imperi
All’inizio del 1918, la penisola di Crimea era un territorio conteso e instabile, sospeso tra le convulsioni della Prima Guerra Mondiale e le ripercussioni della Rivoluzione russa. La regione era infatti passata sotto il controllo della Repubblica Popolare di Crimea dopo il crollo dell’impero zarista, ma viveva una situazione interna tutt’altro che calma. Si trattava infatti di uno stato multietnico che cercava di bilanciare le aspirazioni nazionali tartare con la complessa e ricca composizione etnica locale. Ma le rapide avanzate dell’Armata Rossa bolscevica, unite all’occupazione tedesca in Ucraina, stavano per cambiare ancora una volta il destino della penisola che ancora oggi è oggetto di desiderio internazionale.
Nel mese di aprile, infatti, con le truppe tedesche alle porte e i bolscevichi indeboliti dalle lotte interne, un gruppo di leader locali proclamò una Repubblica di Crimea indipendente, nella speranza di ottenere un riconoscimento internazionale e di garantirsi protezione dalle mire dei due grandi contendenti. L’atto aveva anche un significato simbolico, ovvero quello di affermare l’autonomia di una regione da secoli al crocevia di imperi, in cui convivevano russi, tatari, ucraini, greci e armeni.

Il nuovo governo durò appena dieci giorni. Il 30 aprile 1918, l’esercito tedesco entrò a Sebastopoli e impose un’amministrazione militare e pose quindi fine all’esperimento indipendentista prima ancora che potesse consolidarsi. La mossa faceva parte della strategia di Berlino di assicurarsi basi navali sul Mar Nero e vie di rifornimento attraverso il Caucaso. La Repubblica di Crimea rimase così un episodio quasi dimenticato, schiacciato tra due potenze che si contendevano la penisola. Nella memoria storica locale, quei dieci giorni rappresentano l’ennesimo tentativo (fallito) di dare voce a una terra da sempre divisa tra le ambizioni di altri.
Repubblica di Perloja (1918) – il microstato lituano di 6 giorni
Quando terminò la Prima Guerra Mondiale, l’Europa centro-orientale era un mosaico di territori in transizione. I confini delle nazioni vennero ridisegnati dal momento che erano crollati numerosi imperi. Diversi poteri locali cercavano di colmare il vuoto lasciato dagli eserciti in ritirata. Il quadro che ne usciva fuori, quindi, era tutt’altro che stabile. In Lituania, ad esempio, il collasso dell’Impero tedesco aprì una breve finestra di autonomia per alcune comunità rurali, decise a prendere in mano il proprio destino.
Il villaggio di Perloja, situato lungo il fiume Merkys, era uno di questi luoghi. La sua comunità contava circa 2.000 abitanti ed era da tempo organizzata attorno a una forte identità locale e a un senso di autogestione profondo. Approfittando del ritiro delle truppe tedesche e dell’assenza di un’autorità centrale stabile, nell’ottobre del 1918 gli abitanti proclamarono la nascita della Repubblica di Perloja.

Per sei giorni il piccolo villaggio funzionò come un vero e proprio microstato. Venne istituito un governo locale guidato dal capo della comunità Jonas Česnulevičius. In aggiunta, venne anche istituito un tribunale per dirimere dispute e messa in piedi una forza di polizia armata per mantenere l’ordine. Addirittura la neonata Repubblica si concesse il lusso di produrre documenti ufficiali con il sigillo della Repubblica. Le decisioni erano prese collettivamente, in un clima di entusiasmo alimentato dall’idea di poter controllare il proprio futuro, lontano finalmente dalle ingerenze di potenze straniere. Tuttavia, l’esperimento ebbe vita brevissima. Già dopo sei giorni, l’autorità del nascente Stato lituano indipendente raggiunse Perloja, integrando il villaggio nel nuovo assetto nazionale. Nonostante la sua durata lampo, l’episodio è rimasto vivo nella memoria locale: ancora oggi, a Perloja, una stele ricorda quei giorni di effimera sovranità.
Repubblica di Benin (1967): uno degli Stati più effimeri esistiti – 24 ore
Il 1967 fu un anno cruciale per la Nigeria. Dopo l’indipendenza del 1960, infatti, scoppiarono tensioni etniche, politiche ed economiche che divisero il paese in fazioni contrapposte. A luglio, lo Stato del Biafra (a maggioranza Igbo) dichiarò la propria secessione, dando inizio a una guerra civile destinata a durare tre anni. Nel pieno del conflitto, il 9 agosto 1967, le forze biafrane lanciarono un’offensiva verso Ovest, penetrando nella regione del Midwest, un’area considerata strategica sia per le sue infrastrutture che per la vicinanza alla capitale Lagos. Qui, le milizie proclamarono la nascita della Repubblica di Benin, destinata ad essere ricordata appunto come uno tra gli Stati più effimeri mai esistiti. Il loro obiettivo era quello di consolidare il loro controllo sulla zona e di ottenere legittimità internazionale.

La scelta del nome richiamava l’antico Regno del Benin, fiorito tra il XIII e il XIX secolo. Questo apparato statale è passato alla storia per la sua ricca tradizione artistica e per la capitale, Benin City, che divenne famosa anche per essere un centro nevralgico di vendita degli schiavi. L’uso di questa denominazione aveva una duplice funzione: innanzitutto, evocare orgoglio storico nella popolazione locale; poi anche quello di presentare il nuovo Stato come entità distinta dal Biafra, per facilitare eventuali riconoscimenti diplomatici.
Ma il progetto era destinato a spegnersi quasi subito. Già il 10 agosto 1967, infatti, appena ventiquattro ore dopo la proclamazione, l’esercito federale nigeriano lanciò una controffensiva fulminea, riconquistando il Midwest e ponendo fine all’esistenza della Repubblica. I leader locali fuggirono o vennero catturati e il sogno di uno Stato indipendente si dissolse in meno di un giorno. Oggi, la Repubblica di Benin è ricordato come uno degli Stati più brevi esistiti nella storia contemporanea: un episodio nato e morto nel giro di un’unica giornata, simbolo della fragilità politica in tempi di guerra civile. Tuttavia, tra i Paesi esistiti per così poco tempo, occupa sicuramente il primo posto in quest’articolo, essendo quello “morto” più giovane.
È importante precisare che questa Repubblica di Benin del 1967 non ha alcun legame con l’attuale Stato del Benin in Africa occidentale, ex Dahomey, che assunse quel nome soltanto nel 1975. Le due entità condividono solo il riferimento al Regno del Benin, ma sono completamente distinte.
Repubblica di Saugeais (1947): uno scherzo diventato tradizione
Non tutti gli Stati esistiti per pochissimo tempo, però, sono nati da guerre o rivoluzioni. Alcuni, come la Repubblica di Saugeais, sono esistiti grazie ad un semplice scambio di battute e hanno finito per trasformarsi in una tradizione locale. Siamo nel 1947, nella regione francese della Franche-Comté, ai confini con la Svizzera. Il prefetto del dipartimento del Doubs era in visita ufficiale al piccolo comune di Montbenoît, un villaggio pittoresco circondato dalle montagne del Giura. Durante la cerimonia di benvenuto, il funzionario si rivolse scherzosamente al sindaco, Georges Pourchet, chiedendogli: «E lei, signor sindaco, è anche il Presidente della Repubblica?».

Pourchet colse, senza un attimo di esitazione, l’occasione per alimentare la gag. Davanti agli abitanti e ai giornalisti presenti, infatti, decise di proclamare la nascita della Repubblica di Saugeais, estesa a undici comuni della zona, con lui stesso come Presidente autoproclamato. L’atto non aveva alcun valore legale e durò solo poche ore: passò giusto il tempo necessario a ridere e brindare, ma l’idea di vivere in un nuovo Stato rimase impressa nella memoria collettiva. La “Repubblica” è diventata negli anni successivi una vera e propria tradizione folkloristica, assolutamente unica nel suo genere. Il titolo di Presidente è stato poi trasmesso prima alla moglie di Pourchet e in seguito a un successore scelto dalla comunità e sono stati addirittura creati passaporti simbolici, francobolli commemorativi e persino un inno ufficiale, che suona tutt’oggi durante le celebrazioni locali. La Repubblica di Saugeais è diventata così una curiosità in grado di attirare numerosi turisti: i visitatori possono infatti ottenere un visto simbolico (come succede anche in altre parti nel mondo, ad esempio nella Repubblica di Uzupis in Lituania) e scoprire una storia che dimostra come anche uno scherzo possa diventare parte integrante dell’identità di un luogo.
Fonte immagini: Wikimedia Commons (in copertina: gli abitanti di Fiume celebrano D’annunzio, 1920 – Foto di Edward Alexander Pwell, immagine di dominio pubblico).