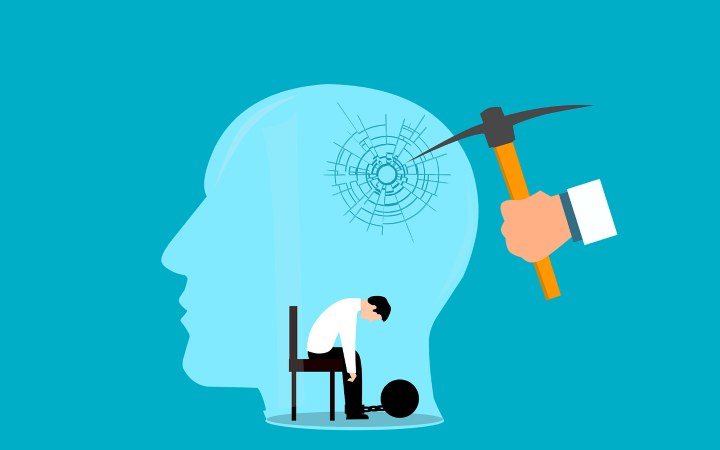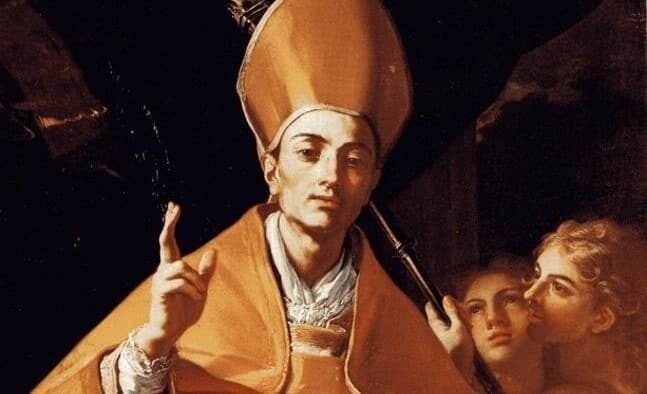Il disturbo da stress post-traumatico (DPTS o PTSD in inglese) è una condizione di sofferenza psicologica che può manifestarsi in seguito all’esposizione a un evento traumatico o estremamente pericoloso. Mentre in molte persone le intense reazioni di ansia e paura si risolvono naturalmente con la fine del pericolo, in altre persistono per mesi o anni, compromettendo significativamente la qualità della vita. Chi vive in questa condizione di iperattivazione e disagio continuo a distanza di tempo dall’evento, può soffrire di disturbo da stress post-traumatico.
Indice dei contenuti
Sintomi principali del disturbo da stress post-traumatico
I sintomi del DPTS possono manifestarsi a qualsiasi età e intaccare la sfera personale, lavorativa e sociale. Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), i sintomi si raggruppano in quattro categorie principali. Dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) indicano che la prevalenza del disturbo nella popolazione generale varia dall’1% al 3%. Le donne e le persone in condizioni di vulnerabilità socioeconomica risultano essere più colpite.
| Cluster di sintomi | Manifestazioni tipiche |
|---|---|
| Sintomi intrusivi (rivivere l’evento) | Flashback, incubi e ricordi involontari che fanno rivivere l’evento traumatico con la stessa intensità emotiva. |
| Evitamento | Evitare pensieri, luoghi, persone o attività che possono innescare il ricordo dell’evento traumatico. |
| Alterazioni negative di pensieri ed emozioni | Disinteresse per attività prima piacevoli, distacco emotivo, sentimenti persistenti di colpa, vergogna o paura. |
| Iperattivazione (arousal) | Stato di allerta costante, irritabilità, difficoltà a dormire e a concentrarsi, reazioni di spavento esagerate. |
Eventi che possono causare il DPTS
Non è l’evento in sé a determinare l’insorgenza del disturbo, ma una combinazione di fattori che includono la gravità del trauma, la resilienza individuale, le esperienze passate e il supporto sociale. Alcuni eventi sono comunemente associati allo sviluppo del DPTS:
- Esperienze di combattimento: i soldati sono una delle categorie più studiate. La diagnosi è stata formalizzata proprio dopo la guerra in Vietnam. Si stima che circa il 30% dei veterani manifesti sintomi riconducibili al DPTS.
- Disastri naturali o incidenti: eventi come terremoti, inondazioni, incendi o gravi incidenti stradali e aerei.
- Vittimizzazione e aggressioni: aver subito abusi, violenze fisiche, rapine o essere stati esposti ad atti di terrorismo. L’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 è un esempio di evento che ha causato DPTS su larga scala.
- Violenza sessuale: subire un rapporto sessuale non consenziente è un trauma con un’altissima probabilità di generare un DPTS.
- Tortura: una pratica finalizzata a punire o estorcere informazioni, comune ad esempio sui prigionieri di guerra.
Come si effettua la diagnosi del DPTS
La diagnosi del disturbo da stress post-traumatico deve essere effettuata da un professionista della salute mentale, come uno psicologo o uno psichiatra. Per poter diagnosticare il DPTS, i sintomi descritti sopra devono essere presenti per almeno un mese e causare un disagio clinicamente significativo o una compromissione del funzionamento sociale o lavorativo. Lo specialista valuterà la storia del paziente, la natura dell’evento traumatico e la persistenza dei sintomi attraverso colloqui clinici e, talvolta, test psicodiagnostici standardizzati.
Quali sono le cure e i trattamenti disponibili
Il disturbo da stress post-traumatico è una condizione trattabile. Esistono diversi approcci terapeutici che hanno dimostrato una solida efficacia. Secondo il Manuale MSD per professionisti, i trattamenti più efficaci includono:
- Psicoterapia focalizzata sul trauma: è l’approccio di prima scelta. Tecniche come la Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT) aiutano a modificare i pensieri e i comportamenti disfunzionali legati al trauma.
- EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): una terapia specifica che utilizza la stimolazione bilaterale (come i movimenti oculari) per aiutare il cervello a elaborare e desensibilizzare i ricordi traumatici.
- Terapia farmacologica: in alcuni casi, lo psichiatra può prescrivere farmaci, in particolare gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), per gestire i sintomi ansiosi e depressivi associati al disturbo, sempre in combinazione con un percorso di psicoterapia.
Fonte immagine: Pixabay
Articolo aggiornato il: 01/10/2025