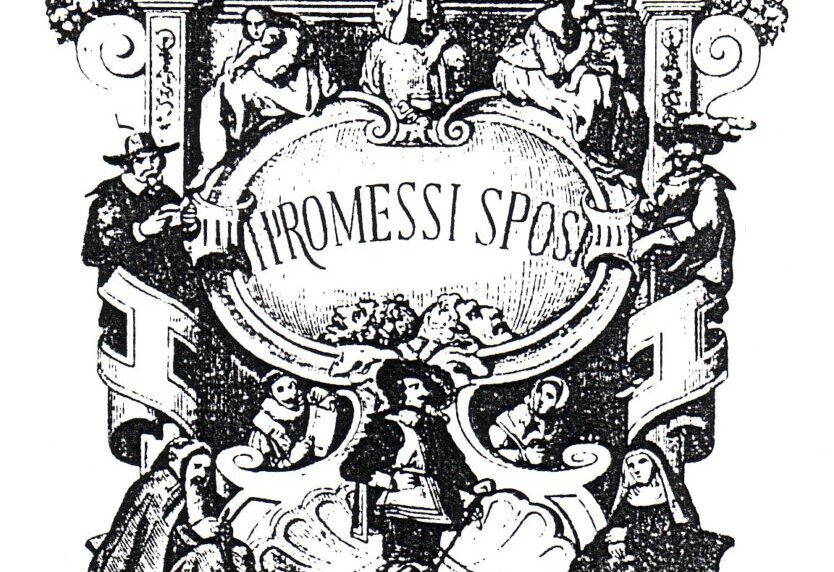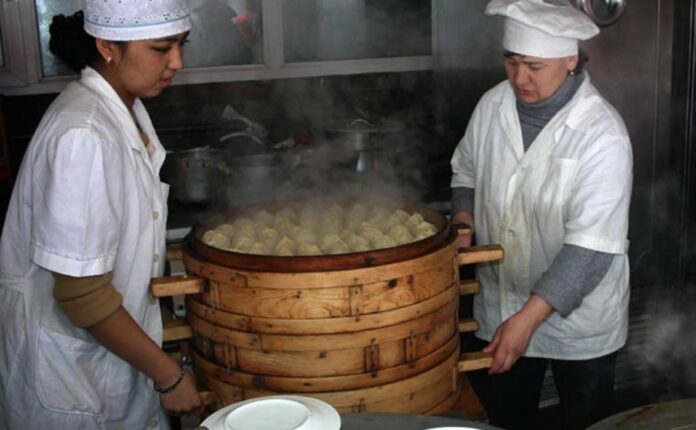Dalla Terza pagina alle piattaforme social, ripercorriamo l’evoluzione del giornalismo culturale e il contributo che può fornire alla messa a punto di un’informazione vincente.
Inizialmente relegato in uno spazio tutto suo, come fosse un’appendice del giornalismo stricto sensu, il giornalismo culturale ha vissuto una lenta ma costante emancipazione. Da un’iniziale Terza pagina elitaria e quasi del tutto letteraria inaugurata dal Giornale d’Italia, la cultura è fuggita dalla torre d’avorio in cui si era arroccata per intersecarsi con altri ambiti, dapprima soprattutto l’attualità e la politica e negli ultimi anni anche le discipline scientifiche.
Dalla Terza pagina al giornalismo culturale
Sul modello de Il Giorno – che per primo comparve senza Terza pagina nel 1956 – e di Piero Ottone che pubblicò Pasolini sulla prima pagina de La Repubblica, si è incrinata man mano l’immagine archetipica del giornalista culturale che presta la sua prestigiosa penna soltanto ad uno spazio spiccatamente elitario.
Ad accorciare la distanza tra i giornalisti che storcevano il naso di fronte alla limitata letterarietà della Terza pagina e gli scrittori che in quella pagina indugiavano in una ridondante laudatio temporis acti è stato soprattutto Paolo Mieli. Dopo la sua esperienza presso La Stampa, l’Espresso e La Repubblica, Mieli ha portato il “mielismo” al Corriere nel 1992, inaugurando una linea editoriale che Concita de Gregorio ha definito «un giornalismo tutto influenzato dai temi e dai ritmi della tv, fatto di dibattiti» (la Repubblica, 2 marzo 1993); un giornalismo che, anche nel settore culturale, si ribellava al precedente ingessato ipse dixit e sostituiva ai commenti in pompa magna un amalgama tra materie alte e tematiche popolari, nuovo e anticonvenzionale.
Cultura orizzontale e crisi dei mediatori
Sul principio del nuovo Millennio, le pagine culturali hanno iniziato a riflettere le istanze di una società in rapido mutamento, con orizzonti più ampi e confini sempre più sottili; il giornalismo culturale ha risentito del nuovo modello di cultura che Giovanni Solimine e Giorgio Zanchini hanno definito “orizzontale”, evoluzione di quel “mielismo” di cui sopra. Orizzontale perché trasversale, multiforme, multimediale e soprattutto priva della sua consueta struttura verticale. In un contesto sociale simile, il giornalista, che nei secoli scorsi era mediatore tra produttori e fruitori e guida dei lettori a un processo di costruzione di una conoscenza critica, si è ritrovato assoggettato alla brutale legge della domanda e dell’offerta.
Ogni prodotto dell’informazione, da una ventina d’anni a questa parte, è importante solo se incontra l’approvazione (e quindi l’interazione) del popolo dei social. In sintesi, sono gli algoritmi a definire i nostri gusti, nonché i nostri consumi. In questa “crisi dei mediatori”, parafrasando Nicola Lagioia, è proprio l’informazione culturale, più degli altri settori, a scivolare pericolosamente verso l’appiattimento, un rischio che può diventare opportunità a seconda di come viene giocata la partita.
Croce e delizia del pubblico di consumatori, infatti, se da un lato questo andamento rischia di assecondare un’umanità più scomposta, debole e liquida, dall’altro consente a tutti l’interazione diretta e facile con un mondo prima riservato agli addetti ai lavori. Lontano ormai dai tempi della Terza pagina, il giornalismo culturale si è tolto la giacca, trasformandosi in una creatura fluida, ibrida, modellata da un maggior numero di personaggi e voci.
L’informazione culturale come faro del nuovo giornalismo
C’è da dire, d’altro canto, che una trasformazione simile si addice al giornalismo culturale più che alla cronaca e al giornalismo politico; e proprio perché maggiormente vulnerabile e debole, si sta scoprendo più camaleontico e pronto a indicare la direzione di un cambiamento costruttivo del modo di fare informazione.
Un buon giornalista culturale, ad esempio, riconosce le notizie oggettivamente rilevanti, ma allo stesso tempo riesce a far valere quel senso critico parzialmente soggettivo che gli consente di cogliere fenomeni nuovi. È ovvio che un meccanismo simile risulterebbe di difficile implementazione in altri settori per i quali non si può operare una cernita arbitraria; tuttavia, senza inficiare il fine ultimo dell’informazione, si può evitare la ripetitività cercando quantomeno di filtrare le notizie attraverso prospettive alternative.
Il livellamento si evita anche mediante uno sforzo di complessità, che strutturalmente caratterizza il giornalismo culturale. Complessità non vuol dire rinunciare alle tempistiche richieste dalla rivoluzione antropologica in atto, ma recuperare la profondità e il discernimento, anche sfruttando i vantaggi della crossmedialità per vivacizzare l’informazione tradizionale.
I rischi e le sfide
Rinunciare a una selezione critica e concedere spazio solo alle notizie di maggior seguito sotto la spinta della contingenza rischia di proiettare il giornale in un’ottica di allettamento commerciale; il giornalismo così si limiterebbe a fidelizzare fan, piuttosto che a educare pensatori critici. E proprio quest’ultima dovrebbe essere la sua missione.
Per quanto innovato nei mezzi e nei linguaggi, non è escluso, dunque, che la trasformazione del giornalismo culturale possa fornire all’informazione, nelle sue svariate forme, strategie utili per sopravvivere alla burrascosa crisi degli ultimi anni.
Il ruolo del giornalista può ripartire da questa esigenza di adeguarsi ai nuovi mezzi e alla differente domanda degli utenti senza arrendersi alla “massificazione” e, nel tentativo di sopravvivere, può riscoprirsi nella sua forma più autentica.
Immagine in evidenza: Pixabay