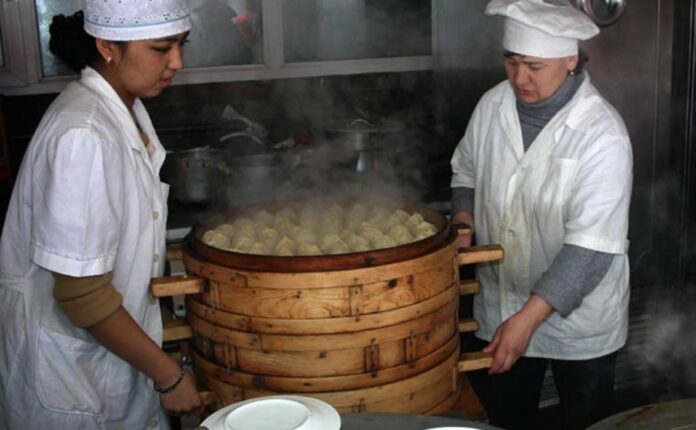L’alleanza tra papato e Franchi: la nascita dello Stato della Chiesa
La caduta di Ravenna nel 751 d.C. per mano dei Longobardi fu un evento di straordinaria importanza, che ridisegnò gli equilibri politici dell’intera Italia. Papa Stefano II, diventato pontefice nel 752, dovette prendere atto di un fatto incontrovertibile: l’Impero d’Oriente, suo protettore formale, non era più in grado di difendere Roma. Per la Chiesa era giunto il momento di cercare un nuovo e più potente alleato. La scelta ricadde sul Regno dei Franchi, una potenza emergente destinata a cambiare la storia d’Europa.
La caduta di Ravenna: il papato cerca un nuovo protettore
Il pontefice si dedicò a rinsaldare i rapporti con la monarchia franca. A differenza dei Longobardi, la cui conversione al cattolicesimo era recente e non sempre stabile, i Franchi erano cattolici da secoli e la Chiesa era una presenza capillare nel loro regno. Questa affinità religiosa, unita alla loro potenza militare, li rendeva il partner ideale. Il papato aveva bisogno di un protettore forte, ma anche sufficientemente lontano da non rappresentare una minaccia diretta, un ruolo che i Bizantini non potevano più svolgere e che i Longobardi, per la loro vicinanza, non avrebbero mai potuto incarnare.
L’ascesa dei Carolingi: da Carlo Martello a Pipino il Breve
All’interno del regno franco, il potere reale era da tempo scivolato dalle mani dei re della dinastia merovingia a quelle dei loro potentissimi funzionari, i maggiordomi di palazzo. La famiglia dei Pipinidi aveva progressivamente unificato il regno, prima con Pipino di Heristal e poi con suo figlio, il celebre Carlo Martello. Il prestigio di quest’ultimo era cresciuto enormemente dopo la battaglia di Poitiers (732), in cui fermò un’incursione araba. Alla sua morte, il potere passò a suo figlio, Pipino III, detto il Breve. Nel 751, Pipino decise di porre fine all’ambiguità: depose l’ultimo sovrano merovingio e, con un vero e proprio colpo di stato, assunse il titolo di re dei Franchi, sostenuto probabilmente dai vescovi del regno.
L’alleanza tra Stefano II e Pipino: la consacrazione e la promessa
In questo scenario si inserì papa Stefano II. Nel 754, in un gesto senza precedenti, il pontefice si recò di persona da Roma in Francia e, durante una solenne cerimonia, consacrò personalmente Pipino il Breve re dei Franchi, ungendolo con l’olio santo. Questo atto aveva un’importanza immensa: conferiva una legittimità divina a una dinastia di usurpatori. In cambio, Pipino si impegnò a intervenire militarmente in Italia contro i Longobardi. L’alleanza tra papato e Franchi era sigillata. Pipino mantenne la parola: scese in Italia, sconfisse i Longobardi e liberò Ravenna e i territori circostanti.
La nascita dello Stato della Chiesa: le donazioni di Pipino
Il re franco, però, non restituì i territori conquistati all’Impero bizantino, a cui formalmente appartenevano. Li donò invece al papa. Queste terre, unite alla precedente “Donazione di Sutri” di Liutprando, andarono a costituire il primo nucleo del Patrimonio di San Pietro, ovvero lo Stato della Chiesa, un’entità politica destinata a sopravvivere fino al 1870. L’intervento franco aveva arginato i Longobardi e garantito al papato un nuovo, potente protettore, sancendo un rapporto privilegiato tra Roma e il nascente Impero carolingio.
La Donazione di Costantino: il falso storico che legittimò il potere papale
Ma con quale autorità il papa incoronava i re e governava territori che, in linea di principio, appartenevano ancora a Costantinopoli? Per dare un fondamento giuridico a questo crescente potere temporale, fu creato all’interno della cancelleria papale uno dei falsi più efficaci della storia: la cosiddetta Donazione di Costantino. Questo documento apocrifo, attribuito all’imperatore Costantino, affermava che egli, prima di trasferire la capitale a Costantinopoli, aveva donato al vescovo di Roma e ai suoi successori l’autorità politica sull’intera parte occidentale dell’impero. Il falso proclamava anche la superiorità del papa su tutti gli altri patriarchi, incluso quello di Costantinopoli. Per secoli, questo documento fu usato dai papi per rivendicare il primato del potere spirituale su quello temporale di re e imperatori. Ci vollero settecento anni per smascherare l’inganno: solo nel 1440, l’umanista Lorenzo Valla ne dimostrò filologicamente la falsità.
L’eredità dell’alleanza: un nuovo ordine per l’Europa
In conclusione, l’alleanza tra papato e Franchi non fu un semplice accordo politico, ma un evento che ridisegnò la mappa dell’Europa. Segnò la fine dell’influenza bizantina in Occidente, accelerò il declino del regno longobardo e, soprattutto, gettò le basi per due delle istituzioni più importanti del Medioevo: lo Stato della Chiesa, che avrebbe condizionato per secoli la storia d’Italia, e il Sacro Romano Impero, che sarebbe nato con l’incoronazione del figlio di Pipino, Carlo Magno, nell’anno 800. Il vescovo di Roma era diventato a tutti gli effetti un sovrano, e il suo legame con la più grande potenza militare del tempo avrebbe definito il corso della civiltà occidentale.
Prof. Giovanni Pellegrino
Bibliografia
- Longobardi, Franchi e Chiesa romana, Tamassia Nino e altri, Edizione Reprint 2016
- Italia longobarda, il regno, i Franchi, il papato, Gasparri Stefano, Editore Laterza 2014
- Le origini dello stato della chiesa, Crivellucci Amedeo, Editore Utet 01.01.1987
- Lo stato della chiesa. Gli antichi stati italiani: Tabacchi Stefano, Editore il Mulino 2023
Immagine Di Frankish_Empire_481_to_814-en.svg: Sémhurderivative work: Dom De Felice (talk) – Frankish_Empire_481_to_814-en.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8453388