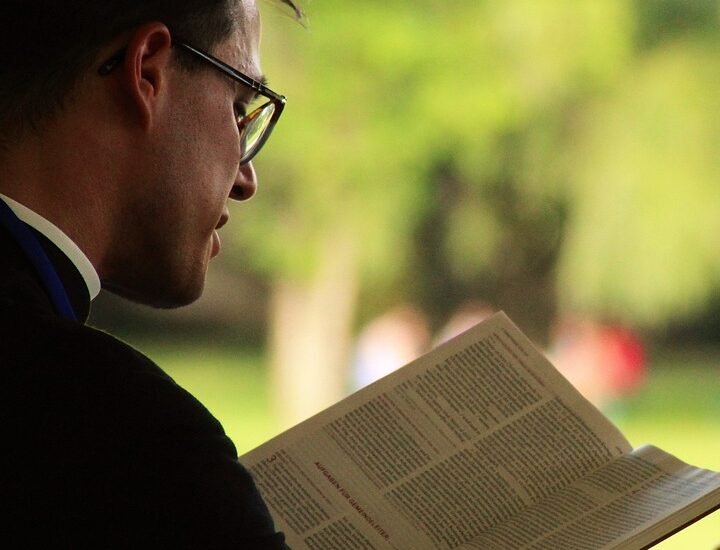Tra racconti epici, voci silenziate e scritture del confine, riscopriamo oggi la linfa viva della letteratura dell’Asia centrale, un mosaico narrativo tutto da esplorare.
Indice dei contenuti
Autori chiave della letteratura centroasiatica contemporanea
| Autore | Paese d’origine | Opera significativa |
|---|---|---|
| Hamid Ismailov | Uzbekistan | The Dead Lake |
| Aigerim Tazhi | Kazakistan | Paper-Thin Skin (poesia) |
| Alisher Khasanov | Kirghizistan | Er Töstük e altre leggende kirghise |
Letteratura dell’Asia centrale: la parola che resiste dopo il silenzio
Per numerosi decenni, la letteratura dell’Asia centrale ha vissuto ai margini del panorama mondiale, incastonata tra lingua russa, censura sovietica e narrazioni imposte con violenza. Da quelle crepe linguistiche, culturali e storiche, però, oggi sgorgano parole nuove. Romanzi, poesie, racconti e graphic novel nascono tra le steppe kazake, i deserti uzbeki, le valli del Kirghizistan, dando sfogo ad una pluralità di voci differenti, ad un’identità sfaccettata e ancora in trasformazione.
Questo risveglio non è solo letterario: è politico, ma soprattutto esistenziale e profondamente simbolico. Dopo secoli di narrazioni dall’esterno, infatti, i popoli centroasiatici tornano a raccontarsi con i propri strumenti, mescolando memoria condivisa e modernità. La letteratura è oggi lo spazio dove fiaba e trauma si intrecciano. Le nuove voci emergenti sono quelle di figure che nei secoli scorsi non hanno mai avuto la possibilità di esprimersi: donne, giovani, scrittori della diaspora, editori digitali.
Letteratura dell’Asia centrale: le origini
La letteratura dell’Asia centrale ha sempre avuto una tradizione orale e simbolica. L’epopea di Manas, in Kirghizistan, è ancora oggi tramandata a voce da cantori professionisti (manaschi), mentre le fiabe kazake con cavalli alati e madri sacre tornano a vivere nelle pagine di romanzi contemporanei.
Molti autori reinterpretano questi elementi folklorici in chiave moderna, contaminandoli con il realismo magico, la fantascienza, il trauma post-sovietico. Il risultato è un complesso e affascinante ibrido narrativo, in cui il mito non è solo nostalgia, ma anche e soprattutto materiale vivo.

Lingua, censura e diaspora
Scrivere in Asia centrale significa spesso scegliere una lingua (russo, kazako, uzbeko, inglese) e affrontare moltissimi vincoli editoriali o politici. Molti autori continuano a usare il russo per raggiungere un pubblico più ampio e per esigenze editoriali, soprattutto in Paesi dove le infrastrutture culturali in lingua nazionale sono ancora fragili. Il russo resta una lingua ponte tra Paesi post-sovietici e, per alcuni scrittori, rappresenta anche la lingua dell’infanzia, della formazione, dell’ambiguità. Tuttavia, questa scelta non è mai neutra: scrivere in russo può essere visto come forma di privilegio culturale, ma anche come atto di resistenza o, al contrario, di alienazione.
Parallelamente, cresce un movimento di scrittura in lingua locale. In Turkmenistan la censura è ancora fortissima; molti scrittori si rifugiano in una narrazione simbolica, ambigua, dove la metafora è più sicura della denuncia. In Uzbekistan, Kazakistan e Kirghizistan, invece, le pubblicazioni indipendenti crescono ma non senza rischi.
Molti scrittori vivono all’estero o pubblicano attraverso piccole case editrici occidentali come Tilted Axis Press o Deep Vellum. Anche il digitale offre nuovi spazi: Instagram, Substack, riviste come The Steppe o Naryq (Kazakistan) raccolgono racconti brevi e poesia in forma visiva, aggirando le complicazioni burocratiche.

Tre nomi di scrittori centroasiatici contemporanei: chi leggere?
Tra i nomi degli autori più interessanti della scena contemporanea troviamo Hamid Ismailov, scrittore uzbeko in esilio, autore del romanzo The Dead Lake, bandito nel suo Paese ma pubblicato da Penguin. Il romanzo, scritto in russo e pubblicato nel 2014, è ambientato nel Kazakistan sovietico, vicino al poligono nucleare di Semipalatinsk, usato per test atomici dall’URSS tra il 1949 e il 1989.
Il narratore, un uomo che viaggia in treno nella steppa, incontra un ragazzino che si esibisce danzando. Si chiama Yerzhan. Poco a poco, Yerzhan racconta la sua storia: vive in una zona remota, vicino al lago “morto” (The Dead Lake), contaminato dalle esplosioni nucleari. Un giorno, da bambino, Yerzhan si immerge nelle acque del lago. Da allora, non crescerà mai più. L’opera affronta le conseguenze invisibili del nucleare sulla popolazione, soprattutto sui bambini nati nelle aree contaminate, ai quali l’infanzia viene rubata. Le comunità kazake vivono accanto ai test atomici come se fosse normale, in un clima di silenzio e rimozione dettato dal colonialismo sovietico. La narrazione è semplice, quasi favolistica, con paragrafi brevi e ritmo rapido: ricorda il realismo magico, ma in chiave centroasiatica. Di seguito un video di approfondimento della rivista Internazionale sul poligono nucleare di Semipalatinsk e l’eredità nucleare dell’Unione Sovietica in Kazakistan, tema che ha ispirato il romanzo di Ismailov:
https://www.youtube.com/watch?v=L93F0QVWz5I
Accanto ad Ismailov, brillano nuove voci come la poetessa kazaka Aigerim Tazhi, i cui versi minimalisti e cosmici sono stati tradotti da Words Without Borders. Nata ad Aktobe nel 1981, Tazhi è considerata una delle espressioni più originali della nuova poesia centroasiatica. Nella raccolta Paper-Thin Skin (Zephyr Press, 2019), Tazhi unisce il minimalismo del verso breve russo con le immagini naturali della steppa: luce, vento, alberi, corpi e silenzio. La steppa kazaka è interpretata non solo fisicamente, ma anche come spazio psichico. Esempio tradotto: “L’albero si china per bere dalla pozzanghera. Le radici si contraggono”. Corpo, natura e movimento si fondono. Tahzi rappresenta una voce femminile rara e autorevole in un contesto dominato da uomini o da voci diasporiche. I suoi versi dimostrano che la letteratura dell’Asia centrale possa essere contemporanea, senza rinunciare alle sue radici: la sua poesia è esistenziale, globale, e soprattutto non politica o storica. Di seguito un breve video in cui la poetessa kazaka legge le sue poesie al Poetry International Festival di Rotterdam 2022:
Ci sono poi anche autori locali che rielaborano la mitologia tradizionale con forme narrative ibride, come le fiabe illustrate di Alisher Khasanov in Kirghizistan. Nato a Biškek negli anni ’90, Khasanov ha pubblicato diverse raccolte illustrate in kirghiso per bambini e ragazzi, tra cui “Er Töstük e altre leggende kirghise”, dove miti popolari come il viaggio nell’oltretomba, l’eroe a cavallo o lo spirito della montagna vengono ripensati attraverso uno stile visivo che mescole tradizione ornamentale, linee essenziali e narrazione grafica. Le sue opere non sono semplici trasposizioni: sono veri e propri ibridi letterari, opere d’arte che fondono fiaba, graphic novel, poesia visiva e design etnico.
E il Tagikistan?
Il Tagikistan è l’unico paese dell’Asia Centrale a maggioranza iranofona: la lingua ufficiale è il tagico, una variante del persiano. Questo lo isola culturalmente rispetto agli altri paesi turcofoni (Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan), che condividono un certo grado di comprensione reciproca e circolazione di testi. La produzione letteraria in tagico è poco tradotta in inglese, russo o francese rispetto a quella di Kazakistan e Uzbekistan. Manca una vera e propria rete internazionale di diffusione. Le poche traduzioni esistenti (spesso accademiche) non sono sostenute da case editrici indipendenti come avviene per Hamid Ismailov o Aigerim Tazhi. Il regime tagiko mantiene ancora forme rigide di controllo culturale. La narrativa contemporanea è spesso limitata alla sfera educativa, oppure legata a modelli “positivi” di Stato e moralità. Questo ha disincentivato una produzione letteraria autenticamente sperimentale o critica, e ha spinto molti scrittori nella diaspora o nel silenzio.
Scoprire un mondo fuori dalla zona di comfort occidentale
La rinascita della letteratura centroasiatica rappresenta un’esigenza profonda: quella di affermare il diritto a narrare la propria complessità in tutte le sue sfaccettature. Sono testi che parlano di colonialismo, desiderio, frontiere, memoria.
Leggere questi autori significa uscire dalla zona di comfort occidentale e ascoltare voci nuove, spesso spezzate. Non si tratta solo di conoscere “l’altro”, ma di lasciarsi toccare da mondi che, seppur lontani, parlano delle stesse paure, slanci e domande che abitiamo anche noi.
Fonte immagini: Wikipedia
Articolo aggiornato il: 06 Gennaio 2026