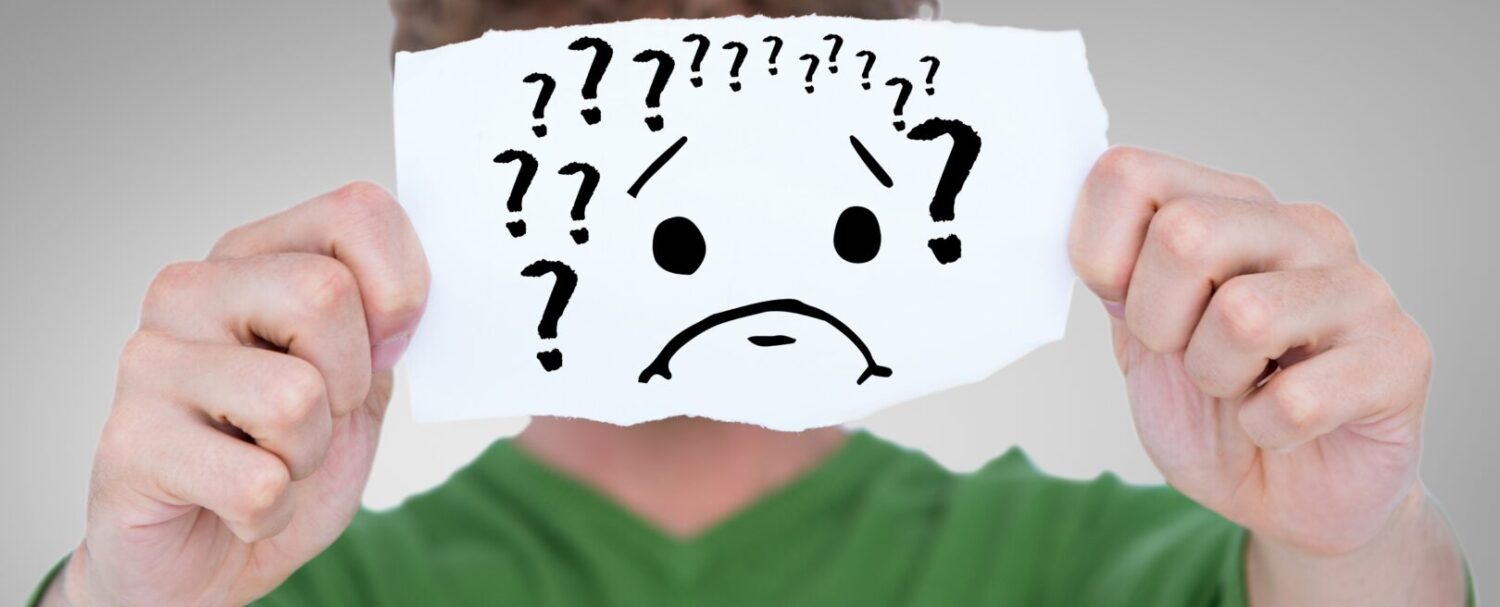Nonostante possa sembrare tratta da un film distopico, la sindrome di Capgras è del tutto reale. Fu descritta per la prima volta nel 1923 da due importanti psichiatri francesi: Joseph Capgras e Jean Reboul-Lachaux. Nota anche come “delirio dei sosia”, è un raro disturbo psichiatrico che comporta la convinzione, da parte del paziente, che una o più persone del proprio nucleo familiare (ad esempio figli, coniuge o genitori) siano state sostituite da impostori ostili, identici nell’aspetto ma privi della vera identità.
Caratteristiche cliniche della sindrome di Capgras
I pazienti riconoscono perfettamente i tratti fisici della persona, ma negano la sua identità autentica attribuendole differenze impercettibili agli altri, ad esempio: «ha uno sguardo diverso» o «la sua voce è più fredda». Oltre ai familiari, il delirio può coinvolgere sé stessi (“sosia di sé”), animali, oggetti o luoghi. Spesso, chi è affetto dalla sindrome di Capgras presenta anche altri sintomi. Questi possono essere:
– Allucinazioni sia uditive che visive;
– Sintomi dissociativi come la depersonalizzazione (quando il paziente percepisce sé stesso come se fosse un osservatore esterno della propria vita, dei propri pensieri o del proprio corpo) e derealizzazione (ovvero la percezione del mondo esterno come irreale, distorto o estraneo, pur mantenendo la consapevolezza che questa sensazione non corrisponda alla realtà);
– Disturbi legati alla memoria come paramnesie e déjà-vu;
– Episodi (non rari) di aggressività nei confronti di chi o ciò che il paziente vede come “doppio” — in questi casi si hanno rischi concreti di violenza da non sottovalutare.
Le cause della sindrome e i disturbi associati
Questa sindrome non è riconosciuta come diagnosi a sé stante, ma in associazione ad altri disturbi, mentre i fattori che la causano possono essere di tre tipi: organici, psicodinamici e da deficit neurocognitivi. Per quanto riguarda la prima tipologia, s’intende la presenza di anomalie nei lobi frontali e temporali che coinvolgono l’emisfero destro. Queste zone cerebrali sono quelle che si occupano del riconoscimento dei volti, dell’elaborazione emotiva e dell’integrazione tra memoria e percezione. Quindi, se queste aree (che fanno parte di un sistema detto “limbico”) non sono ben connesse con la corteccia visiva, potrebbero spiegare la perdita del senso di familiarità verso i volti conosciuti. Queste anomalie possono essere rilevate solo tramite mezzi come TAC, SPECT e risonanza magnetica (che producono “neuroimmagini”).
Nel caso dei fattori psicodinamici, la teoria più accreditata ipotizza che il paziente divida l’immagine del familiare in una parte “buona”, corrispondente al reale, e una “cattiva”, che corrisponde all’impostore. Questa teoria porta a pensare che il paziente, che vede un’ambivalenza delle due parti nella persona, attivi inconsciamente dei meccanismi di difesa: ad esempio la divisione, la proiezione e la negazione, che gli consentono di essere aggressivo senza avere sensi di colpa.
Altri pazienti, invece, possono essere affetti da deficit neurocognitivi come prosopagnosia (ovvero l’incapacità di riconoscere i volti) e disturbi visuo-spaziali, che a differenza della sindrome di Capgras alterano la percezione ma non l’attribuzione emotiva dell’identità.
La sindrome, presente nel 2-3% dei casi psichiatrici acuti, è più comune nelle donne ma più violenta negli uomini. Il rischio di aggressioni è elevato, con episodi gravi documentati. La pericolosità aumenta in caso di convivenza con la persona non identificata, deliri cronici, convinzioni persecutorie e diagnosi psichiatriche gravi.
Trattamenti e conclusioni
I trattamenti che vengono forniti non curano definitivamente la sindrome, tuttavia possono alleviare i sintomi. I medici hanno approcci differenti: c’è chi prevede l’uso di farmaci antipsicotici e stabilizzatori dell’umore, anche se comunque il delirio del sosia spesso persiste; altri tendono a trattare principalmente le condizioni associate (come l’epilessia); infine, un altro tipo di approccio è quello della psicoterapia, anche se resta complesso in quanto il paziente non è del tutto consapevole della malattia.
Possiamo concludere che la sindrome di Capgras resta un fenomeno affascinante e inquietante al tempo stesso, portandoci a riflettere su come anche ciò che ci sembra estremamente lontano rispetto a noi, in realtà, faccia parte della natura umana. In quanto tale, bisogna conoscere e approfondire anche i fenomeni e disturbi meno diffusi, per dare l’opportunità anche a chi ne soffre di vivere una vita dignitosa.
Fonti bibliografiche:
– Bianchi, A., Fornari, M. C. D., Nastro, P. F., Rusconi, A., Carlone, C., & Biondi, M. (2012) – Capgras syndrome: historical, psychopathological, psycho-organic and psycho-functional aspects.
– Giornale Italiano Di Psicopatologia, 18, 156–163.
– Silva, J. A., Leong, G. B., Weinstock, R., & Boyer, C. L. (1989) – Capgras syndrome and dangerousness – PubMed, 17(1), 5–14.
Fonte immagine di copertina: Freepik (foto di creativeart)