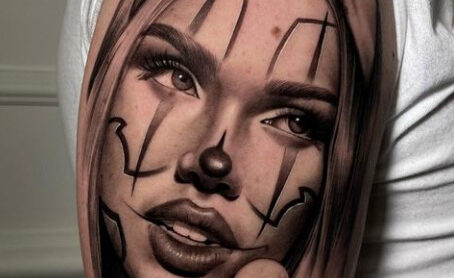I Longobardi, un popolo germanico originario della Scandinavia, invasero l’Italia nel 568 d.C., ponendo fine all’unità politica della penisola, che durava dai tempi di Roma, e dando inizio a un periodo di profonde trasformazioni. La loro dominazione, durata oltre due secoli, ha lasciato un’impronta profonda sulla storia, la società, la cultura e la lingua italiana. Vediamo insieme la storia dei Longobardi in Italia, dalla loro conquista all’eredità che ancora oggi possiamo ammirare.
Indice dei contenuti
- I Longobardi in sintesi: date e re principali
- L’invasione longobarda e la fine dell’unità d’Italia (568 d.C.)
- La società longobarda: fare, duchi e re
- L’evoluzione del regno longobardo: da Rotari a Liutprando
- La conversione al cattolicesimo e l’integrazione
- La caduta del regno longobardo (774 d.C.)
- L’eredità dei Longobardi in Italia
- Domande frequenti (FAQ)
I Longobardi in sintesi: date e re principali
Per una visione d’insieme, ecco una tabella con i momenti e le figure più importanti del dominio longobardo.
| Periodo / Data | Evento o Figura Chiave |
|---|---|
| 568 d.C. | Invasione dell’Italia guidata da Re Alboino. |
| 636-652 d.C. | Regno di Rotari, promulgazione dell’Editto di Rotari (643). |
| Fine VII sec. | Regina Teodolinda promuove la conversione al Cattolicesimo. |
| 712-744 d.C. | Regno di Liutprando, massima espansione e consolidamento. |
| 774 d.C. | Carlo Magno sconfigge Re Desiderio. Fine del Regno Longobardo. |
L’invasione longobarda e la fine dell’unità d’Italia (568 d.C.)
Le cause dell’invasione longobarda sono diverse: la pressione di altre popolazioni come gli Avari, la ricerca di nuove terre e la debolezza dell’Impero Bizantino, che controllava un’Italia devastata dalla guerra greco-gotica. Guidati da re Alboino, i Longobardi valicarono le Alpi nel 568 d.C., conquistando rapidamente gran parte del Nord e del Centro. L’invasione segnò la rottura definitiva dell’unità politica della penisola, che si ritrovò divisa in due: la Langobardia (le terre longobarde) e la Romania (le terre rimaste ai bizantini, come Ravenna, Roma, Napoli e le isole). A differenza degli Ostrogoti, i Longobardi inizialmente non cercarono l’integrazione, imponendo un dominio duro basato sull’esproprio delle terre.
La società longobarda: fare, duchi e re
La società longobarda era organizzata per scopi militari e basata su legami familiari.
- Le fare: erano i clan familiari, gruppi di guerrieri legati da vincoli di parentela. Costituivano le unità fondamentali dell’esercito e dell’insediamento territoriale.
- I duchi: erano i capi militari e politici delle fare. Dopo la conquista, i duchi divennero governatori dei territori, esercitando un potere molto forte e spesso autonomo, dando vita a ducati importanti come Spoleto e Benevento.
- Il re: inizialmente eletto solo in caso di guerra, la sua figura divenne stabile con l’insediamento in Italia, con capitale a Pavia. Il suo potere, però, rimase a lungo limitato dalla grande autonomia dei duchi.
L’evoluzione del regno longobardo: da Rotari a Liutprando
Con il tempo, la monarchia longobarda si consolidò, tentando di imporre un’autorità centrale sui duchi.
L’Editto di Rotari (643): le prime leggi scritte
Uno dei re più importanti fu Rotari (636-652), che non solo conquistò la Liguria, ma nel 643 promulgò l’Editto di Rotari. Fu la prima raccolta scritta delle leggi longobarde, fino ad allora tramandate oralmente. Scritto in un latino approssimativo, l’editto è una fonte preziosa sulla loro società. Uno dei suoi principi più importanti fu la sostituzione della faida (la vendetta privata) con il guidrigildo, un risarcimento in denaro che il colpevole doveva pagare alla famiglia della vittima, il cui valore variava in base allo status sociale dell’offeso.
Liutprando: l’apogeo del regno longobardo
Il regno raggiunse il suo massimo splendore con Liutprando (712-744). Considerato il più grande re longobardo, rafforzò il potere centrale, emanò nuove leggi a integrazione dell’editto e tentò di unificare l’intera penisola sotto il suo dominio. Approfittando della debolezza bizantina, conquistò molte città, arrivando fino alle porte di Roma. Famosa è la “Donazione di Sutri” (728), con cui Liutprando, cattolico, donò il borgo di Sutri non all’imperatore bizantino ma “agli apostoli Pietro e Paolo”, di fatto riconoscendo il potere temporale del Papa e ponendo le basi per il futuro Stato della Chiesa.
La conversione al cattolicesimo e l’integrazione
Inizialmente i Longobardi erano pagani o cristiani ariani, una dottrina considerata eretica dalla Chiesa di Roma. La conversione al cattolicesimo fu un processo lento, favorito dalla regina Teodolinda, moglie dei re Autari e Agilulfo. Donna di grande intelligenza politica, promosse la costruzione di chiese e monasteri e mantenne un dialogo costante con Papa Gregorio Magno. La conversione favorì una progressiva fusione tra la minoranza longobarda e la maggioranza della popolazione italica, creando una nuova società italo-longobarda.
I monasteri, come quello di Bobbio fondato da San Colombano, divennero centri fondamentali per la conservazione del sapere antico, grazie al lavoro dei monaci amanuensi.
La caduta del regno longobardo (774 d.C.)
L’alleanza tra il Papato e i re dei Franchi segnò la fine dei Longobardi. I Papi, sentendosi minacciati dall’espansionismo longobardo, chiesero aiuto ai Franchi. Nel 773, re Desiderio, l’ultimo sovrano longobardo, invase i territori papali. Papa Adriano I invocò l’intervento di Carlo Magno, re dei Franchi. Carlo Magno scese in Italia, sconfisse i Longobardi e assediò Pavia, che cadde nel 774. Desiderio fu deposto e Carlo Magno si proclamò “Re dei Franchi e dei Longobardi”, annettendo il regno al suo impero. Solo il Ducato di Benevento sopravvisse autonomamente ancora per secoli.
L’eredità dei Longobardi in Italia
Nonostante la fine del loro regno, i Longobardi hanno lasciato un’eredità duratura e visibile ancora oggi.
I siti UNESCO: i luoghi del potere longobardo
Nel 2011, l’UNESCO ha riconosciuto il sito seriale “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774 d.C.)”, che comprende sette gruppi di monumenti che testimoniano l’importanza artistica e culturale longobarda.
- Cividale del Friuli (Udine): con il famoso Tempietto Longobardo e il Complesso Episcopale.
- Brescia: con il complesso monastico di San Salvatore-Santa Giulia.
- Castelseprio (Varese): con il castrum e la chiesa di Santa Maria foris portas.
- Spoleto (Perugia): con la Basilica di San Salvatore.
- Campello sul Clitunno (Perugia): con il Tempietto del Clitunno.
- Benevento: con il Complesso di Santa Sofia.
- Monte Sant’Angelo (Foggia): con il Santuario di San Michele Arcangelo, meta di pellegrinaggio fondamentale per i Longobardi.
Puoi trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’associazione Italia Langobardorum.
Paolo Diacono e la Historia Langobardorum
Paolo Diacono, monaco e storico longobardo dell’VIII secolo, è l’autore della Historia Langobardorum (Storia dei Longobardi). Scritta dopo la caduta del regno, è la principale fonte scritta per conoscere la storia e la cultura di questo popolo.
L’eredità nella lingua italiana
Molte parole dell’italiano moderno derivano dalla lingua longobarda. Eccone alcune:
- Da guerra: zuffa, faida, scherano, elmo.
- Da vita quotidiana: panca, zanna, stalla, balcone, ricco, schiena.
- Da anatomia: guancia, milza.
Domande frequenti (FAQ)
Chi erano i Longobardi in breve?
Erano un popolo germanico che invase l’Italia nel 568 d.C., stabilendo un regno che durò fino al 774. Hanno segnato la fine dell’unità politica della penisola e hanno lasciato una forte eredità culturale.
Quali erano i re longobardi più importanti?
Tra i più importanti ci sono Alboino, che guidò l’invasione; Rotari, che emanò il primo codice di leggi scritte; e Liutprando, che portò il regno al suo massimo splendore.
Perché finì il regno dei Longobardi?
A causa del conflitto con il Papato, che per difendersi chiamò in aiuto i Franchi. Carlo Magno sconfisse l’ultimo re, Desiderio, nel 774, annettendo il regno longobardo.
Cosa rimane dei Longobardi oggi in Italia?
Rimangono importanti testimonianze architettoniche e artistiche, molte delle quali sono patrimonio UNESCO. Inoltre, hanno lasciato un’eredità nella lingua italiana e in molti toponimi (nomi di luoghi), specialmente nel Nord Italia (es. Lombardia).
Fonte immagine: Wikipedia