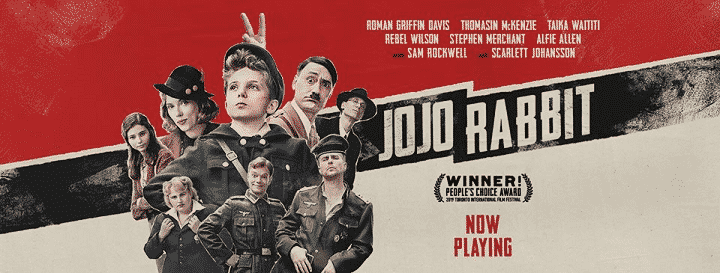Sabato 28 gennaio arriva al Modernissimo Il primo giorno della mia vita. Il regista Paolo Genovese e gli attori Toni Servillo e Sara Serraiocco sono ospiti in sala per salutare il pubblico.
Il piccolo ma resistente cinema del centro storico riempie ancora una volta la sala, con un film che dimostra di essere in tutti sensi una forma di sopravvivenza: della potenza creatrice e visionaria della pellicola, di quei superstiti che ancora si lasciano attraversare dalle cose e che, dunque, soffrono e, attraverso la sofferenza, trovano una ragione di vita.
Paolo Genovese è emozionato di presentare il suo film qui, a Napoli, nella stessa città che, anni addietro, ha ospitato la prima del suo lungometraggio d’esordio: Incantesimo napoletano (2002, scritto e diretto con Luca Miniero).
Così, con Il primo giorno della mia vita, lo scrittore-regista ripropone un incantesimo, scevro di ogni trucco, lontano dal misticismo e dalla magia, e crea un’atmosfera di sogno così concreta e tangibile da somigliare alla vita reale.
Si rivolge agli spettatori, augurandosi di poter lasciare qualcosa: una sensazione, forse una luce accesa a intermittenza, non una certezza, ma una speranza, un bagliore inatteso di resistenza. Il tempo dell’esistenza si protrae, si assiste ad una dilatazione improvvisa – anche il film sembra non avere più una durata -, la vita si estende nella morte e la coscienza della fine ne restituisce il senso.
Relativizzare il presente per riattivare i sensi: vivere e rivivere ogni giorno Il primo giorno della propria vita
Il primo giorno della mia vita rappresenta anche il primo tentativo di un nuovo modo di fare cinema: si tratta di un rinnovamento interno al suo creatore, che offre, con questo piccolo capolavoro di scrittura, una visione filmica essenziale, senza alcun effetto speciale, in comunione profonda con il sentire collettivo.
Il regista romano (classe’66) sembra aver raggiunto il punto di sintesi – e ovviamente si spera non di approdo – del suo percorso cinematografico. Ci troviamo di fronte a un autore perennemente in itinere, in un processo trasformativo perpetuo e instancabile.
Paolo Genovese inverte il senso di marcia della sua filosofia, già nel 2014, anno in cui esce Tutta colpa di Freud: “romanzo di formazione” di tre figlie, cresciute da un papà psicanalista, ma non per questo privo di insicurezze. Il cinema diventa ricerca del proprio IO, sforzo per farsi spazio nel mondo, per cercare il proprio posto, per avere qualcuno accanto da poter amare.
Comicità e malinconia si intersecano fino a fondersi definitivamente, per dare forma a un linguaggio inedito, ma comunque degno discendente della tradizione italiana.
Con Perfetti sconosciuti (2016) e The Place (2017), la filmografia di Genovese acquista un suo riconoscibile carattere, una sua identità: ne viene fuori una sensibilità sottile, la fragilità come punto di partenza per iniziare la stesura di una sceneggiatura. La collettività è l’oggetto di indagine, che sia a condurla un analista, un ignoto signore che realizza desideri, o una persona qualunque, questo non conta. Empatia è la parola chiave, lo strumento necessario per avventurarsi nel quotidiano.
Dopo esserci smarriti nel giardino di Psiche, ed essere rimasti seduti per ore a un tavolo, a casa di amici, che pensavamo di conoscere come le nostre tasche, ne Il primo giorno della mia vita abbiamo la percezione di morire, – almeno durante le due ore intere della proiezione – per, infine, scegliere di riproiettarci nelle nostre vite con una nuova prospettiva.
L’ispirazione per la realizzazione del film nasce da The bridge – Il ponte dei suicidi (2006). Il documentario è una testimonianza drammaticamente lucida di 24 suicidi, avvenuti a San Francisco, precisamente dal Golden Gate Bridge. «La maggior parte dei sopravvissuti» – spiega Paolo Genovese in un’intervista per la stampa – «durante i sette secondi del volo, si sono pentiti. Per un gesto così estremo esiste, dunque, una possibilità di pentimento».
Protagonista de Il primo giorno della mia vita non è, però, la non-vita, la possibilità mancata dell’esistenza, ma la vita con il suo canto di sirene ammaliatrici, la scommessa non ancora fatta, la proposta di un’esperienza immensa ed autentica, che finora non si ha avuto ancora l’occasione di accogliere, perché nascosta, per nulla facile da scorgere.
Se ci si lascia trasportare dalla reale intenzione della pellicola, quest’ultima assume le sembianze di un tappeto volante che ci consente di “planare sulle cose dall’alto” e scovarne il senso profondo, ma, al contempo, banale e stupido, perché in grado di stupire.
Lo spettacolo visivo, lungi dal rassicurare, non fa altro che comprimere qualcosa dentro di noi, nutrire il malessere e l’insoddisfazione, fino a farli esplodere in un atto di ribellione nei confronti del nostro andare, del nostro stare, che da sempre viviamo come un’opportunità gratuita, che nessuno ha mai chiesto, o come un obbligo, o un compito da svolgere per soddisfare gli altri.
I quattro personaggi, interpreti principali del dramma (Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini), vengono letteralmente ripescati da un Uomo (Toni Servillo), che è in grado di comparire e intervenire in quel frangente di tempo (costituito dai sette secondi prima della fine), in cui l’istinto prende il sopravvento.
L’istinto: questo mistero inesplicabile, che si pone al di sopra delle emozioni, delle sensazioni, che ha forse qualcosa a che vedere con l’inconscio, ma che non si presenta mai con lo stesso volto, assimilabile a un attimo di follia, oppure all’istante immediatamente precedente all’atto sconsiderato. Chi è questo Signor Istinto? Ci può fare del male o del bene? Quanto influisce nelle nostre scelte?
Il primo giorno della mia vita corrisponde al primo momento in cui si riesce a far funzionare l’istinto in una direzione costruttiva e vivificante. Già a una prima visione, ci si rende conto che il film non ti spinge a prendere una posizione, ma, probabilmente, con più sincerità, dimostra che tra vivere o morire non c’è molta differenza.
L’importante è essere dentro se stessi, dimorarsi, abitando il proprio corpo, ascoltarsi, prendendo coscienza di quale sia il proprio ruolo, anche se quest’ultimo implica concentrarsi sulle vite degli altri: innescare la spinta vitale potrebbe equivalere a stare al mondo per la prima volta, o a starci di nuovo, in forme innovative di salvezza.
Sopravvivere è una scelta consapevole per alcuni, per altri è un riscoprirsi, un accettarsi esseri antropomorfi, ma con un cuore enorme, sproporzionato, incontenibile, e non contenuto nello spazio circoscritto della Terra.
I protagonisti non sono Supereroi, non sono né angeli, né demoni, sono umani deboli e forti, matti e sani, ingordi e golosi, ma pure gelosi del proprio realizzarsi, vittime e complici dell’affermazione di sé. Alcuni sono colpiti da dolori naturali, dalla cattiva sorte, dalla malattia, dal lutto, dalla competizione, altri sono caduti in un vortice di male inspiegabile, di sofferenza che non ha un nome, che non è categorizzabile, e che, in quanto tale, uccide silenziosamente il desiderio.
Ai quattro vengono concessi, dall’Uomo, sette giorni, solo sette, come i secondi prima dell’atterraggio, per cambiare sguardo, imparare a ridere di sé, e della tragedia che incombe su di loro. Così cominciano a sostenersi l’un l’altro, ad aggrapparsi, – come sognatori, non utopisti, ma visionari del reale – al Signor Futuro, che, da sempre, cammina a braccetto con il coraggioso Istinto. I cineasti sono una testimonianza vivente di questa scelta sognante.
Se è vero che nulla è definitivo, che ogni cosa nella vita è reversibile, che “dal letame nascono i fiori”, allora è necessario soltanto imparare a relativizzare.
Quindi, in quel fatale istante, occorre guardarsi indietro, anche solo per una frazione di secondo, e magari accorgersi che, alle nostre spalle, si nasconde la persona che amiamo o che ci è simile, e può comprenderci, e può accompagnarci in questo viaggio. La vita è un’avventura triste, e tremendamente tragica, ma incantevole, per le stesse ragioni che non svela o che non ci è dato conoscere.
La felicità risiede nella nostalgia o nel sogno? Teniamo gli occhi chiusi quando stiamo per buttarci e abbiamo paura di perdere qualcosa (e già ci manca), e quando esprimiamo un desiderio e non vediamo l’ora di ottenerla, invece, quella cosa. In fondo, abbiamo la stessa reazione, sia al punto massimo di piacere, sia prima di precipitare.
Siamo esseri strani noi umani, e ogni giorno per noi è come il primo, perché ci svegliamo con l’impressione di non sapere niente, ma mai smettiamo di credere nel domani.