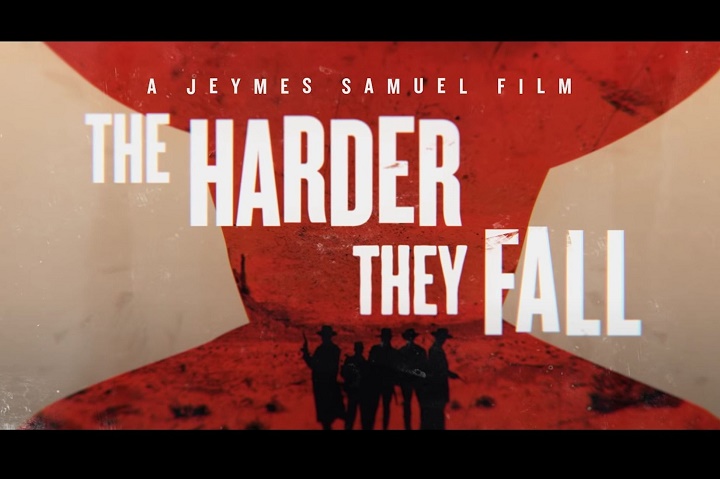L’inganno, la nuova serie prodotta Cattleya
La nuova miniserie L’inganno, diretta da Pappi Corsicato e scritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Ciampelli, Flaminia Grassi e Michela Straniero, è stato il brillante adattamento italiano della serie britannica Gold Digger, debuttando su Netflix il 9 ottobre 2024. Prodotta da Cattleya, troviamo al centro della storia Monica Guerritore nei panni di Gabriella, una donna di sessant’anni elegante e indipendente che gestisce un lussuoso hotel sulla Costiera Amalfitana. Dopo il divorzio e una vita tranquilla accanto al figlio minore Nico, l’apparente serenità di Gabriella viene stravolta dall’incontro con Elia, un giovane affascinante e dal passato oscuro (interpretato da Giacomo Gianniotti). La loro attrazione irresistibile risveglia in Gabriella una passione travolgente, portandola a mettere in discussione tutto: dalle sue relazioni familiari agli equilibri che aveva faticosamente costruito. Questo nuovo amore, tanto travolgente quanto destabilizzante, farà emergere tensioni profonde e conflitti che minacciano di sconvolgere la sua vita.
L’inganno del motivo dello straniero: dalla letteratura al cinema
Nella serie L’Inganno, emerge con forza la figura dello straniero, un archetipo centrale nelle arti, simbolo di verità nascoste, destabilizzazione e rottura degli equilibri. Lo straniero, con la sua presenza, spinge i protagonisti a riflettere su sé stessi e sul mondo che li circonda. In un’epoca segnata da migrazioni globali, crisi identitarie e un crescente senso di smarrimento, questa figura è tornata a dominare le narrazioni contemporanee, incarnando non solo l’alterità, ma anche le inquietudini interiori dei personaggi. Piattaforme come Netflix hanno colto il potenziale di questo tema, trasformando lo straniero in un simbolo delle ansie e dei conflitti del nostro tempo. L’Inganno segue questa tradizione, presentando lo straniero non più soltanto come un “diverso” in senso culturale o fisico, ma come la manifestazione dell’alienazione e della rottura degli schemi sociali. Nella serie, l’arrivo misterioso di Elia destabilizza la serenità di un ambiente apparentemente tranquillo, portando alla luce ipocrisie e ferite nascoste all’interno della famiglia di Gabriella. Solo dopo l’incontro con Elia, Gabriella si accorge delle crepe profonde che per anni erano rimaste sepolte, rivelando come l’esperienza con l’”altro” possa innescare un processo di guarigione e autoconsapevolezza. Questo espediente narrativo ha radici profonde nella letteratura.
Un esempio pertinente a questo discorso è Teorema di Pier Paolo Pasolini (1968), dove lo straniero assume una dimensione quasi trascendentale. Nel film, un giovane enigmatico irrompe nella vita di una famiglia borghese, smantellando le loro certezze e dinamiche. La sua presenza silenziosa e pacata induce ogni membro della famiglia a confrontarsi con i propri desideri repressi, debolezze e angosce, svelando verità nascoste. Come accade in L’Inganno, lo straniero diventa il catalizzatore del caos e del cambiamento. Tuttavia, mentre nel film di Pasolini lo straniero scompare, lasciando i protagonisti in uno stato di disorientamento e catarsi, in L’Inganno Elia si integra nella famiglia, assumendo un ruolo più permanente. Un’ altro esempio letterario più vicino alla nostra contemporaneità di questo archetipo è il romanzo Voci fuori campo di Ali Smith (2005). Smith esplora l’alienazione e l’alterità non solo attraverso la figura del “migrante”, ma anche di chi non si riconosce nei rigidi schemi della società moderna. Lo straniero diventa una voce che cerca di emergere in un mondo che spesso ignora o soffoca le differenze. In uno stile frammentato e poetico, Smith rappresenta lo straniero come un simbolo non solo di diversità culturale o razziale, ma di una dislocazione personale e spirituale. La protagonista, smarrita, trova nello straniero uno specchio della propria condizione, confermando come l’alterità possa essere uno strumento potente di riflessione e trasformazione interiore.
Come nella letteratura, anche nel cinema contemporaneo possiamo trovare altre figure simili di stranieri destabilizzanti. Nel film Knock Knock (2015), diretto da Eli Roth, due giovani donne entrano nella vita di Evan (interpretato da Keanu Reeves), minando la sua stabilità familiare e mettendo in discussione il suo ruolo di marito e padre. In questo caso, lo straniero non solo sconvolge l’ordine sociale, ma rivela la vulnerabilità e l’ipocrisia che si celano dietro le apparenze, proprio come fa Elia in L’Inganno. La sua presenza costringe i protagonisti a rivedere le loro certezze e a fare i conti con i propri lati oscuri. Un altro esempio recente è un film uscito recentemente su Netflix, Leave the World Behind (2023), diretto da Sam Esmail. In questa storia, una famiglia benestante si ritrova a fronteggiare una crisi globale quando in questo caso non troviamo lo straniero ma “gli stranieri”, vale a dire una coppia sconosciuta che bussa alla loro porta durante un blackout. Anche qui lo straniero, con la sua misteriosa comparsa, destabilizza la famiglia, portando alla luce le loro paure più profonde. Come in L’Inganno, la tensione generata dalla presenza dell’altro svela le fragilità dei protagonisti, facendoli confrontare con le loro ansie più nascoste. Questa figura dello straniero, tuttavia, non si limita a film o serie.
Fonte immagine in evidenza: Cattleya