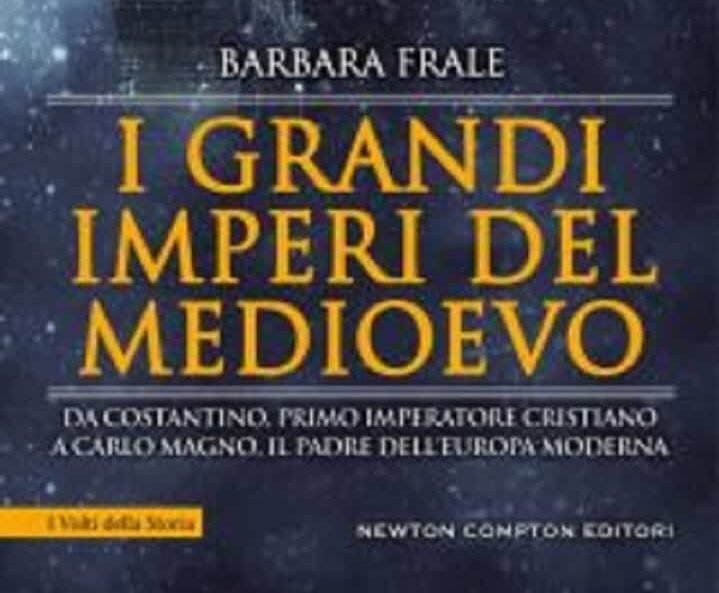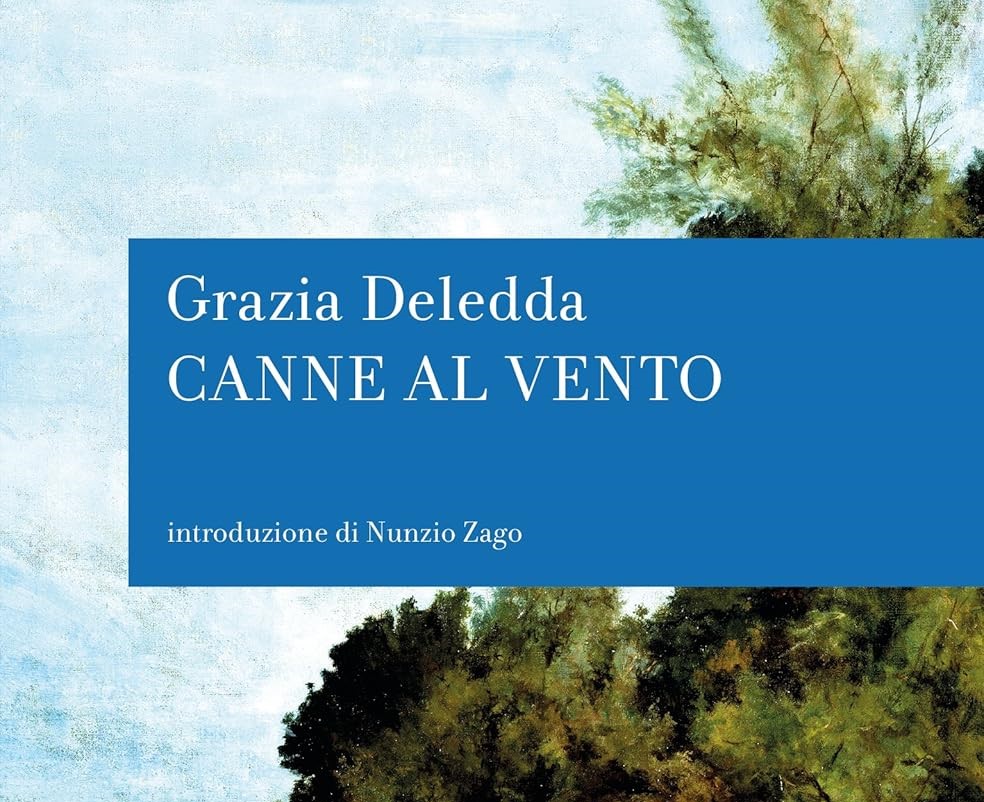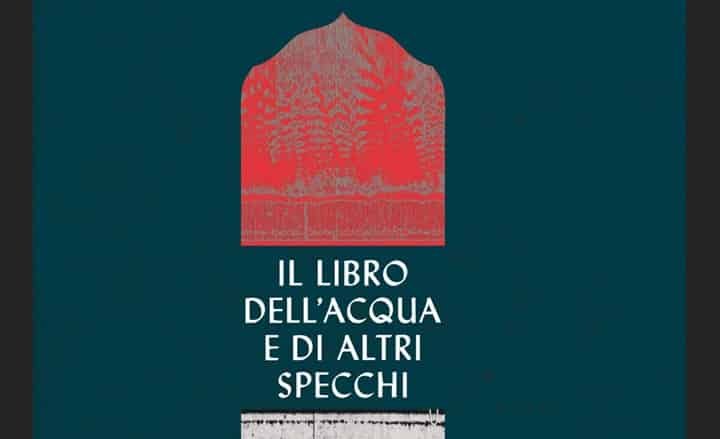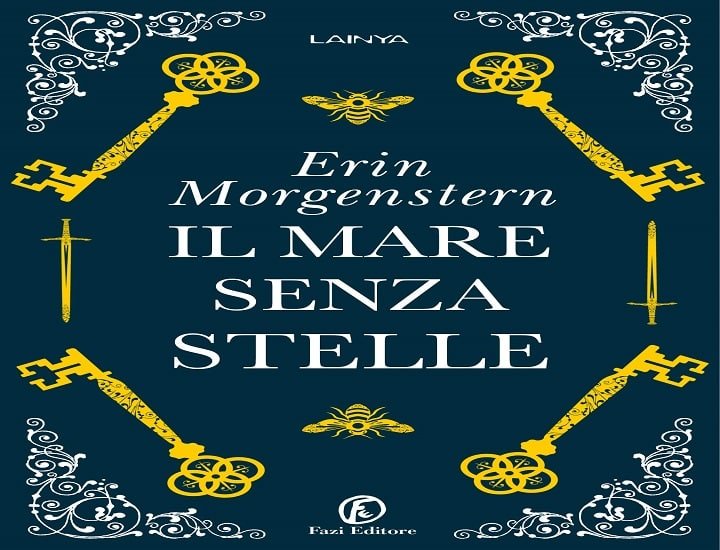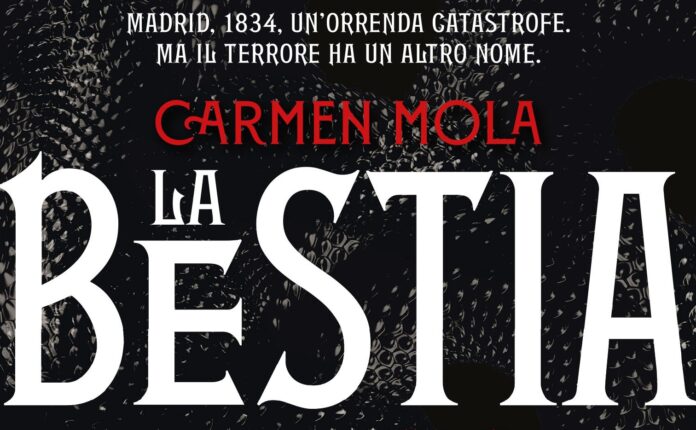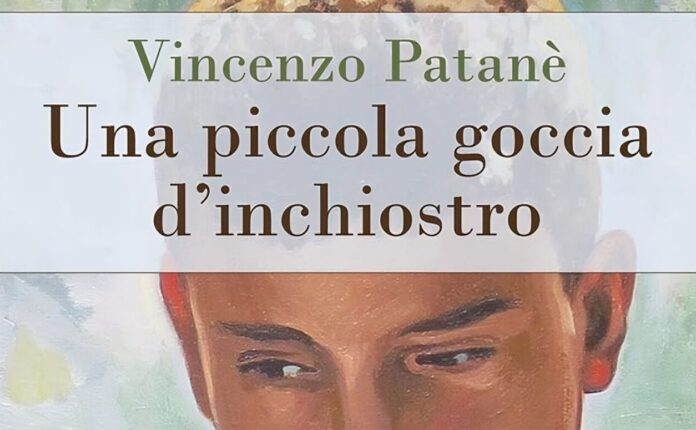Atonement (Espiazione) è un romanzo dello scrittore inglese Ian McEwan, pubblicato nel 2001 e da cui è stata realizzata una trasposizione cinematografica, diretta da Joe Wright. I concetti chiave, a frutto di un’analisi di Atonement, sono quelli di intertestualità e ucronia sui quali si regge l’intera vicenda.
Nell’estate del 1935, la tredicenne Briony Tallis, tradita dall’innocenza della sua giovane età e suggestionata dalla letteratura ottocentesca, interpreta erroneamente ciò che crede di aver visto, condannando la vita di un innocente e anche la sua. Trascorrerà tutta la sua vita cercando di rimediare ad un errore di gioventù, spingendosi fino ad un disperato tentativo di rielaborazione della realtà, mostrando così al lettore il potere salvifico della letteratura.
Intertestualità: il mondo interconnesso della letteratura
Volendo fare un’analisi di Atonement, uno dei concetti principali presenti nel romanzo è l’intertestualità, ovvero, l’abitudine di porre in connessione un testo con un altro testo, oppure di costruire delle narrazioni attraverso chiari riferimenti ad altri testi. Poiché a partire dal postmodernismo le singole opere non sono creazioni isolate, l’intertestualità è una delle tecniche ricorrenti, per cui l’autore è libero di giocare a costruire testi fatti di altri testi o testi che ne omaggiano o parodiano altri ancora.
L’intertestualità in Atonement la si può notare dalla presenza di svariati riferimenti alla letteratura inglese. Ciò è evidente a partire dall’ambientazione: siamo negli anni ‘30 anni, in una casa di proprietà nella campagna inglese. Il dipingere questa casa come un po’ tetra è un’eco intertestuale, perché in qualche modo è come se l’autore citasse L’amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence, dove spesso viene sottolineato l‘aspetto tetro.
Altro esempio di intertestualità, proseguendo nell’analisi di Atonement, è la suggestione di Briony. Questo personaggio legge la realtà con la fervida immaginazione di un’adolescente alimentata dalla letteratura ottocentesca e che quindi vive in un mondo di fantasia di romanzi d’appendice: fughe, malattie, persone che perdono gli affetti più cari, eroine perseguitate da cattivi seduttori. Questo è il suo universo e con questo tipo di bagaglio immaginativo lei interpreta la realtà, distorcendola inevitabilmente. L’approccio distorto della realtà di Briony ricorda la protagonista de L’abbazia di Northanger di Jane Austen, la quale è appassionata di letteratura gotica e risulta suggestionata da questa al punto da travisare gli eventi e le circostanze in cui si trova coinvolta.
Facendo un’analisi di Atonement dal punto di vista strutturale, il romanzo, che si presenta in tre parti, è un chiaro omaggio ad un’altra grande scrittrice inglese, Virginia Woolf e più precisamente al romanzo Gita al faro. In ambedue le opere, il secondo capitolo segna uno spartiacque nella visione del mondo e delle cose, poiché vi è il tempo della guerra ad occupare la narrazione.
L’ucronia e la manipolazione della realtà
La parola ucronia deriva dal greco οὐ «non» e χρόνος «tempo» e significa appunto “nessun tempo”. Indica pertanto uno stato sospeso delle cose in rapporto alla realtà, poiché consiste nella sostituzione di eventi immaginari ai fatti accaduti. L’ucronia non rappresenta un modello positivo o negativo, fornisce semplicemente una realtà alternativa.
Da un’analisi di Atonement, più precisamente dell’ epilogo, si scopre che in esso è contenuta la rivelazione, ovvero, il personaggio di Briony ha scritto il romanzo. La storia però è andata diversamente rispetto ai fatti narrati: sua sorella Cecilia era morta durante un bombardamento e Robbie sulla spiaggia di Dunkerque. Il lettore scopre così di non aver letto la vera storia, ma la versione con un lieto fine che Briony aveva scritto per espiare la colpa di aver costretto i due ragazzi a separarsi e successivamente alla morte.
Ecco così che la letteratura si fa redenzione: l’alterazione della realtà, che trova spazio in un possibile universo narrativo, diventa l’ultimo e disperato tentativo di espiazione.
Analisi di Atonement: il punto di vista dell’autore
Per McEwan la letteratura non può essere solo un gioco intellettuale, sperimentazione, ma deve anche mettere in moto dei meccanismi emotivi. Infatti, da un’attenta analisi di Atonement vediamo che la versione della storia, ovvero quella di Briony, permette di entrare in sintonia con i personaggi anche se ad un certo punto ci si interroga su cosa si stia leggendo, finendo nel gioco intellettuale della riflessione sui piani della realtà.
Fonte immagine in evidenza: Freepik