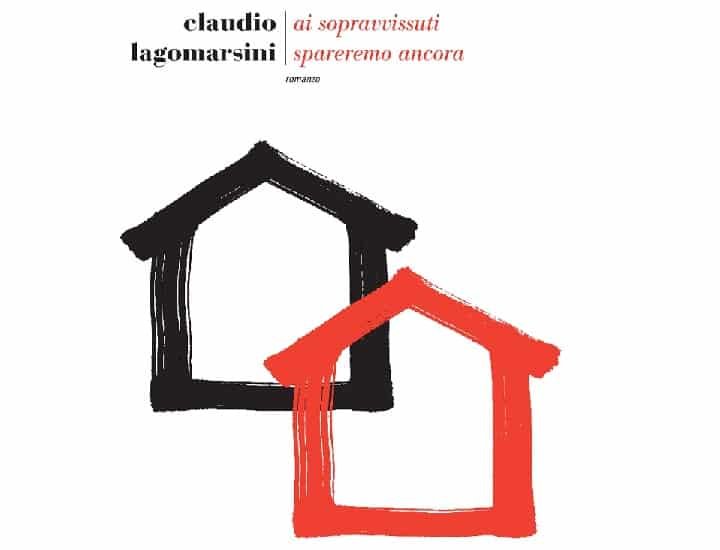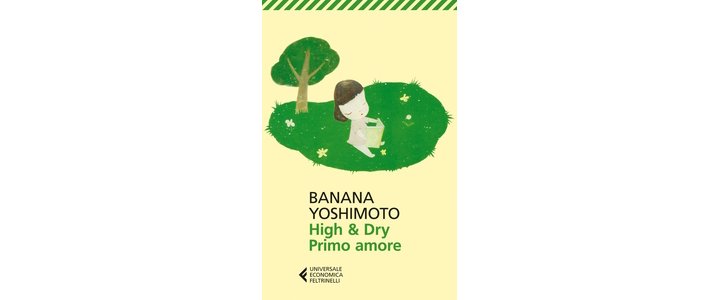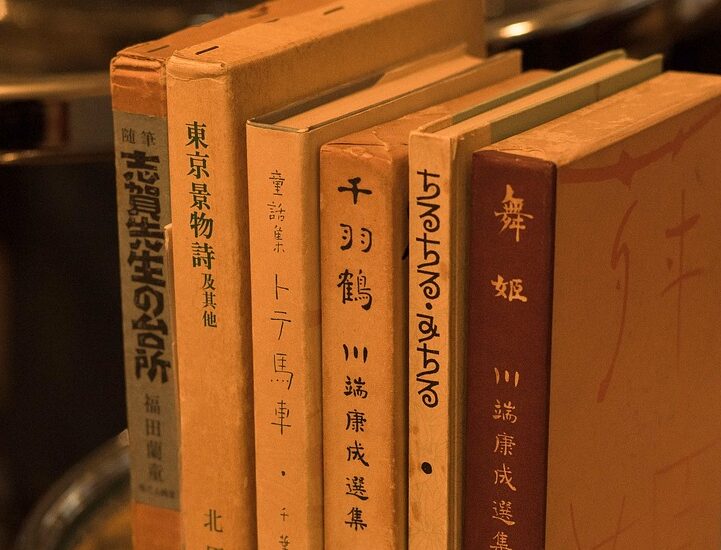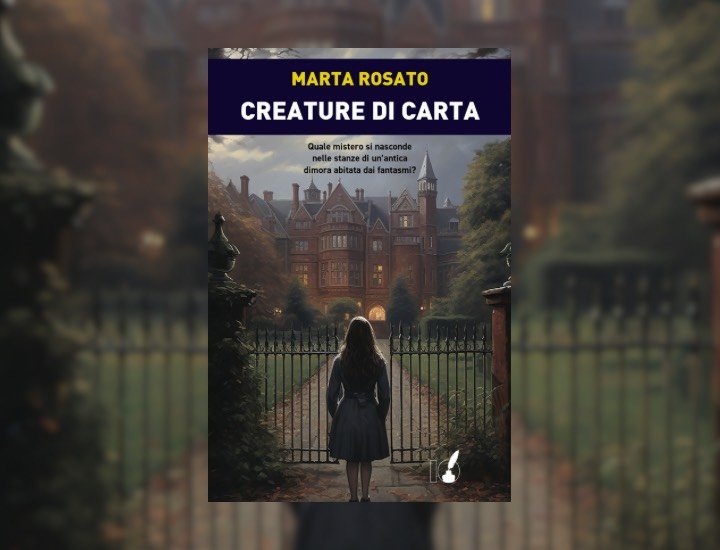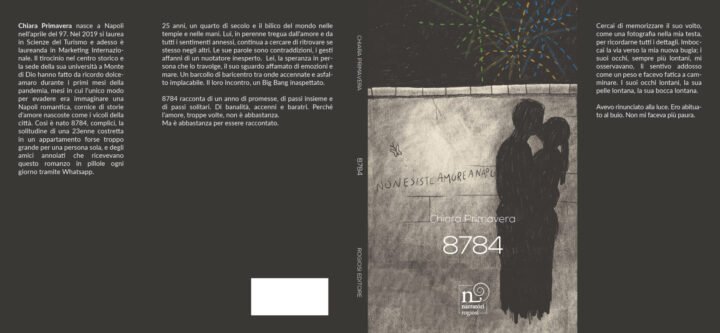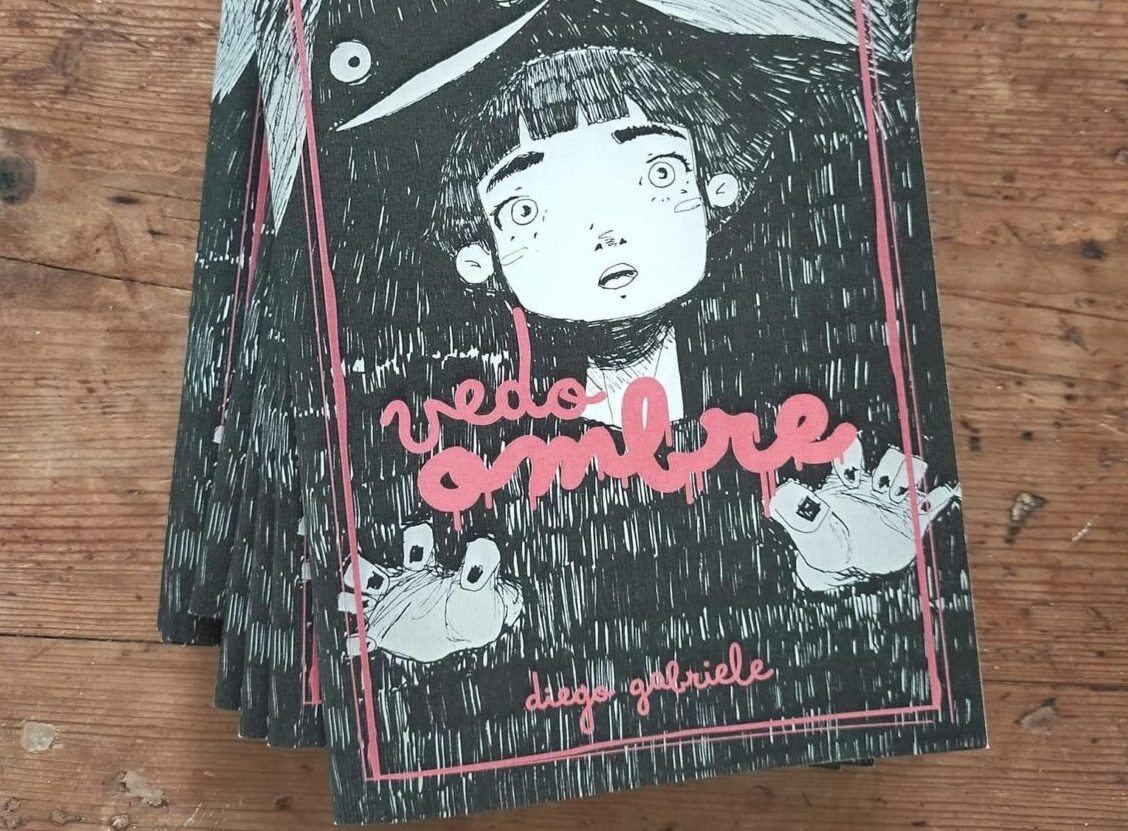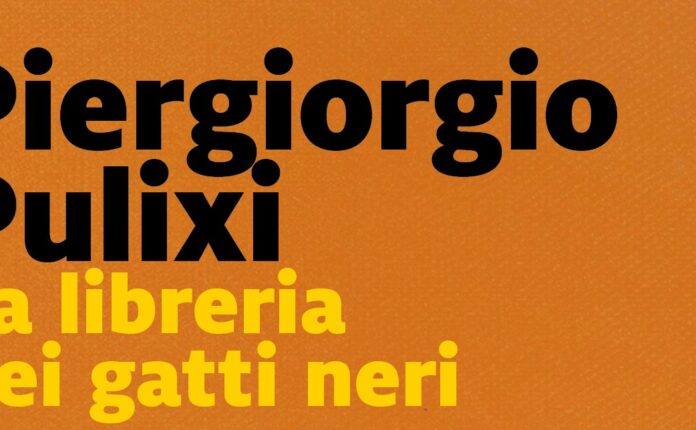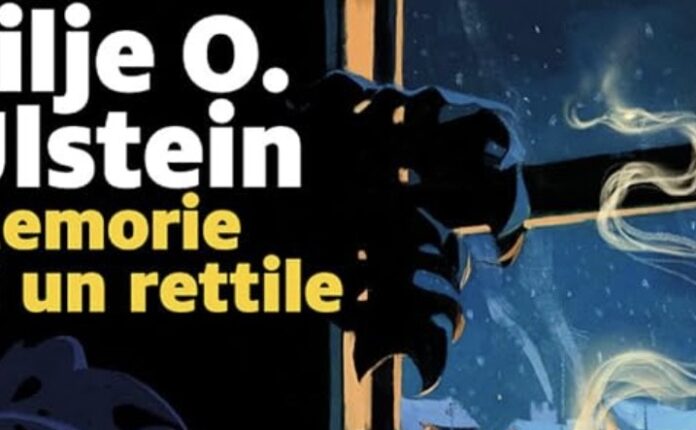La letteratura comparata si occupa di studiare i rapporti letterari intercorrenti nelle differenti lingue. Diversi intellettuali hanno cercato di limitare i suoi “confini”, seppur di tali confini geografici fisici non ve ne sia alcuna traccia. Il primo intellettuale che cercò di darne un effettivo identikit fu Goethe, che nel 1827 ne formulò un primo concetto. Esattamente fu nel 1820 che l’intellettuale, parlando al suo segretario Ekermann, asserì: «non siamo più nell’epoca delle letterature nazionali, questa è l’epoca della letteratura mondiale».
Il grande intellettuale tedesco aveva compreso in anticipo la direzione verso cui dirigere la storia, ossia verso un’epoca di intenso contatto (per via della circolazione delle idee, dei concetti e delle merci) tra luoghi e popolazioni site in svariate parti del globo.
Per Goethe ogni cultura deve sempre estrapolare il meglio dalle altre. Tuttavia vi è da aggiungere che Goethe si contraddicesse molto nei fatti: egli conferiva alla sua nazione (la Germania) una netta superiorità culturale e intellettuale, per cui ad essa veniva concesso un vero e proprio status di massimo predominio (e di privilegio) rispetto alle altre culture e letterature globali.
Per letteratura mondiale si intende il complesso delle letterature nate in tutte le lingue del mondo che, con la lingua stessa, raggruppano l’insieme delle diverse culture, religioni, habitat ed ideologie, le quali sono vere e proprie espressioni visive dello spirito di un popolo. Successivamente a Goethe, il concetto è stato rielaborato incessantemente.
Ad esempio, l’intellettuale palestinese Said, docente per molti decenni alla Columbia University di NYC, ha parlato di ‘worldlines’ per esprimere la sua idea di letteratura mondiale. Said ritiene che la letteratura si alimenta dal proprio contesto locale; tuttavia, risiede nel suo DNA quel “potersi mettere in viaggio”, ossia di non essere prigioniero e schiavo del contesto, ed è “mondiale” proprio perché può parlare a tutto il mondo.
David Damrosch, un altro tra i più grandi esponenti della letteratura mondiale, ritiene che un testo entri a far parte della letteratura mondiale quando riesce a scivolare via dal suo contesto di provenienza (ovvero, dal contesto linguistico-culturale di appartenenza), e per far sì che ciò accada, deve essere necessariamente tradotto. Inoltre, tale studioso sostiene che la letteratura sia:
• secolare, cioè che dura e vive nei secoli, ed è universale, perché non è per pochi eletti, ma coinvolge tutti;
• molto mondana, ovvero, che riguarda il mondo e l’universo tutto.
Tra il finire del XIX secolo e la prima metà del XX, c’è lo sviluppo di tre ideologie diverse sul concetto di letteratura mondiale.
La prima è strettamente legata alla definizione di letteratura mondiale di Cheng Jitong: venne dichiarato in merito alla letteratura cinese che questa per migliorare sarebbe dovuta uscire dai confini nazionali ed entrare in contatto diretto con il resto del mondo e approcciarsi alla letteratura mondiale.
La seconda ideologia è correlata a Tagore, intellettuale Bengalese. Lo studioso, che viveva in un’epoca in cui in Bengala era ancora ben radicata la forte presenza coloniale britannica, parla di letteratura mondiale utilizzando il termine Vishwa Sahitya per riferirsi alla necessità di promuovere una maggiore umanità e tolleranza tra i diversi popoli. In tal senso, letteratura mondiale acquista il significato di umanità, ossia è puro sentimento di solidarietà tra gli uomini. La letteratura mondiale per Tagore doveva promuovere una visione pacifista dei contatti tra diversi popoli e culture, visione quest’ultima che traspare in un saggio del 1952 di Erich Auerbach sulla letteratura mondiale.
La terza ideologia fu espressa proprio da Auerbach (intellettuale tedesco e uno dei fondatori delle letterature comparate così come le conosciamo oggi) che ha tuttavia un pensiero molto simile a quello di Tagore. Dal momento in cui Auerbach aveva vissuto la seconda guerra mondiale, e stava assistendo all’inizio della guerra fredda, egli riutilizza il concetto di letteratura mondiale in chiave pacifista. La letteratura doveva pertanto essere un modo di trovare un contatto tra i popoli, a prescindere dalle nuove divisioni che sarebbero sorte.
Massimo Fusillo — grande comparatista dei giorni nostri — fa una sorta di distinzione tra il periodo fino ad Auerbach e il periodo successivo, e distingue questi due periodi anche rispetto al modo in cui si concepisce la letteratura mondiale. Fino alla prima metà del ‘900 c’era una fiducia in chiave umanistica dell’idea unitaria della letteratura, che è anche più connessa al cercare uno spirito comune, andando così ben oltre ogni differenza. Dalla seconda metà del ‘900, ovvero con la fine della Seconda Guerra mondiale e con la decolonizzazione (periodo post coloniale) si perde il senso di comunità, che abbiamo visto essere molto forte ai primi anni del ‘900. In sostanza, è in questo periodo che si è più propensi all’indipendenza nazionale, e di conseguenza i discorsi sulla letteratura mondiale diventano maggiormente conflittuali.
Anche altri studiosi negli ultimi trent’anni hanno scritto di letteratura mondiale. Tra i molti ricordiamo Pascale Casanova, facoltosa studiosa francese francofona che ha pubblicato nel 1999 La Repubblica Mondiale delle Lettere. Nel suo studio la studiosa afferma che la letteratura è una repubblica — alias una res repubblica — ovvero, una “cosa” che non è limitata solo a una parte del mondo ma al mondo stesso.
Immagine: Wikipedia