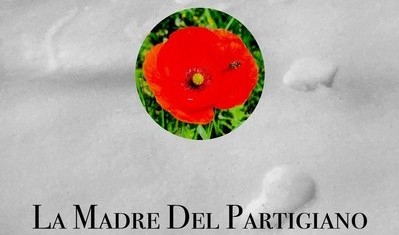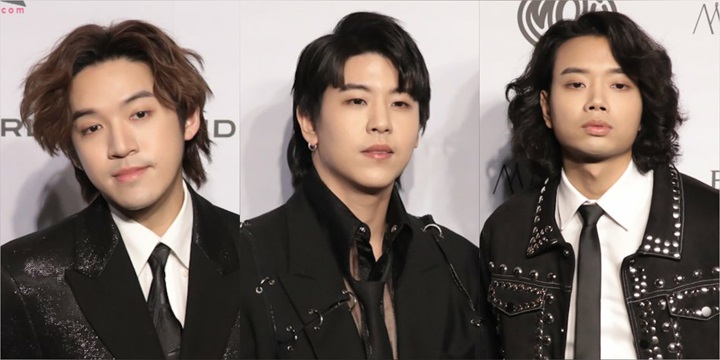Rocco Rosignoli in questa intervista presenta “La madre del partigiano”, brano tratto dalla poesia di Gianni Rodari, in uscita il 5 Luglio 2025. I versi, accompagnati dalla sola chitarra e da un graziosissimo video, sono una celebrazione al sacrificio dei partigiani durante la Resistenza, ma anche il canto di orgoglio di una madre che, nonostante la perdita del proprio figlio, ne elogia il coraggio e il contributo che ha dato con la sua vita per la libertà; figlio che è diventato poeticamente un fiore rosso, nato dal suo stesso sangue sulla neve, e per il quale la madre chiede a “tu che che passi, non lo strappare”. Come ricorda Rocco Rosignoli in questa intervista per “La madre del partigiano”, la memoria collettiva sta rischiosamente affievolendosi, aiutata da un certo tipo di revisionismo storico che contamina il significato ancestrale di quel sentimento che mosse i partigiani, e non solo, durante la lotta al nazifascismo a donare la loro vita per la liberazione; anche la mancata “risignificazione” negli anni del 25 Aprile sta contribuendo purtroppo a far affievolire il valore di questa celebrazione come patrimonio comune. Ed ecco che i nomi e i luoghi del sacrificio diventano sempre più anonimi, sbiadiscono negli anni insieme con i loro significati e le loro storie, storie di persone comuni, fatte di paure, coraggio e sacrificio. Decidere quindi di ritornare attraverso la musica e la poesia in quei luoghi è un gesto coraggioso e delicato allo stesso tempo: il contributo di Rocco Rosignoli è certamente un omaggio alle persone e alla memoria, carico anche di una nuova consapevolezza, quella dell’essere diventato genitore, che gli ha offerto nuove prospettive, anche rispetto a fatti che già conosceva. Per rendere poi il suo omaggio ancora più significativo, il cantautore ha integrato il brano nella cartellonistica dei sentieri partigiani del Monte Fuso, dove un QR code consente ai visitatori di ascoltarlo direttamente camminando tra i boschi, rendendo quindi l’esperienza ancora più intima e personale. Questa intervista a Rosignoli per “La madre del partigiano” raccoglie quindi il racconto non solo del brano e dei progetti musicali per il futuro, ma anche del suo personale coinvolgimento, artistico e sociale, per offrire un esempio ai suoi figli (e non solo) “di coerenza e non di ruffianeria“.
Ecco come il musicista/cantautore ha risposto alle nostre domande.
“La madre del partigiano” è una poesia di Gianni Rodari dura e dolcissima insieme che hai deciso di musicare durante il lockdown mentre tu e la tua compagna aspettavate un figlio. Questo ha cambiato la tua percezione della poesia? Sapere di stare per diventare genitore te l’ha fatta interiorizzare in una maniera nuova?
Credo di sì. Tutti ti dicono che quando sei genitore la tua emotività cambia, e non è che non ci si creda, ma è impossibile immaginare in che modo. Finché non ti succede: a quel punto ti accorgi che, anche di ciò che già conosci, stai scoprendo dei lati che prima non coglievi. Il legame tra la vita interiore e la storia intorno, in altre parole quel che chiamiamo memoria, è stato sempre al centro del mio lavoro. Avere questa nuova prospettiva per trattarla è una delle tante cose belle che la paternità mi ha regalato – al netto di tutte le notti insonni!
I luoghi della Resistenza e le loro storie, fatte di persone comuni e troppo spesso anonime, sono andate quasi fuori dai riflettori probabilmente a causa di un conto che non si è ancora voluto pagare con la nostra storia. Gli artisti in particolare che trattano questo tipo di tematica sono spesso invitati a rimanere delle figure di intrattenimento e di lasciare la politica al di fuori dall’arte. Senti la responsabilità di esserti mosso in direzione opposta rispetto alle classiche aspettative?
Credo che la prima responsabilità nello svolgere un lavoro di tipo artistico sia verso sé stessi; e solo quando sei certo di essere stato sincero e coerente puoi mettere la tua faccia in ciò che fai. Ho scelto di abitare un mondo in cui la canzone e l’impegno civile vanno di pari passo, e questo comporta delle scelte, a volte impopolari. Ci ho fatto i conti, è un rischio che corro per me stesso e perché i miei figli possano avere dava un esempio di coerenza e non di ruffianeria. C’è chi fa scelte diverse, fin da come imposta il proprio lavoro. Non è meglio né peggio, è un altro lavoro, un lavoro per cui io non sono tagliato.
C’è un obiettivo che speri questa canzone raggiunga?
Questa canzone nasce per essere ascoltata in un luogo di memoria preciso: un cippo povero e dai nomi quasi cancellati, che si trova sotto un tetto di aghi di pino a pochi passi dal centro faunistico del Monte Fuso. Spero che il risultato che può raggiungere sia quello di emozionare chi si trova davanti al sacrificio di questi ragazzi che non sono passati alla storia, ma il cui esempio rimane oggetto di memoria, di una memoria forse non solenne, ma di certo intima e del tutto sincera.
Il Monte Fuso è il luogo dei sentieri partigiani, teatro di rastrellamenti e barbarie. Hai un legame personale con quell’area o è un tuo personale omaggio alla memoria di quei fatti?
Ho un legame personale, ma non di tipo famigliare. Da alcuni anni collaboro in maniera più o meno continua con la compagnia teatrale El Bornisi, che ha radici profonde in quel territorio e nel Museo Storico della Resistenza di Sasso, che conserva la memoria dell’eccidio di luglio. Questo orrore, questa ferita di quel territorio, è stato uno dei primi temi su cui il loro regista Matteo Ferzini mi ha chiesto di collaborare a un loro spettacolo, nel lontano 2019. Da allora non ci siamo mai persi di vista e abbiamo fatto tante cose belle insieme. È stato grazie a Matteo che la mia canzone è stata integrata nella cartellonistica dei Sentieri Partigiani tramite QR code.
Ancora oggi, nel 2025, il 25 Aprile è una celebrazione controversa per una certa fetta di italiani. Credi che il futuro porterà dei cambiamenti rispetto alla lettura della Resistenza oppure, in un certo modo, il dibattito, seppur inquinato, è il mezzo per “tenere in vita” la memoria e gli approfondimenti storici?
Credo, e lo dico con grande amarezza, che con la distanza storica il senso del 25 Aprile sia destinato ad affievolirsi. È una festa che io sento molto, fin dall’infanzia; ma ormai ho 42 anni, il che vuol dire che il mio primo 25 Aprile è più distante da quello appena passato di quanto all’epoca non lo fosse dal 25 Aprile del ‘45. È cambiato tutto, il modo di celebrarlo, lo spirito di scendere per strada; soprattutto è mancata la capacità di risignificarlo perché rimanesse patrimonio comune. Ammettendo che un modo ci fosse. Di certo, la ricerca storica è il sale di ogni possibilità di rivitalizzazione di questa ricorrenza: il dibattito è ciò che mantiene viva la memoria. Il rischio grande ora è che nel discorso pubblico vinca una narrazione diversa, incompatibile con il paese architettato dalla Resistenza e dalla classe politica che da essa uscì. E non è una tendenza solo italiana: in tutto l’occidente le destre revisioniste, post-costituzionali, stanno disegnando i contorni di una nuova forma di gestione della vita pubblica, che gli strumenti del ‘900 fanno fatica ad analizzare nella sua complessità.
C’è qualche altra composizione poetica che, in un futuro, vorresti tradurre in musica?
Tanti anni fa mi diedi la regola di non mettere mai in musica delle poesie: se una cosa nasce per stare su carta, è bene che arrivi al fruitore attraverso la lettura. Da allora questa rigida regola l’ho infranta un sacco di volte senza in seguito pentirmene mai… quindi, credo davvero che accadrà. Al momento sono alle prese con la traduzione e messa in musica di una poesia di Mordechai Gebirtig, il grande cantore yiddish del ghetto di Cracovia. Lui scriveva canzoni, ma il suo primo testo in versi, “Der general shtreyk”, “Lo sciopero generale”, fu pubblicato come poesia. Sono convinto che lui avesse pensato a una melodia per quelle parole, e la mia mira è quella di comporre per esse una musica che possa sembrare scritta da lui, per inglobarla in un florilegio di sue canzoni che ho tradotto con passione e solerzia da due anni a questa parte. Sono già l’ossatura di uno spettacolo di teatro-canzone, e spero che presto possano diventare anche un disco.
In conclusione, questa intervista a Rocco Rosignoli per “La madre del partigiano” è quasi un invito, o meglio un’opportunità, per ritornare a riflettere sul passato storico, ad estrapolarlo da libri, nozioni e fazioni e a guardare a quegli avvenimenti con occhi diversi, magari con gli occhi amorevoli di un genitore o anche di un figlio e cercare di mantenere viva la memoria, proprio come esortava Gianni Rodari nei suoi versi del 1953.
Fonte immagine: Ufficio Stampa