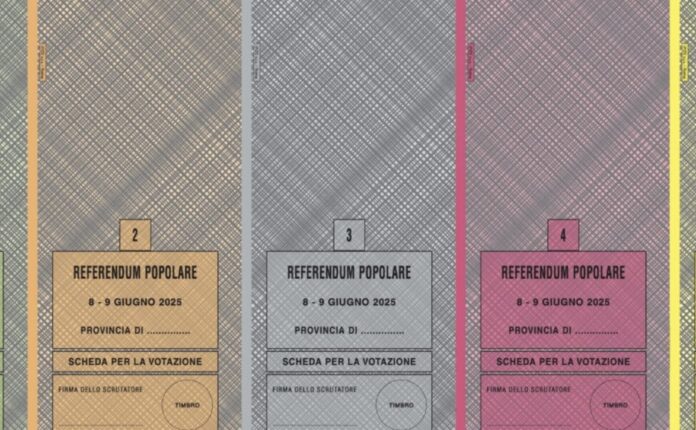«La generazione Z è la meno resiliente che io abbia mai visto»: non è il commento nostalgico di un 50enne che – come ormai è divenuto consueto – affibbia alla informe massa dei “giovani” la colpa di ogni male nel mondo, ma l’osservazione di un 30enne che in quella generazione Z non rientra per soli cinque anni.
Il suo nome è Steven Bartlett e nel Regno Unito è ormai preceduto dalla fama di uomo d’affari tra i più influenti dell’ultimo decennio, con una storia tanto banalmente complessa e un patrimonio stimato così consistente da essersi avviato alla più classica delle parabole moderne, quella da imprenditore enfant prodige a personaggio dello spettacolo. Questo è sufficiente di per sé a garantire a Bartlett – e a tutti gli altri – il diritto più ambito dei nostri tempi: il diritto di dire la sua ad ogni proposito.
Il suo commento sulla generazione Z (1997-2012) risale ad un episodio dello scorso settembre del suo Apple podcast The Diary of a CEO, in cui Bartlett racconta, conversando con altri imprenditori ospiti, che cosa gli ha permesso di passare dalla frustrante condizione di studente fuori corso squattrinato a CEO della agenzia di social media marketing Social Chain, oggi valutata 350 milioni di euro.
La generazione Z o la meno resiliente
Il motivo per cui la generazione post 1997 sarebbe la meno resiliente di tutte risiede in quella che Bartlett ritiene un’etica del lavoro non abbastanza forte e non adatta a gestire un mondo ad alta intensità. Un mondo in cui non c’è spazio per le pretese di tempo libero, orari contrattuali e vita privata, perché «le richieste non si fermano il sabato, la domenica o quando finisce il turno di lavoro».
A sostegno della sua opinione, l’imprenditore ha commentato la giornata di lavoro standard di una dipendente poco più che ventenne: arriva a lavoro, scatta foto al cappuccino e al muffin offerti dall’azienda, le posta su TikTok e poi alterna momenti di lavoro, che racconta al mondo sui social, a corsi di ceramica organizzati per i dipendenti. E in tutto questo, guadagna molti più soldi di quanti ne possa anche soltanto immaginare un impiegato con turni di lavoro massacranti e scadenze impilate sulla scrivania; sempre che riesca ancora a immaginare qualcosa tra un attacco di panico e un accenno di burnout.
«Se penso alla fatica e alle tempeste che mio padre ha affrontato quando lavorava, mi convinco che questa generazione non potrà mai fare fronte a nulla di simile. Probabilmente loro, di fronte alla fatica e ai sacrifici preferirebbero smettere di lavorare o, nella migliore delle ipotesi, criticare il datore di lavoro con lunghi post su LinkedIn», ha aggiunto Bartlett. E così anche lui non si è lasciato sfuggire l’occasione di rispolverare il più antico e nostalgico dei cliché: il confronto con chi è venuto prima, il quale – non importa a quale prezzo o in quale contesto – ha fatto meglio di chi ora è giovane, sempre e comunque. Da che mondo è mondo ritrarre quella masnada fresca e dannata di giovani in modo deforme, deplorevole, colpevole di non si sa che cosa, è una priorità di chi si è adeguato a malincuore ad un sistema che in fondo non condivide. Questa volta, però, la sentenza arriva da un ragazzo che ha ammesso di non essersi impegnato a scuola perché riteneva gran parte delle lezioni superflue e che ha costruito la sua fortuna sul mondo social.
Meno resilienti o più sani?
Non si sono fatte attendere le reazioni dei giovani direttamente chiamati in causa, ma anche di chi ha voluto difendere una generazione che, a conti fatti, sembra essersi fatta carico più di tutti gli altri delle istanze di un mondo malato.
«Non direi che sono poco resilienti, ma che sanno stabilire meglio i limiti tra lavoro e vita privata. Hanno visto i genitori lavorare troppo, senza le opportune ricompense, e non hanno più alcuna intenzione di alimentare questa cultura del lavoro ad alta intensità», ha precisato la scrittrice Toni Tone su Twitter.
«They are switched ON», ha aggiunto il presentatore Richie Brave, confessando di imparare tantissimo dai ventenni ogni giorno, nonostante intorno a loro ci siano più critiche che gratificazioni.
Il focus della questione risiede, probabilmente, nel significato che si attribuisce all’espressione “etica del lavoro”. Per chi è convinto che la propria abnegazione sia una condizione necessaria per fare carriera o che multitasking, gestione dello stress e rapidità siano i must have per il successo, l’etica del lavoro equivale al senso di colpa irrisolvibile e allo stato di ansia generalizzata che il dio della produttività ci ha venduto come promozioni professionali. In quanto tale, il lavoro da strumento di affermazione e libertà si rivela essere il luogo della alienazione più opprimente dell’umano.
Chi, invece, di etica recupera il significato classico ed etimologico di aristotelica memoria, capirà che etico è soprattutto adottare – anche in ambito lavorativo – una postura che implica da un lato l’utilizzo della ragione come massima affermazione dell’essenza dell’uomo e dall’altro la ricerca del giusto mezzo. È in questo senso che l’attitudine al lavoro della generazione Z si rivela essere molto più sana e sensata di chi ha avuto l’unico merito di nascere prima. E in questo senso, la generazione Z ha colto nel segno.
Porre attenzione al benessere psico-fisico dei lavoratori e pretendere che ci si preoccupi della loro salute mentale equivale a porre un’etica nel lavoro; considerare tra gli obiettivi non soltanto le condizioni imposte dal datore di lavoro per mandare avanti la baracca – con benefici e tempistiche che rispettano solo la mission dell’azienda –, ma anche il buon umore e la serenità dei dipendenti significa tentare di risanare quella dicotomia tra lavoro e libertà che provoca dissociazione tra lavoro e umanità.
Come precisa anche il filosofo Francesco Totaro, un lavoro etico è un lavoro che rispetti la vocazione del lavoratore; per vocazione si intende la soddisfazione della naturale propensione di ognuno alla libera azione e contemplazione, due attività che devono essere ugualmente inglobate nel ruolo del lavoratore e non riservate ad un “tempo altro”. Perché questo sia vero, è necessario superare la scissione tra un lavoro inteso in termini meramente strumentali per accumulare ricchezze e il tempo libero in cui consumare le ricchezze accumulate. Questo paradigma comporta la perdita dell’uomo nel lavoratore.
Ri-definiamo “resilienza”
Non è forse questa resilienza? Il Cambridge Dictionary definisce resilienza “the ability of a substance to return to its usual shape after being bent, stretched, or pressed”. I ragazzi e le ragazze che abbiamo di fronte hanno avuto la lucidità di scardinare il tabù della salute mentale e di difenderla a gran voce dopo aver attraversato una selva oscura di crisi pandemica ed economica che, volente o nolente, ha riformulato l’ordine delle priorità; hanno capito come lavorare e guadagnare quando la loro stanza era l’unico posto di lavoro permesso dalla legge, quando le assunzioni erano un miraggio e il tempo, per tutti, si era fatto improduttivo. E la maggior parte di loro lo ha fatto anche nel modo più proficuo, strategico e dignitoso possibile, senza un ufficio, senza risorse, senza nemmeno un datore di lavoro. Chi più di loro ha tentato di riportare la “sostanza umana” alla forma più naturale, dopo che questa era stata piegata, stirata o pressata per decenni?
Pretendere di riappropriarsi del tempo vitale, di ritrovare uno stile di vita migliore e più sostenibile e di ridefinire i fondamenti di una cultura lavorativa tossica non è forse un impegno a tornare all’umano nella sua forma naturale e giusta? E se questo significa anche difendere i propri diritti, rifiutare un lavoro ad alta intensità in cambio di un salario ridotto ai minimi termini e guadagnare di più lavorando in maniera strategica e intelligente (che non vuol dire lavorare meno), non è forse una grande lezione di imprenditoria sana?
Le battaglie del tempo che fu di certo non possono essere le battaglie del mondo di oggi, e senza dubbio creare profitti con i social e lavorare da remoto è un vantaggio. Ma mentre gran parte della popolazione mondiale continuava ad arrancare e a raccontare se stessa, come per decenni ha fatto, attraverso i principi di leadership di aziende, sovraccaricandosi di incarichi senza ricompensa ed esponendosi al rischio di un blackout senza possibilità di salvezza, i “Zs” operavano una rivoluzione economica, sociale, antropologica, o almeno ci provavano. Loro davano a tutti – forse a volte con qualche vena di arroganza e superficialità di troppo, ma, come si dice, so’ ragazzi – una dimostrazione magistrale di pensiero laterale, di equilibrio e, perché no, di resilienza.
E se la loro battaglia avrà successo, forse un giorno toccherà anche ringraziarli.