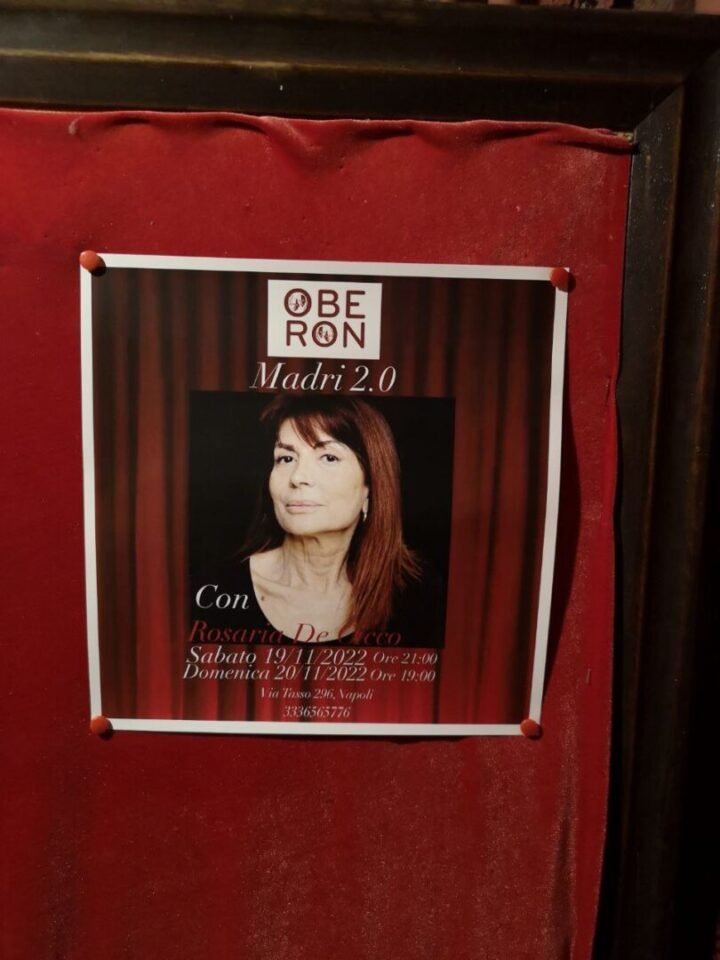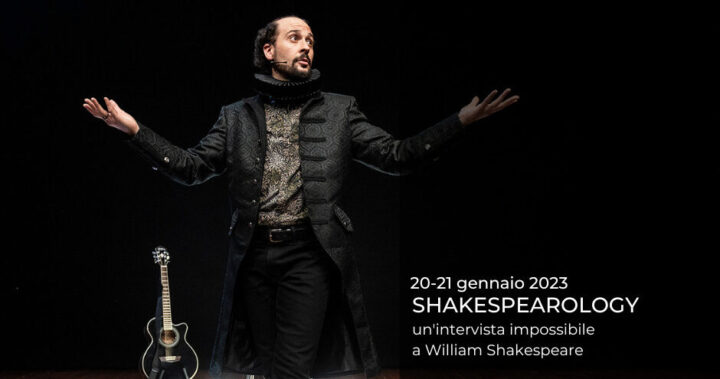Tra la metà del XVI e il XVIII secolo si sviluppò in Italia un innovativo e peculiare modo di fare teatro: la Commedia dell’Arte. Questo genere, caratterizzato dall’uso delle maschere, dall’improvvisazione e dalla presenza di personaggi tipo, rivoluzionò il panorama scenico dell’epoca, diventando popolare in tutta Europa. La Commedia dell’Arte non fu soltanto un nuovo genere, ma rappresentò una vera e propria professione nel modo di produrre e fruire gli spettacoli.
Indice degli argomenti
Le origini: quando e dove nasce la Commedia dell’Arte
La nascita ufficiale della Commedia dell’Arte ha una data e un luogo precisi. Il 25 febbraio 1545, a Padova, otto uomini si presentarono davanti a un notaio per stipulare un contratto con cui si costituivano in una compagnia teatrale professionale. Questi attori, dotati di preparazione culturale, capacità mimiche e acrobatiche, decisero di trasformare la loro arte in un vero e proprio mestiere (da qui il termine “arte”).
L’atto notarile stabiliva che avrebbero acquistato un cavallo per trasportare costumi e attrezzi di scena e che sarebbe stata presente assistenza in caso di incidenti o malattie per tutti i membri. Nacque così la prima compagnia, un evento che segnò l’inizio di un nuovo modo di fare teatro, basato sulla professionalità degli attori e su una struttura organizzativa definita. Per la prima volta, gli attori si univano in una struttura con regole precise e una divisione dei compiti, permettendo di migliorare la qualità degli spettacoli e di diffondere il genere in tutta la penisola e poi in Europa.
Le donne in scena: una rivoluzione sociale
Tra i cambiamenti più significativi introdotti dalla Commedia dell’Arte ci fu l’ingresso delle donne nel mondo della recitazione. In una società ancora fortemente patriarcale, dove i ruoli femminili erano interpretati da uomini, l’arrivo delle attrici rappresentò un evento epocale, non solo per il teatro ma anche per l’emancipazione femminile. Nonostante le critiche e le accuse di immoralità da parte della Chiesa, le compagnie continuarono a includere le donne, riconoscendone il talento. Tra le attrici più celebri spicca Isabella Andreini, che raggiunse una grande fama in Italia e in Europa grazie alle sue straordinarie doti interpretative.
Le caratteristiche fondamentali della Commedia dell’Arte
Gli attori della Commedia dell’Arte non si limitavano a recitare un testo. Erano artisti completi: musicisti, acrobati e mimi, capaci di creare un rapporto diretto con il pubblico. Le loro rappresentazioni si basavano su alcuni elementi distintivi.
- Improvvisazione e canovaccio: gli spettacoli non seguivano un copione rigido. Gli attori partivano da un canovaccio, un riassunto della trama che indicava l’intreccio generale, le scene e i personaggi coinvolti. Le battute e gran parte dell’azione erano lasciate alla loro abilità di improvvisare, basata su un repertorio di battute e situazioni comiche (i “lazzi”) studiato negli anni.
- I tipi fissi: ogni attore si specializzava in un ruolo fisso, una maschera che avrebbe interpretato per tutta la carriera. Questo permetteva di approfondire al massimo le caratteristiche del personaggio, arricchendolo con sfumature personali.
- Le maschere: l’uso della maschera (solitamente di cuoio) era un elemento centrale. Coprendo parte del volto, obbligava l’attore a enfatizzare la gestualità e l’uso del corpo, creando personaggi fortemente riconoscibili.
- Il plurilinguismo: ogni maschera si esprimeva nel proprio dialetto (veneziano per Pantalone, bolognese per il Dottore, bergamasco per gli Zanni), creando un divertente mix linguistico che abbatteva le barriere con un pubblico proveniente da diverse regioni.
Le maschere: i tipi fissi e i loro ruoli
Le maschere della Commedia dell’Arte rappresentavano stereotipi sociali, vizi e virtù della società dell’epoca. Si dividevano principalmente in quattro categorie.
| Categoria | Maschere principali e ruolo |
|---|---|
| I Vecchi | Pantalone (mercante avaro), Il Dottore (o Balanzone, sapiente saccente). Ostacolano i giovani. |
| Gli Zanni (Servi) | Arlecchino (servo sciocco e agile), Brighella (servo astuto e intrigante), Colombina (servetta sveglia). Muovono la trama con inganni e astuzie. |
| Gli Innamorati | Leandro, Isabella, Lelio, Florindo. Giovani e belli, parlano un italiano colto e recitano senza maschera. Il loro amore è il motore della storia. |
| I Capitani | Capitan Spaventa, Capitan Matamoros. Soldati spacconi e vanagloriosi, ma in realtà codardi. Spesso rivali degli innamorati. |
I Vecchi: Pantalone e il Dottore
Queste maschere rappresentano l’autorità e il potere economico, spesso messi in ridicolo. Tra le più famose c’erano Pantalone, un mercante veneziano avaro e lussurioso, e il Dottore (o Balanzone), un pedante e borioso dottore in legge bolognese che infarciva i suoi discorsi di citazioni latine storpiate.
Gli Zanni: Arlecchino, Brighella e Colombina
Gli Zanni sono i servi, veri motori dell’azione comica. Arlecchino e Brighella erano due servi bergamaschi: il primo sciocco, ingenuo e acrobatico, sempre affamato; il secondo astuto, intrigante e spesso malizioso. Colombina era invece una servetta intelligente e vivace, spesso complice degli innamorati e unico personaggio femminile a indossare talvolta una mezza maschera (il più delle volte recitava a volto scoperto).

Gli Innamorati e i Capitani
Gli Innamorati erano giovani, belli e raffinati, protagonisti di storie d’amore contrastate dai “vecchi”. A differenza delle altre maschere, recitavano senza maschera per mostrare la loro espressività e parlavano un italiano colto. I Capitani erano invece soldati spacconi e codardi, spesso rivali in amore degli innamorati e da loro sbeffeggiati.
La riforma di Goldoni e l’eredità della Commedia dell’Arte
Nel Settecento, la Commedia dell’Arte iniziò a mostrare segni di stanchezza, cadendo spesso in una volgarità ripetitiva. Fu allora che intervenne Carlo Goldoni. Pur apprezzando la vitalità del genere, ne superò gradualmente gli schemi. Goldoni eliminò l’improvvisazione a favore di un copione interamente scritto, sostituì le maschere e i tipi fissi con personaggi dotati di una psicologia più complessa e realistica, dando vita alla moderna commedia di carattere.
L’influenza della Commedia dell’Arte, però, non si esaurì. Le sue tecniche, i suoi personaggi e la sua enfasi sul corpo dell’attore hanno influenzato grandi autori come Molière e continuano a vivere nel teatro contemporaneo, nel circo e nella clownerie. In molte città italiane, inoltre, nacquero maschere regionali che sono diventate simboli del Carnevale, come Pulcinella a Napoli, Gianduia a Torino e Stenterello a Firenze.
Fonte immagine: Pixabay